NOTE DEL TRASCRITTORE:
—Corretti gli ovvii errori tipografici e di punteggiatura.
—L’indice analitico dei nomi comprende anche quelli citati nel primo volume; sono state collegate ai rispettivi rimandi solo le voci riguardanti il presente secondo volume.
—La copertina di questo progetto è stata prodotta dal trascrittore utilizzando il frontespizio del libro originale; l’immagine è posta in pubblico dominio.
SCRITTORI D’ITALIA
━━━━━━━━
C. BALBO
SOMMARIO
II
CESARE BALBO
DELLA STORIA D’ITALIA
DALLE ORIGINI FINO AI NOSTRI GIORNI
SOMMARIO
━━━━━━━━
A CURA DI
FAUSTO NICOLINI
VOLUME SECONDO
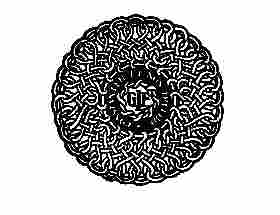
BARI
GIUS. LATERZA & FIGLI
TIPOGRAFI—EDITORI—LIBRAI
1914
───────
PROPRIETÁ LETTERARIA
───────
FEBBRAIO MCMXIV—37567
LIBRO SETTIMO
ETÁ SETTIMA: DELLE PREPONDERANZE STRANIERE
(anni 1492-1814).
1. Di quest’etá in generale, ed in particolare di questo periodo primo delle preponderanze spagnuola e francese combattute [1492-1559].—Fin dall’ultimo secolo dell’etá precedente, noi vedemmo incominciare quel travaglio di unione dei popoli, d’ingrandimento degli Stati italiani, il quale continuò lungo tutta l’ultima e durante nostra etá. E noi, salutammo siffatte riunioni con compiacimento, senza guari compiangere le forme repubblicane perdutesi in quell’opera, senza lamentare i principati sorti sulle loro rovine; perché crediamo, che anche ne’ principati possa esser libertá e felicitá; perché ai tirannici e semibarbari di que’ secoli ne succedettero di quelli civili, e che van diventando liberi; perché poi, in somma, noi teniam l’occhio fermo principalmente al bene di tutte insieme le terre italiane, e che, tenendo sempre piú impossibile la riunione totale di esse, noi stimiamo sommo bene lo sminuzzamento quanto minore, le riunioni quanto maggiori sieno possibili. Se si fosse continuata quest’opera delle unioni degli Stati senza invasioni, senza preponderanze straniere, Dio sa qual magnifico destino sarebbesi venuto ordinando fin d’allora all’Italia! Dio non volle, pur troppo; i nostri maggiori non se l’erano meritato; non avean adempiuto ai grandi doveri, alle grandi virtú nazionali; non avean badato se non ciascuno a sé, con quell’egoismo politico che è vizio e stoltezza insieme, e tanto piú quanto piú va progredendo la civiltá. Quindi, quest’etá, che fu felicemente della formazione degli Stati italiani, fu pure infelicissimamente delle invasioni e delle preponderanze straniere;[4] e prima, delle due francese e spagnuola combattenti tra sé per sessantasette anni; poi della spagnuola pesante sola per centoquaranta; poi delle due, francese ed austriaca, contrappesanti in guerra o in pace, per centoquattordici altri. E da queste tre combinazioni diverse di preponderanze verranno poi naturalmente le tre suddivisioni di quest’ultima etá nostra. Nella quale non faccia specie se dimoreremo piú a lungo che nell’altre piú lontane. Cosí abbiam fatto, a disegno, fin da principio. Nelle storie scritte ad uso degli eruditi, si soglion cercare i particolari de’ tempi quanto piú antichi. Ma nelle storie scritte ad uso comune, popolare, giovano all’incontro tanto piú i particolari, quanto piú son di tempi vicini, simili a’ nostri, piú utili ad accennare ciò che sia da imitare, ciò che da fuggire.—E rimanendo ora nel primo de’ tre periodi detti, ci par da notare che niuno forse mai quanto quello s’assomigliò ai tempi nostri. Una delle volgarita di questi è di credere, che non somiglino a nessun altri, che non mai si sien veduti tanti e cosí grandi fatti, tante e cosí grandi novitá. Quindi poi due gravi errori, due politiche contrariamente esagerate e mediocri: di alcuni timidi, spaventati per sé, od anche candidamente per altrui, di quel moto che par loro anomalo, pericoloso, e a cui si fanno un dovere di resistere, senza eccezione né discernimento; di altri avventati e buonamente compiacentisi in ogni moto, in ogni novitá, e che si fanno un dovere di secondarle, di spingerle, senza discernimento pur essi. Non molti sanno vedere il proprio tempo qual è; non molti, che il nostro, pieno di fatti nuovi e progressivi senza dubbio, è perciò appunto simile ad altri tempi non meno pieni di tali fatti; diversi l’uno e gli altri in ciò solo, che i progressi posteriori son di lor natura pur ulteriori; ma di nuovo simili in ciò, che tra le novitá sempre le une son progressi, e le altre all’incontro arresti o regressi; e che quindi sempre ogni politica assennata debb’essere discernente, e constare delle due opere del secondare e del resistere. Ad ogni modo, se niun tempo mai fu pieno di grandi novitá, certo fu quello che siamo per correr qui dal 1492 al 1559, dalla chiamata di Carlo VIII che turbò l’Italia e la cristianitá, alla pace di Cateau-Cambrésis che bene o male[5] le compose.—Trovata la bussola da due secoli, la polvere da guerra da uno e mezzo, la stampa da un mezzo, le lettere antiche lungo tutto quel tempo, l’astrolabio da alcuni anni, l’America nell’anno stesso onde incominciamo, la via dell’Indie per il capo di Buona Speranza due anni dopo [1494]; s’accumularono, si combinarono gli effetti di tutte queste nuove cause; ne uscí un mondo rinnovato tutto; si rinnovarono, si mescolarono tutte le nazioni; e n’uscí la cristianitá pur troppo non piú unita in una fede e una Chiesa intorno a una sedia centrale, ma una cristianitá felicemente unita, non piú intorno alla barbara monarchia universale di Carlomagno e de’ pseudo-imperatori romani, bensí in una civiltá e una coltura universali. E il mezzo adoperato a ciò dalla Provvidenza qual fu egli? Evidentemente quel ritrovo che ella diede a tutte quelle nazioni semibarbare nella nostra Italia, posseditrice da quattro secoli non solamente del primato, ma della privativa della libertá e della coltura. Le nazioni non presero, per vero dire, la libertá italiana, che non era bella, non buona, non civile, non allettante, e del resto giá semispenta; ma presero quella coltura, di che abusaron prima religiosamente, di che usaron poi politicamente a riacquistare la libertá.—E l’Italia intanto? L’Italia che aveva tutti i vantaggi della libertá, della coltura, dei commerci e delle ricchezze, ma che aveva i tre grandi svantaggi della libertá mal ordinata, del disuso nella milizia, e di una indipendenza mal compiuta; l’Italia perdette tutti que’ vantaggi suoi, tutte quelle sue operositá, e quel poco d’indipendenza; visse od anzi sopravvisse alcun tempo splendidamente in quegli uomini sorti al tempo migliore, per cader poi, quanto a politica, a un tratto; quanto al resto, a poco a poco, in un’abbiezione che, questa sí, fu anormale, forse unica nella serie de’ secoli civili cristiani.—Furono dunque questi sessantasette anni uno splendidissimo, spensieratissimo precipitare e non piú. E quindi peggio che mai resta tormentato qui lo scrittore di non aver luogo a spiegarli, a lasciarne una chiara ed adeguata impressione. Ma suppliranno i leggitori, con quel che sa ognuno di questo nostro tempo di splendore. E suppliran pure a quelle applicazioni a’ propri tempi,[6] le quali, che dicasi, sono insomma il vero pro della storia; sapran vedere tutta la serie delle cause, degli effetti, e delle nuove cause di nostre perdizioni; l’incompiutezza antica dell’indipendenza, l’antico disordine delle libertá, l’antico difetto d’armi nazionali, gli stranieri nuovamente chiamati, sofferti, lasciati antiquarsi; e finalmente le operositá nazionali cessate, gli ozi, i vizi, le mediocritá innaturali all’Italia, accettate quasi necessitá, diventate abito, e seconda natura; e, danno e vergogna ultima a’ degeneri, il riposar in quel limo, e consolarvisi col sognar le glorie de’ maggiori.
2. Stato d’Europa e d’Italia [1492-1494].—La Provvidenza ha tutto nelle mani, senza dubbio; ma lascia apparire alcune, e cela altre delle leggi delle opere sue; e fra le piú celate è forse quella per cui concede o nega uomini alle nazioni. Fu uno di que’ decreti male scrutabili di lei, che mentre i popoli oltremontani ed oltremarini si univano dopo lunghi travagli ciascuno in un corpo di nazione sotto principi se non grandi almeno arditi ed operosissimi, l’Italia, perduto Lorenzo il magnifico, non avesse piú se non uomini o mediocri (come giá quelli che eran succeduti a Cosimo e Francesco Sforza), o cattivi o cattivissimi.—In Inghilterra Arrigo VII, regnante dal 1485, aveva con suo maritaggio riunite le due case, distrutte le due fazioni di Lancastro e di York, che l’avevano lungamente straziata.—In Ispagna s’eran congiunte Castiglia ed Aragona fin dal 1474 con un altro maritaggio tra Isabella e Ferdinando; e questi insieme avean poi conquistata Granata, l’ultimo regno e rifugio di mori, in quel medesimo anno [1492] della morte di Lorenzo e della scoperta d’America; ondeché, non rimaneva piú disgiunto se non il piccol regno di Navarra, e tutte quelle vittorie e fortune accendevan l’animo piú inquieto che grande, ma insomma ambiziosissimo di Fernando, detto (appunto allora e per concessione del papa) il «re cattolico».—In Francia, dove Carlo VII aveva finita la guerra d’indipendenza e cacciati gl’inglesi, e Luigi XI riunite Borgogna e Provenza e i diritti de’ secondi Angioini al regno di Napoli e Sicilia, regnava il giovine Carlo VIII dal 1483; e, riunita Bretagna sposando Anna che n’era duchessa,[7] ambiva quel retaggio dei conti di Provenza in Italia, ambiva l’imperio orientale, una gloria da Carlomagno, qualunque gloria.—Finalmente in Germania, signora nostra (di nome per vero dire oramai, ma anche i nomi son pericoli ai deboli), succedeva nel 1493 al misero Federigo III d’Austria Massimiliano prodigo, inquieto, ed egli pure ambizioso. Con tre principi come Ferdinando, Carlo VIII e Massimiliano a capo di tre quarti della cristianitá, non è meraviglia che ella si sconquassasse tutta; è piuttosto miracolo che non ne perisse. E intanto in Italia signoreggiavano, su Savoia e Piemonte, Carlo II, fanciullo d’un anno, quando succedette nel 1490; su Monferrato, Gian Francesco II pur fanciullo; su Milano, quasi fanciullo quel giovane ed incapace Gian Galeazzo, che dicemmo sotto la quasi tutela di suo zio Ludovico il moro, e che, avendo sposata nel 1489 Isabella di Napoli, n’aveva acquistata in apparenza una protezione, di fatto un nuovo pericolo, per la gelosia e la paura concepitene dal Moro. In Firenze erano succeduti alla potenza indeterminata di Lorenzo, Piero mediocrissimo che non la sapea tenere, e due fratelli minori, Giovanni, allor cardinale e che fu poi papa Leon X, e Giuliano. E sulla sedia romana, morto il Cibo nel medesimo anno fatale 1492, era succeduto Borgia, Alessandro VI, il peggior papa di questi tempi, ove ne furono pochi buoni. Signoreggiavano ne’ ducati di Ferrara e Modena gli Estensi; in quello d’Urbino, i Montefeltro; i Gonzaga in Mantova; i Bentivoglio in Bologna; i Baglioni in Perugia; i Colonna, gli Orsini ed altri signorotti, in molte terre della Chiesa. In Napoli regnava il perfido e crudele, e cosí diventato potente, ma ora vecchio Ferdinando I, che non seppe scongiurar il pericolo, che morí prima di succombervi nel 1494. Sicilia era del re cattolico. Genova, tenuta come feudo di Francia da Ludovico il moro. E Venezia, giá caduta in quella viltá e stoltezza del volersi tener neutrale ne’ pericoli comuni, isolata. E cessati, con Francesco Sforza e i Piccinini, i grandi condottieri potenti al par di principi e repubbliche, non ne rimanevan guari se non de’ piccoli, impotenti a tutto, salvo che a tener disavvezzi dall’armi i popoli della imbelle Italia.
3. Alessandro VI papa [1492-1503].—La causa de’ nuovi guai d’Italia fu senza dubbio l’incapacitá politica e militare di lei; l’occasione poi, fu l’ambizione straniera di Carlo VIII, aiutata dall’ambizione traditrice di Ludovico il moro. Il quale richiesto da Ferdinando di lasciare il governo al nepote Gian Galeazzo, volle usurparne il ducato; e perciò fecesene dare da Massimiliano imperatore l’investitura disprezzata giá dal gran Francesco Sforza, e non data poi a nessuno dei discendenti. E per poter poi effettuare l’usurpazione, volle assicurarsi di Carlo giá minacciante, s’alleò con lui, gli promise passaggio ed aiuto. Qui non era nessuna delle scuse dell’altre chiamate; non quella, che può esser buona, di cacciare altri stranieri; nemmen quella cattiva, di resistere a un nemico interno. Qui è un cumulo di tradimenti; e quindi il Moro è il traditor piá esecrato nelle memorie italiane. Ma pur troppo non fu il solo; il cardinal Della Rovere, che fu poi papa Giulio II e fece tanto chiasso di cacciar i barbari d’Italia, spinto ora dalla rivalitá, dalla inimicizia ad Alessandro VI, anch’egli si trova tra’ chiamatori ed accompagnatori dello straniero.—Carlo scese in agosto 1494 pel Monginevra, Torino, Asti. Ivi ammalò e si fermò. Poi passò a Milano, visitò, non protesse Gian Galeazzo giá morente, e che morí pochi di appresso [20 ottobre] con voci di veleno. Cosí il Moro fu duca, e tirò fuori l’investitura imperiale. Carlo proseguí, s’appressò a Toscana per Pontremoli. Viene Pier de’ Medici spaventato, e gli dà i castelli fiorentini che difendean que’ passi, quello stesso di Pisa. Ma tornato costui a Firenze, è cacciato dalla signoria, dal popolo sdegnato [9 novembre]. Al medesimo dí, Pisa caccia i fiorentini, si libera, presente, e piú o men connivente, Carlo VIII. Questi lascia un presidio nel castello, muove a Firenze, v’entra militarmente, la lancia alla coscia, tratta un accordo colla nuova signoria; e volendolo imporre duro, gli è stracciato in faccia da Pier Capponi, che disse:—Sonate vostre trombe, noi sonerem nostre campane.—Fu il solo bell’atto di questa guerra; cosí vergognosa, del resto, che i contemporanei la disser fatta col «gesso» dei forieri i quali segnavan gli alloggi francesi di tappa in tappa. S’accomodarono[9] tuttavia Firenze e Carlo; e questi proseguí a Roma, dove il papa chiusesi in castel Sant’ Angelo, e s’accomodò poi. Spaventato Alfonso II, il nuovo re di Napoli testé succeduto, lasciava vilmente la corona a suo figliuolo Ferdinando II [24 gennaio 1495]; e questi provava a difendere i passi, ma era vilmente disertato da’ suoi, e fuggiva da Napoli a Sicilia; e Carlo VIII entrava in quella il dí appresso [22 febbraio]. S’arrendevano, a gara di viltá, castella, cittá, province, grandi, popoli, il Regno. Tanto che tra pochi dí i francesi n’erano ad oziare e viziarsi nella disprezzata conquista.—Allora, sollevavasi tutta Italia, mezza Europa, lo Sforza traditore, perché non avea piú ad acquistare ma a difendere il ducato, or minacciatogli dalle pretensioni del duca d’Orléans discendente da una Visconti e signor d’Asti; Venezia, tornata (per poco) al sentimento de’ pericoli d’Italia; il Borgia, tornato dal suo spavento; il re cattolico per restaurare i parenti, o forse fin d’allora riaggiunger Napoli a Sicilia ed Aragona; e Massimiliano non so per quale delle sue mutevoli ambizioni. Tutti questi insieme firmavano un trattato contra Carlo [31 marzo]. Il quale cosi minacciato ripartiva da Napoli [30 maggio]; passava a Roma, schivava Firenze, passava a Pisa; e varcato Appennino, trovava a Fornovo l’esercito degli alleati italiani capitanato dal marchese di Mantova. Combattessi addí 6 luglio, molto piú forti gl’italiani. Disputasi chi vincesse; ma i francesi avean combattuto per passare, e passarono. Giunsero ad Asti, Carlo vi si fermò a corteggiar donne e trattar pace col Moro; e fattala, partí [22 ottobre] da Torino per a Francia, dove non pensò piu guari a Italia.—Tornò quindi Ferdinando II nel Regno, rientrò in Napoli [7 luglio], e guerreggiandovi poi due anni contro a’ francesi rimastivi sotto Monpensieri, se ne liberò coll’aiuto degli spagnuoli capitanati da Gonzalvo di Cordova, il conquistator di Granata, detto il «Gran capitano». Capitolarono gli ultimi francesi ad Atella, e moriva Ferdinando II poco dopo, lasciando il regno a Federigo III suo zio, fratello di Alfonso [1496]. Ed anche da Pisa si erano ritirati i francesi fin dal primo dí di quell’anno, lasciando disputarsi e guerreggiarsi tra sé pisani[10] e fiorentini, e per gli uni o gli altri le varie potenze d’Italia, e Massimiliano re de’ romani. Il quale, invitato anch’egli dal Moro, il gran chiamator di stranieri, scese a frapporsi in tutto ciò con poca gente e pochi danari, e quindi non prese le corone solite, non fece nulla, e risalí disprezzato oltre ogni altro imperatore mostratosi in Italia.—I fiorentini tentavano intanto riordinar lor repubblica sgombra di Medici; ma eran divisi in parti, non piú nazionale o straniera, né per il papa o l’imperatore, per l’aristocrazia o la democrazia, per la repubblica o la signoria, ma pro e contro un frate domenicano, Gerolamo Savonarola. Costui, zelante, costumato, austero a sé, aspro ad altrui, in tempi corrotti, avea colle prediche politiche tratti molti a sé, vivente ancora Lorenzo. Era stato chiamato al letto di questo morente, e dicesi non l’avesse voluto assolvere, perché Lorenzo non voleva restituire la repubblica, a modo di lui il frate. Avea profetato malanni, castighi di Dio, francesi; ed or pendeva a questi che avean adempiute sue profezie. I suoi partigiani chiamaronsi «piagnoni»; i contrari, gente di mondo, gentiluomini i pií, «arrabbiati»; i medii, piú o men desiderosi de’ Medici, «bigi,» e poi «palleschi»; nomi e parti del paro ignobili. I particolari del tempo son vere commedie; il fine, tragedia barbarissima, da medio evo che ancor fiorisse. Contrario al frate riformator di costumi e disciplina ecclesiastica era Alessandro VI, naturalmente. Gli proibí di predicare. Il frate obbedí per poco; poi ricominciò, e contro al papa. Allora uscirono da sé, o fecersi uscire contra lui altri frati; prima un agostiniano, poi un francescano, Francesco di Puglia, il quale propose una di quelle stoltezze od empietá parecchie volte condannate dalla Chiesa, un giudicio di Dio: che passassero egli fra Francesco e il Savonarola tra una catasta ardente; e chi passasse illeso, quegli vincesse. Savonarola non volle, ma s’offri per lui fra Domenico suo confratello. Appuntossi il dí 7 aprile 1498; grande aspettativa, grand’apparecchio, gran concorso. Ma venuti al duello i due frati, fecero come chi vuole e disvuole, attaccaron disputa sul modo: cioè (quasi profanazione al dirne), sul Sacramento, che il domenicano volea portar con sé tra le fiamme,[11] e il francescano non voleva. Non se ne fece altro. Il popolaccio beffato infuriò, gli «arrabbiati» si sollevarono; e al dí appresso diedero l’assalto al convento di San Marco, e fecer prigioni fra Gerolamo, fra Domenico, e un terzo, fra Silvestro. I quali poi furono in pochi dí interrogati, torturati, condannati, ed arsi in piazza [23 maggio].—Di Savonarola chi fa un santo, chi un eresiarca precursor di Lutero, chi un eroe di libertá. Ma son sogni: i veri santi non si servon del tempio a negozi umani; i veri eretici non muoiono nel seno della Chiesa, come morí, benché perseguitato, Savonarola; e i veri eroi di libertá sono un po’ piú sodi, non si perdono in chiasso come lui. Fu un entusiasta di buon conto; e che sarebbe stato forse di buon pro, se si fosse ecclesiasticamente contentato di predicare contro alle crescenti corruttele della spensierata Italia.—Alla quale, come tale, ripullulavano le occasioni di perdizioni. Al dí appunto della festa fallita in Firenze, era morto Carlo VIII, era salito al trono di Francia Luigi XII, quel duca di Orléans che giá dicemmo pretender a Milano come discendente d’una Visconti, e che or pretese a Napoli come re di Francia, successore ai diritti degli ultimi Angioini. Se gli fosse riuscito il tutto, incominciava fin d’allora, e a pro di Francia, quella unione dei due grandi Stati italiani di settentrione e mezzodí, la quale sessant’anni dopo die’ l’Italia legata in mano a Spagna. Luigi XII non era avventato come Carlo VIII; era anzi principe prudente, destro, politico, e in Francia cosí buono che n’ebbe nome di «padre del popolo». Eppure, anch’egli ebbe le maledizioni d’Italia; tanto i migliori a casa son cattivi fuori! Non attese dapprima se non a Milano; e que’ veneziani che s’eran sollevati contro Carlo VIII, si collegaron ora con Luigi XII per il misero acquisto di Cremona e Ghiara d’Adda [trattato di Blois, 15 aprile 1499]. Chiaro è: que’ vantatissimi politici non ebber forse mai, non aveano certo piú niuna politica vera, lunga, propriamente detta, ma solamente abilitá alla giornata; quella vantata aristocrazia non aveva piú l’aristocratica virtú della costanza, ma solamente l’aristocratico istinto della propria conservazione. E legossi pure con Luigi XII Alessandro VI, per far suo infame figliuolo Cesare[12] Borgia duca di Valenza in Francia e di Romagna in Italia. E lasciaron fare, Massimiliano distratto in Germania, e Federigo III di Napoli mal fermo nel nuovo regno. Cosí da Asti, giá sua, Luigi XII assalí il ducato; ed alle prime fazioni sbandaronsi le truppe del Moro, che fuggí in Germania; e Luigi entrò in Milano [2 ottobre 1499], e tutto il ducato con Genova furono di lui. Ma tornato esso in Francia, e riposando i francesi lasciati nella conquista, ritorna il Moro con un esercito di svizzeri e fuorusciti, e riprende Como, Milano, Parma, Pavia, Novara. Arriva La Tremoglia con un nuovo esercito di francesi e svizzeri. Svizzeri di qua, svizzeri di lá, dicesi ricevessero da lor paese ordine di non combattersi. Ad ogni modo quelli dello Sforza lasciano in mano agli altri e a La Tremoglia i lor compagni italiani, i Sanseverino lor capitani, e finalmente lo Sforza; e poi risalgono a lor monti saccheggiando per via. Cosí il Moro, traditore tradito, fu preso, tratto a Francia e tenuto poi dieci anni al castello di Loches, finché vi morí disprezzato, dimenticato. E Milano e il ducato ridiventarono francesi tranquillamente per parecchi anni.—Intanto Luigi XII aveva giá apparecchiato l’acquisto di Napoli in questo modo. Addí 11 novembre 1500, in Granata erasi firmato un trattato tra lui e Ferdinando il cattolico, parente e protettore di Federigo III, re di Napoli; ed eravisi concertato che i francesi assalirebbono il Regno, che gli spagnuoli accorrerebbero a difenderlo, e che prima d’incontrarsi, lo spartirebbono. Certo costoro eran contemporanei non del tutto indegni del Moro, di Alessandro VI e di Cesare Borgia. Effettuossi l’accordo. Nella state del 1501, entrarono per la frontiera settentrionale del Regno il duca di Nemours co’ francesi, e per le Calabrie Gonzalvo il Gran capitano, che macchiò sue glorie in quest’infamie. Federigo il misero re, tradito e ridotto agli ultimi, scelse capitolar co’ nemici vecchi anziché con gli amici traditori, e diessi in mano a’ francesi che il trassero a Torsi dove morí nel 1504. Cosí finí il primo regno indipendente di Napoli; e andò a riunirsi a Sicilia, nella servitú straniera, per due secoli e mezzo.—Intanto, e naturalmente, disputaronsi i ladroni per le spoglie. Corso[13] appena un anno [1502], ruppesi guerra tra francesi e spagnuoli. Combattutosi variamente dapprima, furono sconfitti i francesi a Seminara e Cerignola [aprile 1503]. E sceso un altro esercito francese, fu vinto pur esso al Garigliano al fine del medesimo anno dal Gran capitano; e tutto il Regno rimase fin d’allora spagnuolo.—Nell’agosto era morto papa Borgia. La brevitá cosí sovente tormentante di questo sunto ci serve qui, dispensandoci dal dire le dissolutezze, le rapine, i tradimenti, i veleni, le crudeltá di tutta quella famiglia. Tanto piú che tutto ciò fu bensí il sommo della perversitá di quei tempi perversi, ma non ne fu mutato essenzialmente né durevolmente quasi nulla in Italia. Fu progetto di Alessandro e del figlio distrurre i signorotti, i vicari pontefici che signoreggiavano nelle cittá della Chiesa, i Colonna ed Orsini intorno a Roma, i Varani in Camerino, i Freducci in Fermo, i Trinci in Foligno, i La Rovere in Sinigaglia ed Urbino, i Baglioni in Perugia, i Vitelli in Cittá di Castello, gli Sforza in Pesaro, i Malatesta in Rimini, i Riario in Imola, gli Ordelaffi in Forlí, i Manfredi in Faenza, i Bentivoglio in Bologna e gli Estensi in Ferrara. Cesare Borgia doveva rimanerne duca di Romagna. Ma con tutte le loro male arti sofferte od aiutate dalle potenze italiane e straniere, a che riuscirono? Assassinarono signorotti, riunirono poche signorie, e non durò il ducato. E meraviglia che Machiavello ed altri di que’ tempi ammirasser costoro. Se non che, la Dio mercé, e che che si dica, anche la scienza politica è progredita d’allora in poi: il Machiavello de’ nostri tempi ha professato che le scelleratezze sogliono essere non solamente delitti, ma errori. Cosí fosse ben imparato e tenuto fermo in Italia. Dicesi che Alessandro VI istituisse la censura ecclesiastica de’ libri [1 giugno 1502]; ma ei non fece che applicarla a’ libri stampati. E il fatto sta che ella esistette sempre, ed esiste in qualunque chiesa, anche acattolica, voglia mantenere i suoi dommi. La cattiva imitazione, poi, delle censure politiche nacque molto piú tardi. Dicesi morisse Alessandro di un veleno apparecchiato a’ suoi nemici, e preso da lui e dal figliuolo che ne rimase infermo, e incapace di provvedere ai fatti suoi durante la[14] vacanza della Sede.—La sola buona opera italiana di questo tempo, fu la guerra sostenuta da Venezia contro a’ turchi nel Friuli, in Grecia, in mare, dal 1499 al 1503, in che fecesi pace. S’allega a scusa dell’aver cosí mal provveduto Venezia in quegli anni all’indipendenza d’Italia; non serve ad ogni modo per gli anni addietro. Tutti gli italiani furono colpevoli, in somma, che la penisola libera di stranieri (e si può dir degli imperatori stessi) dieci anni addietro, fosse ora tutta occupata da essi, salvo Venezia, Toscana, e gli Stati del papa.
4. Pio III, Giulio II [1503-1513].—Succeduti al pontificato Pio III (Piccolomini) per pochi giorni, e poi Giulio II per dieci anni, non so s’io dica che peggiorassero o migliorassero le condizioni nostre. Giulio II era quel Giuliano della Rovere, che egli pure aveva chiamati, condotti i francesi a Napoli. Fatto papa, chiamò francesi e tedeschi contra Venezia. Poi, avutone quel che voleva, si ravvide, bandí una guerra che chiamò «santa» contra francesi, bandí la cacciata de’ barbari; e per aver esso, ultimo de’ papi, fatto udir questo gran grido, il nome di lui riman glorioso e caro nelle memorie italiane. E noi siamo stanchi di severitá, noi rispettiamo le tradizioni nazionali, e cerchiam le occasioni di lodare.—Alla morte d’Alessandro molte delle cittá tenute dal Borgia si sollevarono. Giulio II, appena salito al trono, gli domandò le rimanenti; e rifiutato, lo fece prendere, gli fece firmare per forza la consegna, e lo rilasciò poi. Ed egli se n’andò a Napoli, vi fu di nuovo imprigionato da Gonsalvo e mandato a Spagna; dove fuggito di prigione, fu a Navarra, e finí poi piú degnamente che non meritava, coll’armi in mano [1507].—Nel 1506 venne il re cattolico al regno di Napoli, e ne ritrasse il Gran capitano che l’avea conquistato, che sopravvisse poi in Ispagna in ozio e disfavore. Giulio II continuò ciò che era buono de’ disegni de’ Borgia, la riduzione de’ signorotti; e vi riuscí meglio, ridusseli quasi tutti, gli stessi Baglioni di Perugia, e i Bentivoglio di Bologna [1506]. Ma per compiere la riunione dello Stato rimanevano a riprendersi a Venezia Ravenna e Cervia usurpate fin dal secolo scorso, Faenza, Rimini e Forlimpopoli ultimamente tra il rovinar di Cesare[15] Borgia. A ciò si volse tutto papa Giulio; aveva ogni ragione, ma proseguilla in mal modo, aggiugnendosi all’ire o piuttosto alle ambizioni di Luigi XII e di Massimiliano. Fin dal 1504 avean costoro firmato un’alleanza per dividersi gli Stati continentali di Venezia, ma non n’avean fatto nulla, finché non vi s’aggiunsero papa Giulio per riaver quelle cittá, e il re cattolico, gli Estensi e i Gonzaga per simili contese od ambizioni di vicinato. Fu firmata la famosa e brutta lega a Cambrai [10 dicembre 1508]. Primi ad assalire furono i francesi coll’armi dal Milanese; seguí il papa coll’armi e con le scomuniche. Contro ai primi stavano a capo d’un esercito di quaranta e piú mila uomini l’Alviano ed il Pitigliano, due de’ piú abili condottieri o piuttosto (perché giá non erano piú cosí indipendenti come gli antichi) capitani d’Italia. Furono vinti da Luigi XII e trenta mila francesi ad Agnadello [14 maggio 1509]; Luigi XII prese in pochi dí tutta la parte sua convenuta. Accorsero quindi tutti gli altri, e presero facilmente le loro. E allora Venezia ridotta all’estremo fu veramente magnanima, prese uno di quei partiti semplici che sono non solamente piú gloriosi sempre, ma sovente piú felici che non le destrezze. Sciolse dall’obbedienza tutti i suoi sudditi di terraferma; ed essi si difesero meglio, e, quando occupati, si sollevarono secondo le occorrenze per se stessi. E Giulio II, satisfatto di riavere sue cittá, si staccò primo dalla lega, fece sua pace addí 24 febbraio 1510; e si rivolse contra i francesi, nascostamente prima, apertamente tra breve. Per ciò chiamò nuovi stranieri, gli svizzeri; i quali, capitanati da un cardinale guerriero e vescovo di Sion, piombarono sul Milanese a mezzo quell’anno, mentre si avanzavano i papalini da Modena, e riavanzavano i veneziani da Verona. Ma i francesi stavano sulle guardie; e poco mancò non prendessero papa Giulio, che, guerriero anch’esso, stava lí vicino a Bologna, e che per la breccia entrò poco appresso alla Mirandola. E qui pure v’ha chi ammira, e vorrebbe imitazioni; non io, che credo un papa debba restar papa, ed abbia altri modi di cacciar barbari dal suo paese. Furono rotti i pontifici a Casalecchio [21 maggio 1511]; ma Giulio perdurò, s’inaspri, fece [5 ottobre] un’altra[16] lega santa con Venezia, svizzeri, Spagna e fino Inghilterra contra Francia. Massimiliano solo rimaneva con questa, ma inutile. In tali strettezze usarono i due l’arme antica contro ai papi, convocarono un concilio a Pisa. Ma un forte esercito spagnuolo sotto al Cardona veniva in aiuto a Giulio II, ed assediava Bologna tornata nuovamente a’ Bentivogli [21 maggio 1511]; e i veneziani riprendean Brescia. Allora apparí per poco una vera meraviglia di arte e virtú militare, un predecessore de’ grandi capitani moderni, Gastone di Foix, nipote del re di Francia, giovane di ventidue anni. Il quale, appena ebbe preso il comando, che ficcatosi in mezzo ai due eserciti nemici, e piombando or sull’uno or sull’altro, addí 7 febbraio respinse gli spagnuoli da Bologna, addí 19 ruppe i veneziani e riprese Brescia, e ritornò quindi sull’esercito spagnuolo e papalino, e li sconfisse a Ravenna [11 aprile]. Ma ivi morí, immortalatosi in pochi mesi. E allora precipitarono i francesi. Massimiliano lasciò passare ventimila svizzeri che scendean alleati a’ veneziani; Spagna e Inghilterra assaliron Francia; Luigi XII richiamò il suo esercito dal Milanese; Massimiliano Sforza, figlio del Moro, fu fatto duca a Milano; in giugno si sollevò Genova e cacciò i francesi. Cosí, toltene alcune castella, furon questi cacciati di tutt’Italia. Ma eran tutt’altro che cacciati tutti i barbari. Abbondavano spagnuoli, tedeschi e svizzeri, e tiranneggiavan cosí, che, per dar loro una ricompensa delle vittorie procacciate alla lega, fu loro abbandonata una delle piu nobili cittá e potenze italiane, Firenze.—Questa fin da poco dopo la vittoria degli «arrabbiati» contro al Savonarola s’era riordinata e posata sotto l’autoritá d’un solo; e (tanto era impossibile oramai un governo piú repubblicano) sotto un Soderini, gonfaloniero a vita [1502], che avea poi retto con bontá, semplicitá, mediocritá. Machiavello era uno de’ due segretari o ministri principali di lui. Tra tutti ed a forza di trattare, barcheggiare, scivolare, eran riusciti ad ottenere che si lasciasse lor riprendere la desiderata Pisa, e l’avean presa [1509]. Ma, se non esclusivamente, eran pur sempre rimasti stretti con Francia; ed ora i vittoriosi di Francia le posero una multa per quella fedeltá. Que’ mercatanti repubblicani[17] che aveano avute velleitá ma non volontá di ordinar armi proprie, secondo il consiglio di Machiavello, e che eran poi gretti e stretti in fatto di danari, ricusarono, indugiarono. Vengono i Medici, cioè (morto giá Piero da parecchi anni) Giuliano e il cardinal Giovanni, ed offrono pagar la multa se fosser fatti signori della cittá. Cardona accetta, varca Appennino, prende, saccheggia Prato; e i fiorentini, spaventati, si sollevano, cacciano Soderini, e accettan i Medici [settembre 1512]. Governarono insieme Giuliano e il cardinal Giovanni. Ma questi per poco; ché, morto papa Giulio addí 21 febbraio 1513, gli successe esso il cardinal Giovanni [11 marzo] con quel nome di Leone X, che, a torto od a ragione, è forse il piú noto, il piú popolare fra quelli di quanti papi furon mai.
5. Leone X [1513-1521].—Le nature facili, liete, pompose, leggiere, trascurate od anche un po’ spensierate, sogliono piú che l’altre trovar fortuna in vita, e gloria dopo morte. Tal fu, tal sorte ebbe Leone X, del resto non gran principe politico ed ancor meno gran papa. Nato nel 1475, cresciuto tra l’eleganze, le colture, le magnificenze del palazzo Medici e della villa di Careggi; tra Ficino, Poliziano, Pico della Mirandola, Michelangelo, e una turba di minori, ma simili; cardinale a tredici anni; fuoruscitosi in sui diciannove, ma nella porpora, ed ora a Roma, ora alle corti dentro e fuori d’Italia; in colti ozi durante Alessandro VI; poi negli affari, nelle legazioni sotto Giulio II; prigione alla battaglia di Ravenna, ma in breve liberato, ed autor principale della restaurazione di sua casa in sua bella cittá; l’elezione, l’assunzione, l’incoronazione di lui furono veri trionfi. Dopo Alessandro VI, troppo scellerato per essere nemmeno stato protettor d’arti o di lettere, dopo Giulio II, fiero, iroso in queste stesse protezioni, pensi ognuno qual gioia dovesse or sorgere in quella turba di letterati ed artisti che, quasi ballerine tra guerrieri, si frammettevano allora ai feroci invasori, ai cupi politici, ed ai dolenti popoli d’Italia. Quella lieta turba non si vuol perder di memoria mai da chiunque voglia farsi un’idea adeguata di questi tempi singolarissimi. Certo in quelli di PericIe, d’Augusto, né di Ludovico XIV, non fu, o almeno non durò, niun siffatto contrasto di feste e di dolori. Qui[18] la patria era in mano a stranieri; e il principe successor d’Alessandro III e di Giulio II pensava ai nepoti, ai Medici, a far loro Stati in Firenze ed Urbino. Qui sorgeva il sommo degli eresiarchi stati mai dopo Ario; e il pontefice pensava che fosse un frataccio peggio che il Savonarola, e che finirebbe come lui; e proseguiva in quell’abbellir Roma, in quell’edificare, e scolpire, e dipingere, e fare scrivere e rappresentare commedie che avevano scandalezzata la rozza Germania. Insomma, moralmente, politicamente e religiosamente parlando, non sarebbe troppo il dire che fu un vero baccanale di tutte le colture; e se scendessimo ai particolari di sua incoronazione, o, peggio, di ciò che fu allora scritto, rappresentato, dipinto o scolpito in Vaticano, ei parrebbe forse dimostrato a ciascuno. Ma, non avendone luogo, lasceremo che ognuno giudichi secondo le proprie informazioni della severitá del nostro giudicio.—Pochi giorni dopo l’assunzione di Leon X, Luigi XII firmò sua pace con Venezia [24 marzo 1513]; e, cosí assicurato, mandò La Tremoglia e Triulzi a riconquistare Milano contro allo Sforza. Ma vinti i francesi dagli svizzeri presso a Novara [6 giugno], ripassaron l’Alpi; e allora Leon X e gli spagnuoli si rivolsero di nuovo per lo Sforza contra Venezia, e rioccuparono quasi tutto lo Stato di terraferma. Guerreggiossi e trattossi variamente tutto l’anno appresso. Ma morto in gennaio 1514 Luigi XII, e succedutogli Francesco I, principe buono, leggero, facile, gran protettor di lettere ed arti ancor egli, non gran capitano ma gran cavaliero e guerriero, rinnovò l’alleanza con Venezia; e (guardatogli contro dagli svizzeri il passo di Susa) scese per l’Argentiera e Sestriera con un forte esercito a quel Piemonte cosí sovente attraversato, a quella Lombardia cosí sovente riconquistata. Due giorni [13 e 14 settembre] si combatté in Marignano tra’ francesi e gli svizzeri dello Sforza; vinse Francesco I; ventimila cadaveri vi giacquero; il Triulzi, stato a diciotto battaglie, disse, che l’altre eran giuochi da fanciulli, questa battaglia di giganti. Ondeché qui cessa la meraviglia che i venturieri italiani, avvezzi a non ammazzarsi, fosser vinti da tutti questi stranieri che s’ammazzavano cosí davvero. Quindi ritrassersi finalmente gli svizzeri a lor montagne, e noi fummo liberati almen[19] di questi, che fecero l’anno appresso una pace perpetua con Francia. Intanto, ritrattisi anche gli spagnuoli, Lombardia fu di nuovo di Francia, Terraferma di Venezia, e Massimiliano Sforza lasciò il ducato per sempre, e fu a vivere pensionato in Francia, dov’era vivuto e morto prigione il Moro suo padre. E Leon X fece pace col vincitore; ed abboccatosi con lui a Bologna, v’aggiunse poi un concordato, che per secoli regolò le cose di religione di Francia. E il medesimo di che firmò quest’accordo [18 agosto 1516], investi suo nipote Lorenzo di Pier de’ Medici del ducato d’Urbino, tolto pochi mesi addietro a Francesco della Rovere, che aveva pur data l’ospitalitá a’ Medici esiliati. Morto poc’anzi [17 marzo 1516] Giuliano ultimo fratello di Leone, questo Lorenzo era oramai il piú prossimo parente di lui, e governò poi colla solita potenza indeterminata la cittá di Firenze, e come principe il ducato d’Urbino, ritoltogli dal La Rovere e restituitogli l’anno appresso.—Intanto, morto Ferdinando il cattolico re di Spagna ed Indie e Sicilia e Napoli [15 gennaio 1516], e succedutogli Carlo figlio di sua figlia, che fu primo in Ispagna e quinto in Germania e nell’imperio, questi firmava [13 agosto] in Noyon un trattato di pace con Francesco I, al quale aderí in breve pure [4 dicembre] Massimiliano. E cosí finalmente, dopo sette anni, finirono gli scompigli politici e guerrieri sollevati dalla lega di Cambrai. Salvo le cittá di Romagna e del Regno, ripresele fin da principio di quella guerra, Venezia riebbe tutti gli Stati suoi di terraferma; esausti sí, ma che dovetter rifarsi prontamente, ondeché non mi sembra valere tale scusa per quella neutralitá od indifferenza in cui ricominciò a poltrire rispetto agli affari d’Italia. Non furono le forze, furono gli spiriti di lei che si trovarono abbattuti dopo quella guerra, o piuttosto che giá erano quando ella rimase neutrale ed infingarda alla discesa di Carlo VIII, o piuttosto giá dall’antico, tante altre volte che si racchiuse in sua sicurezza delle lagune, tra’ pericoli e i guai dell’indipendenza nazionale. La repubblica di Venezia, indipendente essa, non si curò della indipendenza nazionale, non fu guari italiana mai, se non al tempo della lega lombarda; del resto, sempre strettamente, grettamente veneziana; e se le[20] si voglia cercare una scusa od anche una gloria italiana, non le si può trovar guari a questi tempi se non quella d’averci difesi da’ turchi. Prima di questi, quella politica di lei, che tanti dicono profonda, non può non tacciarsi di leggerissima, per non aver pensato mai a nessuna impresa d’indipendenza, a cui ella sola forse poteva esser capo o centro, che ella piú che l’altre potenze italiane doveva prevedere necessaria. Cosí il languire poi, e decadere, e cadere ultimo di lei, servan d’esempio salutare a qualunque potenza italiana voglia mai isolarsi dagli interessi comuni di tutta insieme la nazione. Ad ogni modo, da quel princi pio del 1517 fino al 152l, i quattro ultimi anni di Leon X furono, relativamente, un tempo di respiro all’Italia, alla cristianitá. —Ma questo fu pure il tempo che sorse di piccoli principi quello che fu poi cosí gran danno alla Chiesa, alla cristianitá, e, politicamente parlando, all’Italia forse piú che a nessuno. Leon X bandí nel 1516 alcune indulgenze da predicarsi, e pur troppo, diciam la parola, da vendersi, o farsi o lasciarsi pagare in Germania, e il cui prodotto doveva servir all’edificazione di San Pietro. N’ebber carico i frati predicatori. Lutero, uno degli agostiniani soliti averlo, si sollevò poi contro a quelle, contro a tutte le indulgenze [3l ottobre 1517], poi contro alla curia romana, contro al papa, e finalmente contro all’infallibilitá, all’unitá, contro a questo e a quel domma, andamento solito di tutti i capi di setta. Denunciato a Roma, condannato, si sottomise; poi ritrattò la sommessione, disputò co’ legati, scrisse, riscrisse, fece discepoli, e fu ricondannato solennemente [15 giugno 1520]; ed ei solennemente bruciò la bolla [10 dicembre], assistente e gia aiutante il popolo di Wittemberga. Era incominciata quella Riforma, quella divisione della Chiesa, che non è vero (né a noi italiani può esser dubbio) introducesse nella cristianitá né la libertá politica né la filosofica, le quali avevamo noi da secoli; che non introdusse se non quella libertá del credere, la quale non può essere in una religione vera rivelata; che, del resto, preoccupò per un secolo e piú quasi esclusivamente la cristianitá, che la distrasse dalle opere migliori, che ritardò i progressi di lei in Germania, in[21] Francia e in quel popolo britannico, dov’oggi ancora ella ritarda l’unione dell’imperio. All’Italia poi ella fu origine d’un male nuovo allora, e forse non cessato. Dalla Riforma, dal bisogno, e diciam pure dal dover de’ papi di rivolgersi contro essa in Germania, incominciò quel loro accostarsi agli imperatori, che fu cosí contrario a tutte le tradizioni, che senza tale scusa sarebbe stato contrario alla natura stessa del papato.—E ciò si vide forse fin da questi primi anni della Riforma, ultimi di Leone X. Perciocché, morto Massimiliano [19 gennaio 1519] ed elettogli a successore Carlo figlio di suo figlio, giá re di Castiglia e delle Indie, d’Aragona e delle Due Sicilie, signor di Borgogna e de’ Paesi bassi, sorse in breve gelosia, contesa e guerra tra lui e Francesco I di Francia, competitore di lui per l’imperio. Era naturale, era tradizionale, che il papa s’opponesse alla potenza imperiale, risalente col possesso unito delle Due Sicilie a ciò che era stata sotto ai due Federighi Svevi, e minacciante salire, come salí, piú su. Né Leon X o la coltissima curia romana erano uomini da ignorare o trascurare tali memorie; e si accostarono dapprima a Francesco I. Ma tra breve, fosse giá quella nuova necessità spirituale della politica pontificia, fosse ambizione di Leone, che volesse avere (per sé o per casa Medici) Parma e Piacenza tenute un tempo da Giulio II ed or da Carlo V, il fatto sta che ei s’alleò con questo [8 maggio 1521]. Da quel dí, e salvo pochissime eccezioni furono sempre imperiali, austriaci i papi, abbandonarono quella causa nazionale che avea fatti grandi come principi e come pontefici Gregorio VII, Alessandro III, i due Innocenzi III e IV principalmente, e tanti altri tra essi. E molti buoni papi furono d’allora in poi certamente; ma[1] nessuno che sia potuto dirsi grande politico, nemmeno dagli scrittori tutto ecclesiastici. E Leon X incominciò subito la impolitica guerra. Riuniti gli eserciti pontificio e spagnuolo sotto Prospero Colonna e il marchese di Pescara, [22]entrarono addí 19 novembre in Milano, ove fu posto duca Francesco Sforza ultimo figliuolo del Moro. Leon X n’udì la nuova, e morí subitamente il I dicembre seguente 1521.—Mortogli nel 1519 il nipote Lorenzo, avea riunito agli Stati della Chiesa il ducato d’Urbino. Leone era l’ultimo o penultimo discendente legittimo di Cosimo padre della patria; disputandosi se fosse legittimo o no il figliuolo dell’antico Giuliano ucciso nella congiura de’ Pazzi, Giulio or cardinale posto a governo di Firenze dopo la morte di Lorenzo, e che fu in breve papa Clemente VII. Di Leone resterebbero a narrare e disputare alcune crudeltà e perfidie contro a cardinali e signorotti. Ad ogni modo, furon poche rispetto al tempo.
6. Adriano VI, Clemente VII [1522-1534].—Succedette Adriano VI [Florent, 9 gennaio 1522], precettor giá di Carlo V, fiammingo. ultimo papa straniero che sia stato; e santo papa che avrebbe voluto fare ciò che giá i papi tedeschi un cinquecento anni addietro, restituir la severità, la disciplina della curia romana. Ma egli non era, né aveva ad aiuto un Ildebrando; non si pose a capo dell’opinione italiana, come avean fatto que’ suoi compatrioti, e non riuscì. Bisogna vedere nel Vasari e in altre storie del tempo le disperazioni degli artisti e de’ letterati per questo che pareva loro ritorno alla barbarie. Era assente; ed intanto che giungesse, furon distrutte le opere politiche di Leon X: i La Rovere tornarono in Urbino, i Baglioni in Perugia, gli Estensi in parecchie terre lor tolte. Venne Adriano [agosto 1522], e strinsesi coll’imperatore, piú che mai signor d’Italia, posciaché i francesi erano stati sconfitti alla Bicocca [29 aprile], ed avean quindi vuotata Lombardia e Italia. Adriano intendeva, badava poco a politica; attendeva a riformar Roma, la curia. Morì ai 24 settembre 1523. Ai romani, agli artisti, ai letterati parve esser liberati.—E parve loro esser risorti, quando [18 novembre] fu eletto un nuovo Medici, il cardinal Giulio, che prese nome di Clemente VII. Arti e lettere furono riprotette, benché molto meno; per la buona ragione che Leon X vi aveva speso quanto si poteva e piú, e rimanevan poveri i successori; e per l’altra che, tra la guerra di Carlo V e Francesco I, durata tutto il pontificato[23] d’Adriano e quasi tutto quello di Clemente, fu il tempo peggiore che toccasse in quel secolo di strazi alla straziatissima Italia. Già un nuovo esercito francese sotto Bonnivet, era ridisceso in Lombardia; e ridiscesevi un esercito tedesco sotto il Borbone, principe, contestabile e traditor di Francia. Dir le fazioni che seguirono tra questi due, e Colonna e Pescara capitani degli spagnuoli, e Giovanni de’ Medici condottiero di quelle «bande nere» che si contano per l’ultima delle compagnie di ventura, ed altri minori, e le prede e le stragi di tutti, e le pesti che vi si aggiunsero, fu quasi soverchio, e riuscì noiosissimo anche nelle storie distese e del tempo; qui sarebbe impossibile ed inutile. Qui non sono nemmen piú a notare errori particolari. Quando s’è fatto quello massimo di dar la patria a stranieri, senza nemmeno serbar in mano l’armi onde approfittar di lor divisioni, di nostre occasioni, non è piú nulla a fare o dire, che soffrire finché dura il castigo di quel sommo errore, proprio o de’ maggiori. Resta memoria d’un progetto di quella mente feconda di Machiavello, la quale, colla sua costante preoccupazione dell’indipendenza, si fa forse perdonare tanti altri errori; il progetto che s’accostasser tutti gl’italiani a Giovanni de’ Medici, alle bande nere, che eran le sole armi italiane rimanenti. Ma che? Erano armi mercenarie e poche; e poi, Giovanni era buon guerriero sì, ma non aveva date prove di grandezza militare, ed anche meno di politica; né avea per sé quell’opinione universale, che è, dopo l’armi, il primo apparecchio a farsi duce di siffatte imprese.—Insomma, i francesi si ritrasser di nuovo per Ivrea ed Aosta nel 1524; e in questa ritirata morí Baiardo, che fra cosí brutte guerre seppe, dai vinti stessi, ottener nome di «cavalier senza paura e senza rimproccio»; e che morente e compatito dal Borbone, risposegli:—Non io che moio per la patria, ma fate pietà voi che la tradite.—Borbone e Pescara fecero quindi una punta in Provenza fino a Marsiglia; ma ne tornarono in fretta contra Francesco I, scendente di nuovo. Questi pose assedio a Pavia [ottobre], e mandò un altro esercito fin nel Regno, ove si mantenne parecchi anni. Ma accorso il Pescara a Pavia, seguí [25 febbraio 1525] quella gran battaglia dove fu preso il re di Francia.[24] Se ne consolò e consolò la nazione con quel detto (fatto famoso, come tanti altri, con un po’ d’alterazione) «esser perduto tutto fuor che l’onore». Ad ogni modo guastò questo, quando tratto prigione a Spagna, e non sapendo soffrir la noia (gran vizio talor anche a un re), firmò un trattato [14 gennaio 1526]; e liberato nol tenne, mal sofisticando sul proprio diritto di promettere in prigione, ch’ei non doveva usar se non l’aveva.—Del resto, questi eran tempi di perfidie complicate; e la liberazione di Francesco I fu aiutata da un altro tradimento fatto a un traditore italiano. Francesco Sforza e Morone suo cancelliero, oppressi in Milano da’ lor alleati spagnuoli e tedeschi, idearono liberar sé, e seco l’Italia. Buona, santa idea di nuovo; e che, se si fosse potuta eseguire con qualche ardita alzata d’armi, avrebbe fatto essi immortali e la patria finalmente felice. Ma ridusser l’impresa a una congiura. Alla quale, numerosa di necessità, avvenne ciò che è impossibile non avvenga: che tra un gran numero di uomini, gli uni traditori, gli altri almeno simulatori, non se ne trovi alcuno che simuli e tradisca la congiura stessa. Fu svelata questa (che del resto fu la sola che avesse uno scopo italiano, fra le tante congiure accennate) dalla duchessa d’Alençon, sorella di Francesco I, e dal Pescara, italiano, discendente e capitano di spagnuoli, a cui i congiurati promettevano il regno di Napoli. La prima tradì il disegno per liberar il fratello; il secondo, quando ciò seppe; e sia che fosse stato fino a quel punto traditor del suo principe, o de’ congiurati, costui arrestò il Morone ai 14 ottobre 1525, e morí un mese appresso, esecrato.—Fecesi poi, a’ 22 maggio 1526, una lega migliore, poiché aperta, tra il liberato Francesco I, Clemente VII, lo Sforza e i veneziani. Ma fu infelice del paro; l’avesser fatta al principio della guerra! ora era tardi. Lo Sforza ne rimase spoglio di Milano [24 luglio], e Roma pagò caro la leggerezza, la pretesa abilità, l’effettiva inabilità e i lussi de’ Medici. In settembre di quell’anno fu presa Roma una prima volta, e saccheggiato il Vaticano da Pompeo Colonna; e Clemente, rifuggito in castel Sant’Angelo, riescì a far patti e liberarsene. Ma l’anno appresso, il Borbone, giá vittorioso in Lombardia, in tutto il settentrione,[25] ed a capo d’un grande esercito quasi disoccupato e non pagato, s’incammina con esso verso mezzodí; senza che si sappia, senza che sapesse egli forse qual città o provincia d’Italia destinasse a servir d’occupazione e di paga a sue vecchie e feroci bande. Scende, varca Appennino, minaccia Firenze, piomba su Roma [5 maggio 1527]. Addì 6 dà l’assalto ed è ucciso d’un’archibugiata che il vano Benvenuto Cellini dice aver tirata egli. Succedegli un tedesco francese, il Nassau-Oranges; e si continua, s’entra in Trastevere e Vaticano, si saccheggia ed ammazza, e si passa il Tevere; e in tutta Roma, peggio che mai, prede e stragi e tormenti a’ prigioni per trame riscatti e far palesar nascondigli, men da soldati arrabbiati che da assassini da macchia. S’aggiunsero i Colonna, la fame, la moria. Eserciti alleati s’appressarono, e non osarono mettersi in questo inferno; il papa s’arrese e rimase prigione, e poi fuggì. Carlo V fece le viste di piangerne da lontano, ma lasciò continuare nove mesi. Ai 17 febbraio 1528 solamente, uscirono l’Oranges e sue bande, per danari mandati da Clemente giá scampato. Intanto si sfidavano Carlo V e Francesco I; e non ne seguiva nulla di piú che in quell’altra scimmiata di lor maggiori, Pietro d’Aragona e Carlo d’Angiò. Scendea Lautrec con un esercito francese, e correa tutta Italia fino al Regno; dove guerreggiò poi coll’Oranges, e perirono egli e molti de’ suoi d’una gran morìa. Ed anche in Lombardia v’era moría e guerra tra un nuovo esercito francese sotto il Saint-Pol, e un nuovo tedesco sotto il Brunswick. Ai 28 maggio, Filippino Doria, genovese ed ammiraglio di Francia, dava una gran rotta navale all’armata imperiale nel golfo di Salerno. Ai 30 giugno, Andrea Doria, zio di Filippino ed anche ammiraglio di Francia, ne dismette il servigio; e ai 20 luglio, passa all’imperatore, a patto di lasciargli liberar la patria, e la libera addí 12 settembre, e ne rifiuta poi la signoria, la tiene in libertá, ne riman primo e gran cittadino. Finalmente, ai 20 giugno 1529, si fa pace in Barcellona tra Carlo V e Clemente VII; e in luglio s’incomincia, e addí 5 agosto si firma in Cambrai, tra Luigia di Savoia per Francesco I suo figliuolo, e Margherita d’Austria duchessa di Savoia per Carlo V, un trattato che fu[26] detto quindi «delle dame»; per cui, fatta pace tra le due potenze strazianti Italia, rimase questa una seconda volta abbandonata tutta ad Austria. In novembre, furono insieme a Bologna papa, imperatore e Sforza; e fu restituito a questo il ducato con dure condizioni [22 novembre]; fatta pace con Venezia [23 dicembre]; fatto duca il Gonzaga, giá marchese di Mantova [25 marzo 1530]; e dal papa incoronato a re d’Italia e imperatore Carlo V [22 febbraio, 24 marzo 1530]. Questo congresso di Bologna fu quasi placito imperiale a modo de’ Carolingi.—E rifatti cosí amici imperatore e papa, rimasene abbandonata a questo la misera Firenze. Ella avea gia cacciati i governanti medicei, s’era rivendicata in libertá fin da dieci di dopo la presa di Roma [16 maggio 1527]. Ed erasi poi ordinata in repubblica meglio forse che non fosse stata mai; aveva quell’armi proprie, ordinate un vent’anni prima per consiglio di Machiavello. Fortificò allora, afforzò sue mura; ed a tale opera venne, abbandonando Roma e i lavori e l’arte, bell’esempio, Michelangelo. Peccato che tutto questo spirito militare fosse nuovo in lei! Anche qui era troppo tardi. Fu causa che non avesse capitano di nome, che non conoscesse uno de’ propri cittadini, il Ferrucci, di ciò forse capace. Così fu ridotta a cercarsi, ad assoldare un capitano forestiero, Malatesta Baglioni. Il quale poi, fosse traditor veramente, o forse ingiustamente venutone in sospetto, ad ogni modo, fu perdizione ultima di quella città, troppo a lungo rimasta imbelle. Venne contro per il papa l’Oranges, a capo di quelle stesse bande che aveano testé saccheggiata Roma. Ai 14 ottobre 1529, pose campo dinanzi a Firenze, ai 10 novembre die’ un primo assalto, e fu respinto. Ai 15 dicembre morí nel campo imperiale quel Gerolamo Morone, il congiuratore per l’indipendenza d’Italia contro all’imperatore! Addì 23 dicembre, per quella pace di Venezia che dicemmo, la misera Firenze si trovò abbandonata dalla secolare alleata. Voltosi l’assedio in blocco, i fiorentini fan due belle sortite addí 21 marzo e 5 maggio 1530. Addì 27 aprile, il Ferrucci, che teneva fuori la campagna, prende Volterra; e la difende poi contro agli imperiali, e aduna e muove un esercito di soccorso; e ai 2 agosto, a Gavinana, s’incontra coll’Oranges,[27] e questi v’è morto; ma Ferrucci ferito, preso e finito da Maramaldo, un indegno soldato. Addí 8, il gonfaloniero vuol deporre il Baglioni, ma non è secondato dal popolo giá stanco; si divide, s’indebolisce la difesa; e addí 12 agosto, capitola la cittá. Cosí, dopo una difesa di dieci mesi, che sarebbe bella in qualunque tempo, che fu bellissima, unica in questi, cadde non indegnamente quella cittá, quella repubblica di Firenze, che vedemmo, a malgrado gli errori, la piú nobile, la piú gentile, la piú alta, la piú guelfa, la piú nazionale di tutte, all’etá de’ comuni. Ella aveva, nella sua politica tutto nazionale, imitata bene quella Roma antica che le fu proposta sovente a modello da’ propri scrittori, dal Villani fino a Machiavello. Ma che serve? ella non seppe imitare la virtú militare romana. Ella mostrò in quest’ultimo assedio, ella aveva mostrato, dugento anni prima, in quello d’Arrigo di Lucemburgo, ch’ella non mancava di tal virtú naturalmente. Ma in que’ dugent’anni tramezzo, scacciata sua aristocrazia militare, e postasi sotto a una aristocrazia tutta commerciante, sotto i Medici commerciantissimi, ella aveva neglette, sprezzate, pagate l’armi; e l’armi pagate le fecer fallo al dí dell’ultimo bisogno. Né d’allora in poi, né trecento e piú anni corsi fino ai nostri dí, si combatté mai piú per lei, né intorno a lei. Ella non esercitò, non vide nemmeno piú mai il viril gioco dell’armi; ed ella ne rimane piú disavvezza che niuna forse delle cittá cristiane, abitate dall’audace schiatta di Giapeto.—Un Valori ed altri palleschi la governaron presso ad un anno tra gli esigli e i supplizi. Addí 5 luglio 1531, venne Alessandro de’ Medici, bastardo di quel Lorenzo che era stato duca d’Urbino; e tiranneggiò con nome di principe e duca, fatto ereditario per decreto da Carlo V, e marito ad una figliuola sua bastarda. Intanto, papa Clemente dava Caterina, figliuola legittima di quel medesimo Lorenzo, a un figliuolo di Francesco I, che fu poi re Enrico II di Francia [27 ottobre 1533]; e perciò venne egli stesso a Nizza e Marsiglia. E cosí barcheggiando, ed aiutandosi di Francia ed Austria, Clemente VII avanzava sua famiglia, e doveva esserne satisfatto oramai. Morí addí 25 settembre 1534. Da cardinale e ministro di suo zio aveva avuta voce di abilitá. E se questa sta in avanzar[28] i suoi, conservolla ed accrebbela. Parve, del resto, principe e pontefice mediocre anche a’ contemporanei, salvo che ad alcuni letterati ed artisti.
7. Paolo III [1534-1549].—Succedette Alessandro Farnese, che prese nome di Paolo III [13 ottobre 1534], sangue d’antichi condottieri, prelato tutt’altro che incolpevole, padre di Pier Luigi ch’ei fece in breve gonfaloniere di Santa Chiesa.—Mutossi, fin da’ primi anni di lui, lo stato d’Italia per due morti. Era morto, fin dal 1533, l’ultimo de’ Paleologi marchesi di Monferrato; e pretendendo, come giá anticamente, i duchi di Savoia e i marchesi di Saluzzo alla successione, l’imperatore diedela [1536], come di feudo femminino, ai Gonzaga di Mantova, che rimasero poi cosí per piú d’un secolo, terza razza de’ marchesi di Monferrato. Morí poi [I novembre 1535] Francesco II, ultimo Sforza, senza figliuoli; e lasciò il ducato all’imperatore, che come imperatore giá il rivendicava, e l’occupò. Ma sorse Francesco I di Francia a disputarlo; e dopo sette anni di pace si riaprì la solita guerra. Fecesi questa volta meno in Lombardia che in Piemonte. Nel quale, al duca fanciullo Carlo II che dicemmo regnante nel 1494, erano succeduti Filippo II [1496], Filiberto II, detto il bello [1497], e Carlo III il buono [1504], infelici principi tutti: che avean sofferto con pazienza l’andar e venir degli eserciti francesi, tedeschi e spagnuoli. Ma or fu peggio; ché, piú forte, l’imperator duca di Milano rattenne la nuova guerra fuori del ducato, e quasi tutta in Piemonte. I francesi occuparono Savoia, Torino e mezzo Piemonte [1536]. Duca Carlo s’alleò coll’imperatore, e questi occupò il resto. Più forti gli imperiali, fecero nuovamente una punta in Provenza, ma furon respinti, e guerreggiossi di nuovo in Piemonte nel 1537. Fecesi in Nizza, nel 1538, una tregua di dieci anni, che durò appena quattro. Guerreggiossi di nuovo; e turchi e francesi, bruttamente insieme, assalirono e predarono Nizza [1543]. Poi, i francesi diedero a Ceresole una gran rotta agl’imperiali [14 aprile 1544]. Ma minacciati dappresso in Francia, facevasi pace a Crespi tra le due potenze straniere [18 settembre]; e rimanevano duca di nome Carlo III,[29] ed occupato, parte da’ francesi, parte dagl’imperiali, il misero Piemonte: misero, ma tra quegli strazi, temperantesi fin d’allora all’armi, ad ogni fortezza.—Nuova mutazione succedeva intanto nella tiranneggiata Firenze. Alessandro, duca, non avea piú a protettore lo zio papa, ma lo suocero imperatore, e s’infangava in persecuzioni e libidini. I fuorusciti moltiplicati ricorsero all’imperatore a Napoli; il Nardi storico liberale orò lor bella causa; il Guicciardini, quella brutta del tiranno [1536]. Il quale n’ebbe, somma e non insueta fra le vergogne italiane, quella d’essere ammonito a moderazione dagli stranieri. Ma (anche in ciò non insueto) l’ammonito continuò. Tuttociò fini per una di quelle scelleratezze miste di barbarie e letteratura, che eran del tempo. Compagno, anzi mezzano del tiranno a sue sfrenatezze, era un cugino di lui, discendente da Lorenzo fratello di Cosimo padre della patria, detto pur Lorenzo o Lorenzino o Lorenzaccio, ed anche il «filosofo», perché pizzicava del letterato e del miscredente. Costui trasse il duca in sua casa, in sua camera, dove promise condurgli una bella e virtuosa gentildonna; ed assistito da Scoronconcolo, un bravo, ivi lo pugnalò e scannò [6 gennaio 1537]. Poi lasciando il cadavere nel letto con una polizza d’una citazione latina sul capo («Vincit amor patriae laudumque immensa cupido»), fuggì spaventato, come giá l’uccisor di Giuliano, a Bologna e Venezia. Questo pretendere alti fini a bassissimi misfatti è cosa volgare. Più rara (ma pur veduta in novembre 1848) ottenerne le lodi pretese; e toccò tal sorte a Lorenzino. Fu lodato in versi e in prosa, paragonato a Bruto; non mai furono sconvolte tutte le idee morali e politiche come in quel secolo. Quanto poi a restaurar la repubblica, quasi non se ne parlò; e tre dí appresso fu fatto capo e principe Cosimo de’ Medici, un altro discendente di quel medesimo fratello di Cosimo, un figlio di Giovanni dalle bande nere, un giovane di diciannove anni, quasi un Cesare Augusto in piccolo; il quale fatto duca dall’imperatore, e piú tardi granduca dal papa [1569], fu stipite di que’ secondi e minori Medici, che signoreggiaron Toscana due secoli giusti or con mediocritá ed or peggio.—E in questo medesimo anno 1537 incominciò[30] Paolo III a far grande Pier Luigi Farnese. Fecegli un ducato di Castro e Nepi; l’anno appresso ottenne dall’ imperatore che gli facesse un marchesato di Novara; e finalmente [agosto 1545] gli fece un ducato di Parma e Piacenza. Ma costui vi tiranneggiò a modo di Alessandro in Firenze; ed a modo di lui [10 settembre 1547], finí trucidato da alcuni gentiluomini piacentini. Accorse Ferrante Gonzaga governatore di Milano per l’imperatore, e prese Piacenza. Ma in Parma fu gridato duca Ottavio figliuolo di Pier Luigi, giá duca di Camerino e che avea sposata Margherita la vedova di Alessandro de’ Medici, la bastarda di Carlo V; e contesesi a lungo con negoziati e guerre per quella successione. Anche Lucca e Genova (trascurando alcune minori) ebbero lor congiure. Perciocché io m’ingannai forse a dir etá aurea di esse quell’altra di ottanta anni addietro. Anche questa ha il suo merito, e può competere e giustificare chi ce ne dà vanto.—A Lucca, serbatasi in governo repubblicano, era gonfaloniero nel 1546 un Burlamacchi. Sognò una serie di quelle restaurazioni di libertá, che sono tanto piu difficili a farsi che non le stesse restaurazioni di principati. Con duemila uomini apparecchiati a’ suoi ordini, ideò liberar Pisa da Firenze, Firenze dal Medici, tutte le città di Toscana, e poi quelle del papa, e, chi sa? d’Italia intiera. Furono storici che anche a’ nostri di fantasticarono di ciò che sarebbe avvenuto, se fosse avvenuta la riuscita di questa congiura, che non poteva avvenire. Perciocché, insomma, ella finí come tutte le congiure che per necessità dello scopo sien numerose. Fu tradita; e l’autore preso, mandato a Milano, torturato, decollato. In Genova poi preparossi a lungo, scoppiò ai 2 gennaio 1547, Luigi Fieschi contro Andrea Doria il liberator della patria, che non l’avea voluta tiranneggiare, e contra Giannettino nipote di lui che tiranneggiava sotto l’autorita di lui. Fu trucidato Giannettino; ma morivvi anche il Fieschi, cadendo in mare; e la congiura finí coi soliti supplizi.—Moriva Francesco I di Francia nel marzo 1547; e succedutogli Enrico II suo figliuolo, il marito di Caterina de’ Medici, apparecchiava nuova guerra contra Carlo V. E volgevasi a lui Paolo III indispettito per Parma.[31] Ma morí [novembre 1549]. I fatti parlano; non è mestier di dir qual fosse in politica; nepotista e non piú. Fu protettor d’arti e lettere anch’egli. Cresciuta intanto la gran calamitá cristiana, la Riforma, e divise dalla Chiesa mezza Germania e quasi tutta Inghilterra, era da riformati e cattolici altamente chiesto un concilio fin dal tempo di Clemente VII. Ma, tra la poca voglia che n’avea questi e il disturbo delle guerre, ei non ne fece altro. Paolo III il convocò prima a Mantova [1537], poi a Vicenza, finalmente a Trento [1542]. Ma non s’apri in effetto costí, se non addí 13 dicembre 1545; e fu trasferito poi a Bologna [11 gennaio 1547]. Morí Lutero a’ 18 febbraio 1546. Addí 27 settembre 1540, Paolo III approvò la Compagnia di Gesú, instituita giá a poco a poco da sant’Ignazio di Lojola con pensiero generoso ed adattatissimo al secolo, di servire e quasi militare per la Chiesa cattolica, per la santa Sedia, nuovamente assalite. Il pensiero disinteressato, ed ispirato dalle condizioni del secolo, fu fecondo. Ai limiti della cristianitá per dilatarla, tra le popolazioni volgentisi all’eresia per rattenerle, furono fatte opere grandi dalla Societá incipiente. Altre alzaronsi, come succede delle cose opportune, col medesimo pensiero: i teatini, i barnabiti, i somaschi. Ma le Societá di Gesú le superò tutte in operositá ed utilitá. E chi, mosso dalle moderne ire non voglia credere a me, creda al Ranke, al Macaulay ed altri scrittori acattolici, in cui sono cessate quell’ire.—Guerreggiò Venezia di questo tempo, ma per poco e senza frutto, contro ai turchi.
8. Giulio III, Marcello II, Paolo IV [1550-1559].—Quel nepotismo dei papi La Rovere, Borgia, Medici e Farnese, che si potrebbe chiamar «nepotismo primo», o massimo, o politico, e consisteva in voler ogni papa formare un principato alla famiglia, cessò colla morte di papa Farnese. D’allora in poi i papi non fecero piú Stati politici ai nepoti, si contentarono di far loro grandi fortune private; passarono al nepotismo secondo, o minore, o privato. Naturalmente il nepotismo politico era vizio che si consumava da sé; conceduti gli Stati concedibili, non ne rimanean piú; il concedere i rimanenti diventava piú difficile, piú scandaloso, piú spogliator della Chiesa romana. Nol vollero? ovvero[32] nol poterono i papi seguenti? Fu bontá in essi o necessitá il non farlo? Io crederei l’uno e l’altro; la necessitá buona fece la bontá, fece elegger uomini buoni. Il fatto sta, che con Paolo III finirono que’ papi della fine del secolo decimoquinto e del principio del decimosesto, che, comunque paiano piú o meno cattivi principi, furono certamente quasi tutti cattivi ed alcuni scandalosi pontefici; e che incomincia quindi una serie nuova e diversa di papi, quasi tutti o forse tutti buoni pontefici, ed anche migliori principi rispetto a nepotismo, cattivi solamente per quella che dicemmo quasi necessitá della politica austriacata. Giulio III [Del Monte, succeduto 18 febbraio 1550] fu giá men nepotista in ciò, che non si volse, per trovar luogo ai propri nepoti, contra il principato fatto dal predecessore, anzi confermò lo Stato ai Farnesi.—Succedette Marcello II [Cervino, 9 aprile 1555], papa buono e troppo poco durato, tutto inteso a terminar le guerre che impedivano le riunioni della cattolicitá, del concilio, e della cristianitá.—Succedette Paolo IV [Caraffa, 23 maggio 1555], santo papa istitutor de’ teatini, paciero, desideroso anch’egli di riunire la cattolicitá e il concilio; e nepotista, per vero dire, ne’ suoi principi, ma che io conterei volentieri tra’ papi men cattivi politici, perché napoletano, e vivo quindi al dolore di vedere il Regno diventato provincia austriacospagnuola, si volse a Francia. Ma morí addí 18 agosto 1559; e cosí pochi mesi dopo aver veduta confermata la signoria spagnuola nel Regno, in tutta Italia.—Perciocché durante tutti tre questi pontificati si combatté tra Francia ed Austria quella lunga ed infelice guerra che doveva confermar la servitú nostra. S’aprí per Parma, che Francia voleva del Farnese e l’imperatore non volea: ma s’estese poi, e si fece piú grossa in Germania, dove Francia protesse i riformati. In Italia non furon guari grandi fazioni. Siena che era stata ab antico quasi sempre imperiale e ghibellina (naturalmente, posciaché la vicina ed emula Firenze era stata guelfa), oppressa ora dagli imperiali e minacciata da Cosimo duca di Firenze, passò a’ francesi, che v’entrarono [11 agosto 1552], e ne fecero lor piazza d’arme nell’Italia media. Ma arse principalmente la guerra nell’Italia settentrionale, in[33] Piemonte. Nemmen qui con grandi fazioni; si ridusse a quelle piccole e moltiplici che piú dell’altre rovinano un paese. Brissac, capitano francese, Gonzaga imperiale vi predarono a gara, lasciarono una memoria funestamente popolare fino a’ nostri dí. E, secondo l’uso pur de’ nostri dí, piú gravi parvero i saccheggi, le oppressioni degli imperiali alleati che de’ francesi nemici. E morí tra tutte quelle miserie il duca Carlo III in Vercelli dove s’era ritratto da un pezzo [settembre 1553]. Detto il «buono», avea regnato presso a cinquant’anni, troppo buono di fatto, debole, oppresso, infelice. Succedettegli Emmanuele Filiberto, tutto diverso, uno anch’egli di que’ principi di Savoia, o quegli forse che piú di nessuno, seppe, operando secondo i tempi, farsi grande. Figlio di principe spogliato, andò come i maggiori a guerreggiar fuor di casa; ma non a modo antiquato, alla ventura, anzi al modo nuovo regolare, e vi diventò capitano e gran capitano.—Intanto Cosimo tentava sorprendere Siena, ma non gli riusciva [27 gennaio 1554]. Veniva allora un esercito spagnuolo ad assediarla, affamarla. Si rinnovava l’esempio di Firenze. Anche Siena e i francesi che v’erano fecero una bella difesa. Ma anch’essa cadde [2 aprile 1555]; anch’essa non vide mai piú guerra intorno a sé; come Firenze, come Pisa, Toscana tutta. Ed anche in essa seguirono supplizi ed esigli, e cessò il governo repubblicano; e anch’essa fu data in breve a Cosimo duca di Firenze [19 luglio 1557].—Intanto, essendo ormai la guerra senza risultati in Italia e Germania, facevasi, addí 5 febbraio 1556, una tregua a Cambrai. Dopo la quale, stanco d’affari, di guerre, di contese, di fortuna (perciocché questa pure stanca quando non è congiunta con qualche gran pensiero, che uno prosegua o creda proseguire a benefizio della patria, o della cristianità o del genere umano), Carlo V rinunziò l’imperio con gli Stati di Germania a Ferdinando I suo fratello; e quelli di Spagna, America, Paesi bassi, Borgogna, Sardegna, Due Sicilie e Milano, a Filippo II figliuol suo. Certo non furono le convenienze de’ popoli quelle che fecero cosí dar Lombardia a Spagna lontana, anziché ad Austria piú vicina. Ma allora e per gran tempo non furono, non sono le convenienze de’ popoli, ma[34] quelle de’ principi, che si chiamarono e si chiamano «ragioni politiche». Durerà? Io ne dubito ormai.—Ruppesi quindi tra breve la tregua, rinnovossi la guerra tra Enrico II di Francia, e i due Austriaci Ferdinando imperatore e Filippo. Qui fu che papa Paolo IV s’accostò a Francia. E quindi un esercito francese scese sotto il duca di Guisa a cacciar gli spagnuoli dal Regno; e s’ampliò allora la guerra per tutta la penisola di nuovo. Ma facevasi molto piú grossa nelle Fiandre; ed Emmanuel Filiberto, capitano dell’esercito spagnuolo, vinceva l’esercito francese in gran battaglia a San Quintino [10 agosto 1558], e minacciava Parigi. E quindi, guerreggiatosi lá e in Italia poco altro tempo, conchiusesi finalmente, addí 3 aprile 1559, la pace a Cateau-Cambrésis. Né furono guari diverse le condizioni di questa pace da quelle della pace di Cambrai di trent’anni addietro: il Piemonte stesso, restituito al duca vittorioso, non fu del tutto sgombro di stranieri, e l’Italia rimase legata, mani e piè, Lombardia e Napoli, a casa d’Austria. E ne rimasero pur troppo piú durevoli gli effetti: per centoquarant’anni Francia non contese piú un po’ fortemente l’Italia all’emula antica; l’Italia non fiatò piú sotto all’incontestata servitù.
9. Colture di questo periodo [1492-1539].—Noi ci scarterem quinci innanzi dal nostro uso di aspettar il fine di ogni grande etá per accennar tutta insieme la coltura di essa; accenneremo via via da sé quella d’ognuno dei periodi in cui subdividiamo questa ultima etá. E ciò faremo, perché, appressandoci a’ tempi nostri, noi pensiamo che sieno piú chiare, piú alla memoria dei leggitori le suddivisioni, e possa cosí essere loro piú grato aver tutto compiuto, politica e coltura, il cenno di ciascuna di esse.—Qui dunque in questi sessantasette anni noi vedemmo peggiorar piú che mai la politica italiana, sviata sì ne’ secoli scorsi dal sommo scopo dell’indipendenza, ma sviata almeno a quello della libertá; mentre qui all’incontro ella non ebbe piú scopo nessuno, e, salve poche eccezioni, non fu piú politica nazionale, ma provinciale, la pessima di tutte per qualunque nazione, la piú stolta per una, che ha tante comunanze di schiatte e di lingua, tante solidarietà d’interessi e di bisogni. Ma se si dicesse[35] ciò solamente, ne rimarrebbe incompiutissima l’idea di questo periodo, di politica pessima sì, ma di coltura la piú splendida fra quante furon mai da Pericle a’ nostri dí. Del resto, noi spiegammo giá siffatto contrasto: tutti gl’impulsi eran giá dati, tutti gli uomini giá nati e piú o meno educati, quando incominciò questo periodo; impulsi ed uomini non potevano cessare a un tratto; il fior maturato al tempo piú sereno, doveva fruttificare a malgrado la tempesta. E tanto piú, che mentre venivasi distruggendo ogni indipendenza e libertá nazionale, rimase pure per qualche tempo molta libertá personale; che chi era oppresso dagli uni trovava libertá, operosità presso ad alcun altro, presso a quegli stessi stranieri, i quali (a ragione allora, e relativamente a’ nostri avi) furon detti «barbari», ma che pur ammiravano, promovevano e venivan prendendo le nostre colture. E cosi in somma sorse quello che noi chiamammo giá «baccanale», ma che qui diremo elegantissimo baccanale di coltura; un rimescolio di scelleratezze e patimenti e solazzi, per cui l’intiera Italia del Cinquecento si potrebbe paragonare alla lieta brigata novellante, cantante ed amoreggiante in mezzo alla peste del Boccaccio; se non che qui, oltre alla peste, eran pure le ripetute invasioni straniere, le guerre, i saccheggi, le stragi, i tradimenti, le pugnalate e i veleni; ed oltre ai canti e alle novelle, ogni genere di scritture e di stampe, e pitture e sculture e architetture, ogni infamia, ogni eleganza, ogni contrasto. Noi vecchi rammentiamo un tempo minore, ma simile, quello dell’ultime invasioni francesi; simili i due in que’ contrasti, e simili anche in ciò, che nell’uno e nell’altro tutte le colture erano frutti, tutti gli uomini erano figli del secolo precedente. Così non si assomiglino intieri i due secoli decimosesto e decimonono! cosí non vengano scemando via via gli splendori del secondo, come siam per veder del primo!—Se non che, la libertá nuovamente sorta in Italia, e giá radicata in Piemonte, pare assicurarci oramai da quest’ultima somiglianza. Il sole risorto della libertá non può non maturare nuovi e migliori frutti di coltura.—E tornando a quelli del Cinquecento, noi incominciamo dalle lettere, dalla storia o politica scritta, vicina alla pratica, e dallo scrittor piú vicino,[36] Machiavello. Fu in gioventù tutto uomo di pratica, colto, non letterato. A’ ventinove anni [1498?] ebbe carico di secondo segretario della repubblica fiorentina ricostituita; e tennelo sotto il Soderini gonfaloniere fino al ritorno de’ Medici, quattordici e piú anni in tutto; andando nel frattempo a ventitré legazioni, al re di Francia, all’imperatore, al papa, al duca Valentino, e ad altri di que’ perversissimi politici. I dispacci (belli, brevi, semplicissimi del resto) che rimangon di lui lo mostrano poco diverso da coloro; non è meraviglia, né grande scandalo. Venuti i Medici, e cacciato esso dall’ufficio, accusato di congiura, imprigionato, collato, e liberato per protezione di Leon X, non sentì, o almeno non mostrò l’ira di Dante contro a’ persecutori, diventò mediceo, pallesco; ed è pur caso volgare. Desiderò rientrar in uffizio, servire il nemico del governo che aveva servito, il principato dopo la repubblica; volgarissimo. Ma negletto, fece uno scritto, un memoriale politico, che dedicò ai Medici e non pubblicò; e il libro è quello del Principe che ognuno sa, e dov’è accennato sì un grande scopo colle famose parole di Giulio II, «liberar l’Italia da’ barbari»; ma dove i mezzi son quelli de’ principi, de’ popoli, della politica d’allora, astuzie, perfidie, violenze, vendette, crudeltà; e qui la colpa diventa grave, immensa, e nella perversità e negli effetti; nella perversità, la quale è sempre le mille volte maggiore in chi scrive che in chi opera perversamente, perché non ha le scuse, gli allettamenti della pratica; negli effetti, perché a pochi uomini, grazie al cielo, è dato far mali durevoli nella pratica rinnovantesi da sé, mentre durano generazioni e generazioni i mali fatti con un libro immorale. Gran semplicità parmi poi quella disputa letteraria fatta e rifatta: qual fosse l’intenzione dell’autore? Chiare dalle parole di lui mi paion due: una personale e bassa, ingraziarsi co’ principi distruttori della repubblica da lui servita; l’altra pubblica ed alta, l’indipendenza; ma peggio che mai avvilita la prima, deturpata la seconda dagli scellerati mezzi proposti. Perciocché allora, come prima, come poi, come sempre, come ultimamente, l’indipendenza non poté, non può, non potrà mai procacciarsi con questi mezzi; anzi nemmeno con quelle[37] destrezze, e doppiezze, ed abilità buie, e segretumi che sono il meno male della politica di Machiavello. Non si rivendica né si tiene in libertá una nazione colla furberia, vizio da servi o tiranni. Le imprese d’indipendenza son quelle fra tutte che vogliono piú unanimità; e questa, grazie al cielo, grazie a ciò che resta di divino nella natura umana, non s’ottiene mai se non colla virtù franca, chiara, pubblica, e quasi direi grossa, o sfacciata. E quindi (mi sia tollerato il dirlo di questa, che pare a molti una delle somme glorie nazionali) io non crederei che sia stato mai un libro cosí fatale ad una nazione, come il Principe all’Italia: ha guastate e guasta le imprese d’indipendenza. V’ha un’impostura, un’ipocrisia delle scelleratezze in molti che senz’essa sarebbon buoni; s’immaginano che la politica non possa esser pratica senza essere scellerata, o almeno buia; e costoro sono confermati in tal errore da quell’autorità e quel codice. E tanto piú, che piú bello è lo scopo proposto in esso; tanto piú, che Machiavello, disgustato de’ Medici, scrisse poscia molto meno scelleratamente ne’ Discorsi, nelle Storie; e tanto piú, che in tutte l’opere sue egli è poi lo scrittore, piú, o quasi solo semplice, piano, naturale, lontano dal periodar pedante; il piú elegante, in somma, e migliore di tutti gli antichi nostri prosatori, senza paragone. Del resto, il gran politico ebbe pure disgrazia fino al fine. Fu finalmente impiegato da’ Medici; ma poco prima di lor nuova caduta del 1527. Ebbe fortuna in ciò, che non sopravisse se non pochi dí [morto 22 giugno]; non ebbe tempo a mutar una o due altre volte colla fortuna. Fece un bene vero, ma non durevole; predicò, promosse, ordinò armi proprie nella imbelle sua città, e scrissene il libro Della guerra. Una vita di Machiavello, fatta virilmente, senza la trista e solita preoccupazione di difender ogni cosa, ogni uomo italiano, sarebbe una delle opere piú utili da farsi ora, per la formazione della politica patria presente ed avvenire.—Francesco Guicciardini [nato 1482] barcheggiò egli pure, servendo prima la repubblica fiorentina al tempo del Soderini, e poi i Medici a cui rimase fedele. Certo che questa era la parte men generosa; pur meno male, poteva credere fosse oramai la sola possibile a[38] Firenze. Ma fu bruttissimo il suo servire, e con zelo, e contro a’ fuorusciti, il tiranno Alessandro. Alla morte di costui, Guicciardini fu principale nel dar il potere al duca Cosimo, giovanetto ch’ei credea governare; ma nol governò; e fu deluso cosí, anche questo politico provetto. Il fatto sta, che fin d’allora sarebbe stata piú facile sempre, e piú utile sovente, quella rettitudine la quale si vien facendo sola possibile in questa nostra civiltà e pubblicità universale. Ad ogni modo, Guicciardini si ritrasse in villa, e scrisse in un anno o poco piú quella storia de’ tempi suoi, che ha nome di prima fra le italiane; che per gravità, acutezza, informazioni e libertá merita senza dubbio gran lode; e che può biasimarsi sì come mancante di politica virtù, e indifferente tra il male e il bene, ma che non cade almeno nello sfacciato lodare e proporre il male, di Machiavello. Parmi bensì molto inferiore nello stile, in tutto il modo di scrivere, lungo, intralciato, latinizzante; se non che, essendo morto l’autore in questo lavoro [27 maggio 1540], ciò che n’abbiamo non è se non l’abbozzo di ciò a che egli l’avrebbe ridotto, se avesse avuto tempo ad esser breve e limpido; ondeché è meno a biasimare lui, che non quegli imitatori, i quali imitano qui, non solamente, come al solito, i difetti del loro autore, ma quelli di un rozzo abbozzo di lui.—Non abbiam luogo a dir degli altri storici fiorentini. Nardi [1476-1540], Nerli [1485-1556], Segni [-1558], Varchi [1502-1565], men famosi forse, men grandi che i due detti, ma piú virtuosi, piú generosi, il Varchi sopra tutti.—Il Davanzati [1529-1586], piú giovane di tutti questi, cadde in un’affettazione contraria a quella del Guicciardini e di altri cinquecentisti. Traduttor di Tacito, volle essere piú breve di lui, che è impossibile senza farsi oscuro. E cadde in quella fiorentineria giá affettata da altri, ma meno male perché almeno in cose facete. E l’una e l’altra affettazione accennavano giá quella brama di novitá, che, quando viene al fine di un gran secolo, suol produrre corruzione; erano preludi al seicentismo. Borghini si volgeva intanto alla storia antica, erudita; come si suole in tempi di servitù, di censure. Tutti questi nella sola e ferace Firenze.—E di storia e politica[39] scrivevano intanto nell’altre parti d’Italia, Bembo [1470-1547], Paolo Giovio [1483-1552]. Giambullari [1495-1564], Costanzo [1507-1591], Adriani [1513-1579], Foglietta [1518-1581], Sigonio [1520-1584], Bonfadio [m. 1550], Ammirato [1531-1601], oltre parecchi altri minori. Grandi ricchezze storiche, come si vede, e che superano di gran lunga quanto si scriveva allora fuor d’Italia; come gli storici stranieri piú liberi e piú misti a pratica superano ora noi, pur troppo. S’aggiunsero le storie pittoriche e gli altri scritti degli artisti, genere quasi esclusivamente nostro. Benvenuto Cellini [1500-1570] e Vasari [1512-1574] sono noti a tutti; piacevolissimo il primo, ma rozzo e partecipe de’ vizi dell’etá sua; scrittore semplice e sciolto il secondo, e tutto inteso a ciò che narra e tratta, senza pretese né imitazioni pedanti (salvo in alcuni proemi che non son di lui); ondeché gli scritti suoi rimangono de’ piú eleganti di nostra lingua. E insieme con quelli di Leonardo da Vinci, sono poi un vero tesoro di tradizioni artistiche di quel secolo aureo dell’arti.
10. Continua.—Né furono meno numerosi o meno splendidi i poeti. Primo senza contrasto Ludovico Ariosto [1474-1533], un vero incantatore, che toglieva sé e toglie noi al tristo mondo reale per portarci in uno imaginario e tutto ridente; precursore di Walter Scott per le eleganze, di Cervantes, Molière e La Fontaine per quel celiar semplice, non amaro, quel celiar per celiare, che essi quattro intesero sopra ogni altro di qualunque tempo o paese. Né gli mancò il ridere utile, correttor di vizi; scrisse comedie e satire; ma fu minore in queste; la sua natura era indulgente, od anche indifferente. Non accrebbe, è vero, come Dante, il tesoro de’ pensieri nazionali; ma oltre all’utilità letteraria, una morale e politica è forse nelle eleganze che salvano da bassezza, dalla quale le nostre lettere, e massime le facete, non si salvarono sovente. Ad ogni modo, sommo in suo genere, sovrasta alla severità della critica.—E gran celiatore, ma quanto minore! fu il Berni [-1536]. E minori gli altri poeti (prosatori pure), Rucellai [1449-1514], Sannazzaro [1458-1530], Bibbiena [1470-1520], Trissino [1478-1550], Guidiccioni [1480-1541], Molza [1489-1544], Bernardo Tasso [1493-1569], Alamanni[40] [1495-1556], Della Casa [1503-1556], Annibal Caro [1507-1556], oltre quasi tutti quegli altri che nominammo tra’ prosatori, ed altri che non nominiamo di niuna maniera. I quali tutti insieme poetando o rimando in tutto questo tempo, empierono poi que’ Canzonieri o Parnasi o Raccolte, che paiono a molti una delle glorie italiane, perché essi soli sanno almeno divertire. Pare ad altri all’incontro che la poesia non ammetta mediocrità; e che l’inutilità non sia scusabile se non nei sommi. Come donna, e cantante un amor vero e virtuoso, sovrasta forse Vittoria Colonna, moglie del traditore marchese di Pescara [1490-1547]. E sovrasta per infamia Pietro Aretino [1492-1572], prosatore e rimator mediocrissimo, anzi cattivo, e per le cose scritte e per il modo di scriverle, empio, lubrico, piaggiatore e infamatore insieme, che si fece un’entrata, una potenza col vendere or il silenzio, or le adulazioni. È vergogna del secolo che lo sofferse, lodò e pagò e chiamò «divino».—Del resto, avendo detto della storia e della poesia e cosí dei due generi di letteratura in che questo tempo fu grande, non ci rimane spazio a dir di quelli in che fu solamente abbondante. Se ci mettessimo a nominar gli oratori piú o meno retori, perché non aveano a discutere interessi reali dinanzi a un’opinione pubblica potente; i latinisti, meravigliosi se si voglia per li centoni che fecero delle frasi antiche, ma appunto perciò piú o men retori essi ancora; i grammatici di lingua italiana, piú utili senza dubbio, ma timidi ed incerti perché nostra lingua mancò sempre d’un centro d’uso, e poco logici perché poco logico era stato il secolo delle origini, e meno logico era questo; i novellatori, piú o meno imitatori e sconci, come i modelli e il secolo; i moralisti, come il secolo leggeri, attendenti a convenienze e cortigianerie piú che a principi sodi, ed anche meno ai virili e meno ai severi; e gli scrittori che trattarono di filosofia piú letterariamente che scientificamente, e si scostarono da Aristotele per cadere in Platone, ma meno nel Platone vero interprete degli immortali dettami di Socrate, che in un platonismo spurio e intempestivo; se, dico, noi nominassimo tutti coloro che gli esageratori de’ nostri primati ci dan come grandi, noi avremmo a rifare parecchie nomenclature molto piú lunghe[41] che non le fatte. Ma il vero è, che qui, piú che altrove, è a distinguere tra le grandezze relative e le positive. Che le lettere nostre del Cinquecento sieno state di gran lunga superiori a quelle contemporanee e straniere, è indubitabile; ma che elle rimangano superiori od anche eguali alle straniere piú moderne, e che perciò elle debbano imitarsi ora di preferenza o per la loro eccellenza o per dover nostro di nazionalità, ciò non è vero e non può essere; perché non può essere che i secoli progrediti non abbiano prodotte letterature migliori e piu imitabili, che i secoli piú addietro; perché il nostro primato di tempo esclude appunto il primato di eccellenza; e perché poi, quanto a nazionalità ella non consiste nel non ammirar né imitar se non le cose giá nazionali, ma anzi a far nazionali quelle buone che non sono. Se Alfieri e Manzoni avessero cosí inteso il dovere di nazionalità, essi non avrebbero aggiunto la tragedia e il romanzo ai tesori vecchi delle lettere italiane.—Né in filosofia materiale si progredì guari allora in Italia. Questo è il tempo di Copernico polacco [1473-1543]; e dicesi che la teoria di lui non fosse anche prima di lui sconosciuta in Italia; ma il fatto sta che gli astronomi d’Italia furono allora poco piú che astrologi, e son famosi quelli di tutti i principotti italiani e di Caterina Medici ed altri, che infettaron l’Europa di lor ciurmerie. Ed anche costoro vi ci diedero e lasciarono cattivo nome. La medicina fu forse delle scienze naturali quella che fece piú veri progressi. Eustachio Rudio [prima del 1587], il Colombo [-1577] e il Cesalpini [1519-1603] ed altri, insegnarono piú o meno fin d’allora in Italia la circolazione del sangue. Harvey, inglese, la dimostrò piu ampiamente, e divolgò poi [1619], e cosí n’ha gloria. Dicono i nostri: ingiustamente. Ma io non entrerei in siffatte dispute, quand’anche n’avessi luogo. Quasi tutte le grandi invenzioni furono fatte a poco a poco, cioè da parecchi in parecchi tempi e luoghi: ondeché la storia sincera di ciascuna può bensì riuscir piacevole ed utile elucubrazione a meglio intendere lo spirito umano, ed istradarlo ad invenzioni ulteriori; ma appunto non può forse esser fatta tale storia sincera, se non ismettendo le pretese personali, municipali e nazionali. Le quali poi chi rialza per farne una gloria,[42] mi sembra farsi per lo piú una grande illusione. Le glorie disputabili non sogliono essere vere glorie; le due parole implicano contraddizione; le certe sole rimangon vere e grandi.—Certe poi sono quelle dei viaggiatori italiani che seguirono Colombo. Amerigo Vespucci fiorentino [1441-1512 o 1516] toccò forse al continente americano prima che Colombo; e sia per ciò, sia perché fece primo alcune mappe delle nuove terre scoperte, ebbe l’immeritato e vano onore di dar loro il nome. Intanto Giovanni Cabotto veneziano e suo figliuolo Sebastiano [nato a Bristol 1467] scoprirono per Inghilterra, e Giovanni Verrazzani fiorentino per Francia, l’America settentrionale. Ma questi furono gli ultimi grandi scopritori e navigatori italiani. La gloria di compiere le scoperte passò d’allora in poi agli stranieri; e cosí ne passò ad essi tutto l’utile. Delle terre date alla civiltà da Colombo, Amerigo, due Cabotti e Verrazzani, non un palmo rimase all’Italia, non una colonia, non un commercio. Questo è forse il segno piú evidente della decadenza italiana, dell’esser passata a un tratto in ozio l’antica operosità di lei. Non basta dire, le scoperte d’America e del Capo, togliendo il commercio al Mediterraneo, lo tolsero all’Italia; bisogna dire, tolto il commercio al Mediterraneo, Italia oziosa non seppe seguirlo nelle nuove vie; e bisogna aggiungere, quand’anche il commercio riprendesse la via antica del Mediterraneo, questo commercio, queste vie, questo Mediterraneo non saranno per nulla dell’Italia, se ella rimane, com’è, oziosa o poco operosa, meno operosa in somma che le nazioni contemporanee. Il mondo è di chi sel prende; cioè degli operosi, cioè di chi opera per sé, cioè degli indipendenti.
11. Continua.—Ripetiamolo pure, e sovente; toltine Machiavello e l’Ariosto, furono abbondanti, anzi che grandi, in questo secolo gli scrittori. Ma gli artisti, abbondantissimi e grandissimi insieme. Qui nell’arte è dove trionfa l’ingegno italiano; qui è innegabile, e conceduto da tutti, il nostro primato. Qui possiamo, anch’oggi, non uscir d’Italia, trovar tra noi tutto quanto è da studiare e imitare. E tutto l’ottimo poi il troviam raccolto nel Cinquecento, anzi in quella prima metà di esso di che qui[43] trattiamo. E quindi non solamente non avremo luogo qui a dir tutti i notevoli, ma nemmeno a nominarli. Accenneremo cinque culminanti intorno a cui si rannoderanno gli altri: Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Tiziano e Correggio. I tre primi, e (se è vero che la purità e l’eleganza, cioè quella che il Vasari chiama «virtù» del disegno, sia la somma dell’arte) i tre sommi, usciron tutti di quella terra e scuola privilegiata di Toscana ed intorno, che dicemmo culla dell’arti italiane. Nato Leonardo in Vinci nel 1452, attese in gioventù all’arti cavalleresche, a tutte quelle del disegno, a musica, a poesia, a matematica, a meccanica. È uno di quegli esempi che ingannano a disperdersi molti ingegni anche presenti, i quali non pensano quanto eccezionali sieno gli uomini enciclopedici, e massime quanto impossibili nelle colture progredite. Oltreché, Leonardo si fermò poi intorno a’ trentacinque anni nell’arti del disegno: e vi giunse al colmo suo (e forse dell’arte) nella Cena che fece a Milano per Ludovico il moro [dal 1494 al 1499], e cosí in quella etá dove tanti altri giá incominciano a stancarsi e scendere. E cosi egli fondò colà la scuola lombarda; in che si vide gran tempo alle fattezze la figliazione fiorentina. Morì l’anno 1519. Furono in quella scuola contemporanei, accerchiatori o seguaci di lui, Cesare da Sesto [-1524], il Luini [-1534?], Gaudenzio Ferrari [1484-1550], Bernardino Lanini [1578], Andrea Salai e parecchi altri minori.—Michelangelo Buonarroti [n. 1474] fu anch’egli «pittor, scultor, architettor, poeta», ma fin dall’adolescenza e nei giardini del magnifico Lorenzo attese all’arti e sopra tutte alla scoltura. Spaziò poscia in tutte e tre, vivendo e lavorando in Roma principalmente. Lasciolla una volta per ira (egli avea del Dante, e fu detto tale nell’arti) contra Giulio II, quell’altro iroso, quel Dante dei pontefici. E fuggito a Firenze, poco mancò che le due ire non guastassero il papa e la repubblica, non fossero uno di piú de’ turbamenti d’Italia. Un’altra volta venuti i due alla ribelle Bologna, e vedendo il papa il modello della propria statua apparecchiatogli da Michelangelo, e che questi gli avea posto nella mano sinistra un libro:—Che libro?—disse,—ponmi una spada, ché io non so lettere.—Poscia guardando la destra:—Dá[44] ella benedizione o maledizione?—E Michelangelo:—Minaccia questo popolo se non è savio.—Ma il popolo non fu savio ed atterrò poi la statua. Meglio un pontefice benedicente, e ribenedetto; dureran serbate da’ popoli le statue sue. Una terza volta, sotto Clemente VII, ei lasciò Roma, come dicemmo, per servir la patria da ingegnere. I freschi da lui fatti in Vaticano serviron di studio all’ultima maniera di Raffaello. Fu geloso di questo, come vecchio di giovane da cui sia superato; e volendo rivaleggiare anche in pittura a olio, a che era poco pratico, s’aggiunse fra Sebastiano veneziano; e i due insieme fecero de’ gran bei lavori, ma men belli che quelli fatti da Raffaello. Più vecchio d’assai sopravvissegli di molto; signoreggiò, quasi tiranneggiò nell’arti a Roma per gran tempo; e morto Antonio da Sangallo [1546], ebbe la fabbrica di San Pietro, dove, ognun sa, pose il Panteon a cupola. Mori nel 1564. I novant’anni di sua vita comprendono tutt’intiera l’etá aurea dell’arti. Quindi in sì lunga vita, ed in una scuola giá cosi antica come la fiorentina, ebbe molti e grandi compagni e seguaci: Luca Signorelli [1440-1521], fra Bartolommeo [1469-1517], il Peruzzi [1481-1536], il Ghirlandaio [1485-1560], Andrea del Sarto [1488-1530], il Rosso [-1541], il Pontormo [1493-1558], il Bronzino [1502-1570], il Vasari [1512-1574], e molti altri che continuarono la scuola fiorentina; e il Francia [1450-1535], che si conta capo della bolognese, figlia cosí essa pure della fiorentina.—All’incontro, passò, quasi celestiale apparizione in bel mezzo alla lunga vita di Michelangelo, Raffaello d’Urbino [1483-1520]. Non enciclopedico, non letterato, raro cultor delle stesse due altre arti sorelle, elegantissimo architetto tuttavia ne’ pochi edifizi da lui fatti, pittor sopra ogni cosa, disegnator come nessuno che si conosca, per l’invenzione, l’espressione, la grazia, la divinità delle figure sue, delle donne principalmente, della beata Vergine sopra tutte. Incominciò in Urbino sotto il proprio padre, pittor non volgare; imparò a Perugia sotto a Pier Perugino [1446-1524], illustre pittore per sé, piú illustre per lo scolaro; innalzossi a Firenze; e chiamato a Roma, superò gli altri, superò Michelangelo, superò se stesso, tre o piú volte, od anzi sempre[45] progrediendo, secondo che lavorava nelle logge e nelle stanze del Vaticano, alla Farnesina, nelle quasi innumerevoli Sante famiglie, e ne’ ritratti, e nello Spasimo, e nella Trasfigurazione, e ne’ disegni che dava a ciascuno, pittori, scultori e incisori, quanti gliene chiedevano, con una liberalitá, che era facilitá ed amore. Amava gli artisti, l’arte, ogni bello che vedesse e faceva suo. Poche anime han dovuto gioir quaggiú come quella. Fece felici quanti gli vissero intorno, e fu fatto felice da tutti. Non un’ira, non una gelosia, un pettegolezzo per parte sua, in tutta sua vita. Poche difficoltá incontrò. Non cercava, era cercato dalla fortuna, da papi, principi, grandi, letterati, uomini e donne. Visse presto, visse poco; morí di trentasette anni [1520]. Gli furon fatte le esequie da Leon X e tutta Roma, colla Trasfigurazione a capo del feretro. E non compagni, ma scolari e creati di lui furono e si professarono i seguenti, tutta quella che è detta scuola «romana»: Giulio Romano [1492-1546] principale fra tutti; Penni o il Fattorino [1488-1528 circa], Giovanni da Udine [1494-1564], Polidoro da Caravaggio [-1546], Perin del Vaga [-1547], Daniele da Volterra [1509-1566], Taddeo Zuccari [-1566] e parecchi altri; i piú de’ quali, dispersi dopo il sacco del 1527, diffusero quello stile e quella scuola non solamente in Italia, ma in Ispagna e Francia: l’Europa colta di quell’etá. Fu qualche compenso ai cattivi nomi fattici da altri.—La scuola veneziana è forse la sola che procedendo anticamente e direttamente da’ greci non abbia avuta origine toscana. Ma i progressi di lei furono molto piú lenti; e gli splendori non v’incominciarono se non da Giovanni Bellini [1426-1516] e Andrea Mantegna [1430-1506]; a cui tenner dietro, nati del medesimo anno, Giorgione [1477-1511] e Tiziano [1477-1576]. Visse questi cosí, a un tempo, e piú che Michelangelo, novantanove anni. Portò sua scuola al sommo subitamente. Il colore, come ognun sa, n’è pregio principale, e grande; ondeché qui forse sarebbe il luogo di gridare contro all’imitazione dagli stranieri, da que’ fiamminghi in particolare che ritrassero senza dubbio molto bene le loro splendide carnagioni settentrionali, ma perciò appunto non bene le meridionali, italiane, spagnuole e greche,[46] piú belle e sole vere incarnate e piú pittoriche; ondeché, per uscir fuori d’Italia, sarebbe meglio andar a Spagna che non a Fiandra od Inghilterra. Tiziano ebbe una gran brutta amicizia, quella dell’Aretino. Salvo in ciò, egli pure fu gentile, dolce e felice uomo in patria ed alle corti di Carlo V e Francesco I; e fece pitture innumerevoli, e ne fu fatto ricco e molto onorato. Del resto, non primeggiò forse in Venezia, come i tre detti a Milano, Firenze e Roma. Furono poco minori di lui, oltre il Giorgione, anche il Tintoretto [1512-1594], e massime Paolo Veronese [1528?-1588]: e seguono piú o men lontani, il Bassano [1510-1592], Palma il vecchio [1518-1574], ed alcuni altri.—Finalmente, Antonio Allegri, detto il Correggio dal nome del suo nativo paese, visse poco [1494-1534], appena tre anni piú che Raffaello. E la vita di lui è quasi ignorata. Par che si trattenesse, e certo lavorò sempre nelle citta vicine a sua culla, Parma, Modena, Bologna. Dove, non essendo per anche una scuola fatta e determinata, egli, studiando da sé e su pochi e vari modelli, fecesi uno stile tutto proprio, e giá poco men che eclettico; come fu quello creato poi ne’ medesimi luoghi un cinquant’anni appresso da’ Caracci. Disegnator poco esatto, ma arditissimo e quasi scientifico, abbondò negli scorci, nel sotto in su, piú e peggio che Michelangelo stesso, giá soverchio in tali ricercatezze. Riman memoria del suo studiar solitario nella tradizione, che vedute le pitture di Raffaello prorompesse in quella esclamazione:—Anch’io son pittore;—la quale fu poi ancor essa consolazione ed inganno a tanti che se la ripeterono. Ma negano alcuni ch’egli uscisse mai da’ suoi contorni. E lá intorno pure fiori il Parmigianino [1503-1540], non dissimile. E gli scolari ed imitatori de’ due si confusero in breve nella vicina scuola di Bologna.—Fiorirono allora, benché non al paro della pittura, anche le due arti sorelle. Nell’architettura (civile o militare) primeggiarono, oltre Michelangelo e Raffaello ed altri detti, il Cronaca [-1509], Bramante [-1514], Giuliano e i due Antoni da San Gallo [-1517-1546], Sanmicheli [1484-1559], De’ Marchi [1490-1574], Tartaglia [1500-1554], Vignola [1507-1573], Paciotto [1521-1591], fra Giocondo [-1625?], e sopra[47] tutti Sansovino [1570] e Palladio [1508-1580].—Nella scoltura, oltre Michelangelo di nuovo e parecchi altri detti, Baccio Bandinelli [1490-1559], il Tribolo [1500-1550], e Benvenuto Cellini [1500-1570], principe degli orefici e gioiellieri di qualunque tempo; e Giovanni dalle Corniole, cosí detto per essere stato primo o principale a rinnovar l’arte dell’incider gemme in cammei ed in cavo. Finalmente, in questo tempo pure si svolse l’incisione in rame e in legno che dicemmo incominciata giá nell’etá precedente; e fiorironvi, oltre il Mantegna, il Francia, il Parmigianino, e Tiziano, Marcantonio Raimondi [1488-1546 o 1550], che incise sovente su disegni di Raffaello, Agostino Veneziano [intorno al 1520], ed altri.—Né lascerem l’arti senza accennar della musica, che ella pure sorse e crebbe dapprima esclusivamente e sempre principalmente italiana. Ma questa rimase per allora lontana dal suo sommo, incominciò allora solamente i suoi progressi. Noi ne vedemmo uno grande fatto nel secolo decimoprimo da Guido d’Arezzo; ed altri ne avremmo potuti notare ne’ secoli decimoterzo e decimoquarto. Nel decimoterzo, i nomi stessi delle composizioni poetiche, sonetti, ballate, canzoni, indicano ch’elle furon fatte per essere accompagnate dalla musica. Nel decimoquarto, abbiamo da Dante e Boccaccio tante menzioni di musica, che, in mancanza di monumenti, dobbiamo argomentare molto coltivata allora quest’arte; oltreché, resta memoria d’un Francesco Landino detto il «cieco», che fu incoronato a Venezia nel 1341, quasi contemporaneamente col Petrarca. Ma d’allora in poi lungo il secolo decimoquinto sorge un fatto curioso, e fors’anco utile a notare in quell’arte: che la musica italiana (probabilmente piana, ricca di melodie fin d’allora, ché tale è il genio nostro nazionale) fu oppressa da quella straniera e piú scientifica de’ fiamminghi o tedeschi. In Roma, in Napoli, nelle chiese, nelle corti tiranneggiaron questi; non si trovan guari mentovati allora altri maestri che questi. Franchino Gaforio [1451-1520?] pare essere stato il primo a restaurar la musica italiana, e dicesi prendesse dagli scrittori greci ed altri antichi gran parte di sua scienza, ma sembra da ciò stesso che fosse scienza o poco piú.[48] all’incontro, dicesi sia stato artista vero ed ispirato il Palestrina [1529-1594]. Dico che si dice, perciocché né io né credo i piú degli italiani udimmo le melodie di lui; e noi abbiamo a invidiar agli stranieri l’uso di far sentire le musiche antiche. E dal Palestrina in poi rimase il primato dell’arte agl’italiani. Né è meraviglia; il sommo di quest’arte sta certamente nella melodia e nell’espressione, o piuttosto nella combinazione delle due, nel trovar melodie espressive; e il modello, il germe delle due non si trova guari in nessuna delle lingue settentrionali, né nel modo di parlarle né nelle inflessioni con cui si parlano; le quali sono od antimusicali del tutto, o molto men musicali che le italiane, e massime che le italiane meridionali. Ad ogni modo, lasciando i progressi tecnici fatti intorno alla metá del secolo decimosesto, noterem solamente, che di quel tempo sono i primi oratorii, inventati, dicesi, per quella congregazione di san Filippo Neri [1515-1596] da cui presero il nome. E di quel tempo pare la prima opera in musica, l’Orbecche di Cinzio Giraldi, stampata in Ferrara 1541. Insomma, tutte le invenzioni, quasi tutti i grandi progressi e i grandi stili e il sommo di quest’arte celestiale, sono italiani. Picciol vanto, ripetiamolo, questo primato nostro quando riman solo; ma bello e caratteristico esso pure, quando si trova nel secolo decimosesto congiunto con tutti gli altri di tutte le arti e tutte le lettere; quando concorre a dimostrar la fratellanza di tutte le colture, gli aiuti, le spinte ch’elle soglion ricevere l’une dall’altre a vicenda.
12. Il secondo periodo della presente etá in generale; rassegna degli Stati [1559-1700].—Se è felicitá al popolo la pace senza operositá; ai nobili il grado senza potenza; ai principi la potenza indisturbata addentro, ma senza vera indipendenza, senza piena sovranitá; ai letterati ed agli artisti lo scrivere, dipingere, scolpire od architettare molto e con lode de’ contemporanei, ma con derisione de’ posteri; a tutta una nazione l’ozio senza dignitá, ed il corrompersi tranquillamente; niun tempo fu mai cosí felice all’Italia come i centoquarant’anni che corsero dalla pace di Cateau-Cambrésis alla guerra della successione di Spagna. Cessarono le invasioni, lo straniero signoreggiante ci parava dagli avventizi.[49] Cessaron le guerre interne; il medesimo straniero ne toglieva le cause, frenava le ambizioni nazionali. Cessaron le rivoluzioni popolari; lo straniero frenava i popoli. Le armi, le sollevazioni che sorsero qua e lá, furono rare eccezioni, non durarono, non disturbarono se non pochi. Bravi, assassini di strada, vendette volgari, ed anche tragedie signorili o principesche, furono frequenti, per vero dire, ma tutto ciò non toccava ai piú; e poi eran cose del tempo, i nostri avi vi nasceano in mezzo, v’erano avvezzi. I piú degli italiani fruivan la vita, i dolci ozi, i dolci vizi, il dolcissimo amoreggiare o donneggiare. Noi vedemmo giá un’etá di grandi errori aristocratici, un’altra di grandi errori democratici: questa è degli errori aristocratici piccoli. Ma l’aristocrazia s’acquista e si mantiene coll’opere; non si corrompe solamente, si snatura coll’ozio; perdendo la potenza, la partecipazione allo Stato, non è piú aristocrazia, diventa semplice nobiltà. Dai campi e dai consigli dove s’era innalzata, la nobiltà italiana era passata alle corti. Così, per vero dire, pur fecero quelle di Francia e Spagna a que’ tempi; ma dalle corti elle facevano tuttavia frequenti ritorni ai campi di guerra ed ai governi, o almeno ai castelli aviti; mentre i nobili italiani non ebber guari di que’ campi o governi, e dimorando piú alle corti e nelle moltiplici capitali, vi poltrirono. Il peggio fu che non vi sentivano lor depressione, piegavansi, atterravansi beati. Spogli di potenza propria, consolavansi co’ privilegi, col credito all’insù, colle prepotenze e le impertinenze all’ingiù; spogli d’operosità, consolavansi con le ricchezze e gli sfarzi; degeneri, colle memorie avite. Non facean corpo nello Stato, ma tra sé; chiudevano quanto potevano i libri d’oro, quegli aditi alla nobiltà, che restano sempre spalancati quando la nobiltà non è un titolo illusorio, quando è aristocrazia. I principi, all’incontro, si facean un giuoco di avvilirla col moltiplicarla, di aggiungere titolati a titolati, privilegiati a privilegiati, oziosi ad oziosi. Insomma, fu un paradiso ai mediocri, che son sempre molti, e quando il vento ne soffia, son quasi tutti; de’ pochi ribelli al tempo, pochissimi penando s’innalzarono, or bene or male; i piú, penando vissero e morirono ignorati.—La storia poi si[50] impicciolisce, ma si rischiara; e, scemato il numero degli Stati italiani, or finalmente si fa possibile una rassegna di essi. Adunque: 1o Filippo II, re di Spagna, signoreggiava sul ducato di Milano estendentesi allora dall’Adda alla Sesia, comprendente Alessandria e sua provincia, e congiungentesi verso mezzodi co’ numerosi feudi imperiali in Liguria. E signoreggiava poi su tutto il regno di Napoli e Sicilia, e su quello di Sardegna.—2o Nell’occidente del largo istmo, dalla Sesia all’Alpi e in Savoia al di lá, signoreggiava Emmanuel Filiberto duca, sugli Stati riconquistati a San Quintino, restituitigli in diritto a Cateau-Cambrésis, ma non tutti di fatto per anche; rimanendo Torino, Chieri, Pinerolo, Chivasso e Villanova d’Asti in mano a’ francesi, Vercelli ed Asti in mano agli spagnuoli, finché non fossero evacuate le prime. Del resto, stato tutto spagnuolo il duca nella guerra, spagnuolo nel trattato e nella restaurazione, spagnuolo rimaneva naturalmente nella pace. Se non che, guerriero esso ed uomo di Stato, e ringiovanito lo Stato, ringiovaniti i popoli dalle guerre, dalle miserie precedenti, dalla restaurazione presente, ed aiutati tutti dalla vicinanza di Francia, essi rivendicaronsi a poco a poco in indipendenza e furono tra breve i piú, od anche i soli indipendenti italiani.—3o All’incontro, nell’oriente giacea la vecchia repubblica veneziana, potente di territori e di popoli dall’Adda all’Adriatico, ed al di lá in Istria e Dalmazia fino a Ragusi, e in Cipro e Candia, che le rimanean sole dell’antico quarto e mezzo dell’imperio orientale. Sarebbe stata cosí, senza contrasto, la prima delle potenze italiane; se non che, circondata d’ogni intorno dagli Stati spagnuoli e tedeschi di casa d’Austria, e preoccupata tutta della difesa contro a’ turchi, e del resto invecchiata sotto a quella invecchiatissima aristocrazia, che delle virtú aristocratiche non serbava piú se non quella della conservazione, Venezia era diventata meno italiana, meno curante degli affari d’Italia che mai; non pesava piú quasi in essi; era spagnuola, o almeno non mai antispagnuola.—4o Genova, l’antica emula, non le poteva piú essere comparata. Fuori delle due riviere (frastagliate da’ feudi imperiali) non avea piú che Corsica. E l’aristocrazia[51] di lei era altrettanto o peggio invecchiata che la veneziana. Né Genova e Venezia non aveano piú il primato de’ mari, passato a’ popoli occidentali; non quello dello stesso Mediterraneo, passato a Spagna.—5o Il marchesato di Monferrato e il ducato di Mantova, disgiunti di territori, si congiungevano in Guglielmo Gonzaga.—6o In Parma signoreggiava Ottavio Farnese; ma Piacenza rimaneva occupata da Spagna.—7o In Modena e Ferrara era succeduto nel 1550 Alfonso II Estense.—8o In Toscana tutta intiera signoreggiava il nuovo duca Cosimo de’ Medici.—9o In Urbino, Francesco Maria II della Rovere. E di tutti questi ducati non è nemmen mestieri dire, che piccoli com’erano, ed istituiti o tollerati dall’imperio le cui pretese s’estendevan sempre a tutta la penisola, nessuno di essi poteva aver indipendenza vera, nessuno pretendeva nemmeno al diritto compiuto di essa.—10o Lucca rimaneva repubblicana.—11o E finalmente in Roma, a Paolo IV Caraffa era nell’anno appunto 1559 succeduto Pio IV (de’ Medici); cioè all’ultimo papa che siasi aiutato di Francia, che abbia un momento ancora guerreggiato con essa contro Spagna, era succeduto uno che (come i successori), trovando fatta la pace, e ferma in Italia la signoria spagnuola, né poteva guari piú scostarsi da essa, né (premendo piú e piú gli affari del concilio e dell’eresia) il voleva di niuna maniera.—Insomma, un gran progresso erasi fatto senza dubbio dall’esser ridotti gli Stati italiani (non contando San Marino, né i feudatari imperiali) a una decina, invece della moltitudine di signori e città che rimanevano un sessant’anni addietro. Ma la signoria straniera facea piú che compensar tal progresso; guastava tutto, non lasciava libera azione a nessuno. L’Italia era incatenata di su, di giú, e dal mezzo; in Lombardia, nel Regno, e nel papa. Casa Savoia sola, grazie al vicinato di Francia, potea sciogliersi, e si sciolse; in Piemonte solo rimase e risorse alquanto di vita italiana. Gli storici patrii, imitatori giá degli antichi, imitatori poi dei cinquecentisti, che avean negletto Piemonte quand’era un nulla per l’Italia, continuarono a trascurarlo, se non del tutto, almeno molto troppo. Botta il primo diedegli giusta importanza; ma con[52] qualche ritenutezza ancora, quasi a lui piemontese non istesse bene ridur la storia d’Italia a poco piú che a storia del Piemonte; e perciò forse, per por nello scritto una proporzione che non è ne’ fatti, s’allungò soverchiamente in alcuni affari piccolissimi del resto della penisola. Ma perciò appunto, sforzati noi a trascurar quelli nel nostro rapido sommario, sembrerem soverchiamente piemontesi; e non avendo luogo nemmeno alle difese, aspetteremo d’esser giustificati dal tempo e da’ successori. Ad ogni modo, poche e misere le opere italiane di questo tempo, noi non veggiam modo di dividerle altrimenti, che seguendo i regni de’ principi di Savoia.
13. Emmanuele Filiberto [1559-1580].—Non mai i tempi moderni s’eran mutati a un tratto come per la pace di Cateau-Cambrésis; né mai mutaron tanto nemmeno i modernissimi, fuorché per la pace del 1814 e 1815. I vent’anni seguenti furono di quiete non interrotta, di ordinamenti, o, come or si dice, d’organizzazioni universali. Nel Regno, giá vecchio suddito spagnuolo, vecchio pur giá era l’ordinamento; in Milano l’ordinamento piú nuovo s’era modellato sul primo. Un viceré a Napoli, uno in Sicilia ed un governatore in Milano, non piú che cortigiani in Ispagna, ma principi assoluti in Italia, governavano non solamente per gl’interessi di quella, ma per li propri in questa e principalmente in quella. E cosí facevano allora gli altri governatori spagnuoli in America, ne’ Paesi bassi. Così giá i proconsoli e legati romani nelle province dell’imperio; cosí poi i governatori britannici nell’Indie. Così i governatori lontani dappertutto. È naturale; sempre si mira al centro, onde vengono grazie, favori, avanzamenti. In ciò il progresso di civiltà non muta guari. È di quelle cose che durano poco diverse sempre nella umana natura. Un Consiglio d’Italia in Madrid temperava solo la potenza di que’ governatori. Tranne una milizia (quasi le guardie nazionali d’oggidì) che non si convocava guari, se non contro ai turchi o agli assassini di strada, non v’eran armi, niun corpo napolitano o milanese; napoletani o milanesi s’arruolavan ne’ «terzi» o reggimenti spagnuoli, che eran tutti di volontari, o piuttosto levati a forza, a inganno, a caso. E cosi gl’italiani[53] militavano fuori per interessi non propri, e gli stranieri in Italia per interessi anti-italiani. Molta religione, cattolicismo stretto, anzi intollerante s’affettava; facevasene strumento d’imperio, d’ordine, di soggezione; e cosí Spagna stringevasi ai papi, quanto i papi a Spagna. Nelle finanze, imposizioni legalmente gravi, piú gravi di fatto, perché non erano perfezionate le forme, le quali guarentiscono ai popoli che non si levi piú dell’imposto. Gran disordine dunque, ma grande affettazione d’ordine, o almeno di governo, smania di regolar tutto, di far sentire l’autoritá straniera; onde non solamente severità ma crudeltà. Ed io dimenticava che in Napoli e Sicilia erano pure resti di Stati generali antichi, assemblee rappresentative o deliberative; ma rappresentavano popoli domati, stanchi, senza volontà, deliberavano a’ cenni del signor lontano, de’ viceré presenti, eran nulla. Non eran sorti gli esempi che fanno cosí importanti queste assemblee a’ nostri dí; dovunque rimanevano elle, fuori come addentro Italia, il principe le distruggeva o serbava o dimenticava, a piacer suo, del paro innocue, con pari facilità. In somma, a que’ tempi non era sorta, non era quasi possibile l’arte di governar province straniere e lontane senza tiranneggiarle, e si tirannegg-iavano. Né contro a’ turchi, quantunque soli nemici stranieri che rimanessero, si poteva o si sapea difenderle. Il Mediterraneo, non piú lago italiano, avrebbe dovuto essere spagnuolo; era turco-spagnuolo. Una sola volta Spagna si destò al dovere di non lasciarlo diventar tutto turco; e fatta una lega co’ veneziani e il papa e il duca di Savoia, allestirono una grande armata sotto agli ordini di don Giovanni d’Austria figlio naturale di Carlo V, il quale die’ una gran rotta ai turchi a Lepanto nel 1571. Ma fosse gelosia di Filippo II contro al fratello, o mollezza e incapacità spagnuola o italiana o universale, non si proseguì la vittoria, si sciolse la lega, si lasciarono soli i veneziani contro a’ turchi, al solito.—In Roma Pio IV Medici, che dicemmo [1559-1565], riadunò e terminò poi il concilio di Trento [1562-1563]. Del quale molto sarebbe a dire certamente, se avessimo luogo; ma non avendone nemmeno per gli affari, per li negoziati politici, non sarebbe ragione che ci estendessimo[54] sugli ecclesiastici, piú ardui a capire e spiegare. Ondeché, riducendoci alle generalità, diremo solamente: che il concilio lasciò le cose ecclesiastiche tali quali erano prima o s’erano svolte intanto tra’ protestanti, i quali non v’assistettero mai e il respinser sempre; ma che esso ordinò, rinnovò molto bene ed opportunamente la disciplina della Chiesa cattolica; e che insomma da esso in poi il protestantismo non ottenne piú una vittoria, un estendimento, e il cattolicismo non perdette piú una chiesa o una provincia. È noto, è ammesso dagli stessi protestanti, che il loro progresso non durò se non un cinquant’anni; che d’allora in poi essi non ebbero se non stazione e regresso. Del resto, Pio IV fu papa buono, quantunque nepotista, perché il nipote in credito trovossi essere san Carlo Borromeo.—Successe Pio V [Ghisilieri, 1566-1572], che è l’ultimo papa beatificato dalla Chiesa, che fu de’ pochi non nepotisti fino a’ nostri dí, severissimo del resto contro agli eretici. E successe Gregorio XIII [Buoncompagni, 1572-1585], che s’unì solo, non potendo unir altri, con Venezia contro a’ turchi, ma non ne riuscì nulla.—In Toscana, Cosimo il nuovo duca ordinò il ducato e governò assoluto, severo, talor crudele, alla spagnuola; men cattivo, perché è sempre minore la cattivezza d’un principe nazionale e presente. Ordinò le cerne, o milizie del paese, ma piú simili a ciò che chiamiam ora «guardie nazionali», che non a veri corpi militari; ed intorno a sé guardie tedesche o spagnuole. Nel 1569, ebbe dal papa titolo di granduca, che non gli fu riconosciuto dall’imperatore. Protesse l’agricoltura, il commercio, Livorno, le lettere innocue, e cosí [1540] l’Accademia fiorentina, madre di quella della Crusca. In casa perdette due figliuoli a un tratto; e resta dubbio se fosse caso o misfatto. Alfieri ne fece una tragedia. Morì nel 1574. Successegli suo figlio Francesco I, giá molto dammeno. Congiuratogli contro, nel 1575, diventò crudele, dentro e fuori, a’ fuorusciti. Nel 1576, ebbe conferma dall’imperatore del titolo di granduca; nel 1579, sposò Bianca Cappello, una veneziana fuggita dalla casa paterna, e giá stata amanza d’un fiorentino, poi di esso granduca, finché visse Giovanna d’Austria sua moglie. E Venezia, che avea [55]giá sbandita costei, la dichiarò ora figliuola della repubblica! A tale erano giunti giá i tempi, di farsi pubblicamente, legalmente, senza pretender necessità né utile, per semplice compiacenteria, le viltà.—Dei duchi minori non abbiamo a dir nemmeno molte successioni, ché in Urbino solo, a Guidobaldo della Rovere era succeduto nel 1574 Francesco Maria figliuolo di lui; ed in Ferrara, Parma e Mantova continuarono per questi vent’anni i medesimi Alfonso II d’Este, Ottavio Farnese e Guglielmo Gonzaga, giá accennati.—In Genova risorsero turbamenti che si potrebbon dire fuor d’etá, tra classe e classe di cittadini, tra’ nobili detti di «portico vecchio» e nobili di «portico nuovo» a cui s’aggiungevano i popolani; ma non avendo noi detto de’ turbamenti interni de’ comuni antichi dov’erano piú importanti, dove si disputava almeno della politica, dell’operosità, della parte a cui rivolger la città, non diremo di queste dispute le quali furono solamente di grado, o tutt’al piú di partecipazione ad un governo inoperoso. E continuavan i turbamenti nella suddita Corsica. E tra tutto ciò fu tolta Scio dai turchi ai Giustiniani, e cosí alla repubblica sotto cui essi la tenevano [1566].—In Venezia tutto languiva nella solita pace e mediocrità. E ad essa pure fu tolta Cipro, una delle isole orientali, in quella guerra ch’ella fece contro a’ turchi dal 1570 al 1575, e in cui ella non ebbe se non una volta a Lepanto un vero aiuto dalla cristianità. Ei si vede: tutti questi Stati decadevano, sopravvivevano, s’ordinavano a sopravvivere.—Casa Savoia sola a crescere. Emmanuel Filiberto, non principe nuovo come i piú di costoro, non di famiglie sporcatesi nel salire alla potenza, discendente d’una lunga serie di principi buoni, provato dalla cattiva fortuna, e salito alla buona per meriti propri, riuniva cosí i vantaggi de’ principi antichi e de’ nuovi. Se ne seppe valere; e gran capitano a riacquistar lo Stato, fu gran legislatore a riordinarlo, perché lo riordinò secondo il secolo suo. Non restaurato ancora in tutti gli Stati suoi, nemmeno in Torino sua capitale, raunò gli Stati generali in Chambéry. Voleva farsene aiuto a’ suoi riordinamenti, trovolli ostacolo o ritardo; li sciolse, e non li convocò mai piú, né egli né nessuno de’ successori fino[56] a Carlo Alberto, riordinator nuovo e piú grande secondo il secolo suo. Quindi Emmanuel Filiberto è vituperato da alcuni di noi altri presenti, quasi principe illiberale, usurpator de’ dritti popolani e costitutor di despotismo. Ma se è certo e santo che de’ vizi e della virtù è a giudicare nel medesimo modo in tutti i tempi, certo e giusto è pure che delle istituzioni è a giudicare diversissimamente secondo i tempi. E degli Stati generali od assemblee rappresentative e deliberative, ei bisogna ritenere che a que’ tempi elle erano informi, indeterminate nella loro composizione di nobili e deputati delle città, indeterminate nelle loro attribuzioni; ondeché, quali erano, o non servivano a nulla, come in Napoli e Sicilia; o non servivano se non a turbare, come in Francia e Inghilterra. E quanto a dire che Emmanuel Filiberto le avrebbe dovute o potute costituire coi modi nuovi, trovati cento e piú anni appresso in Inghilterra, e ducento e piú in Francia e altrove; questo sarebbe poco men che dire ch’egli avrebbe pur dovuto fare ne’ suoi Stati le strade ferrate. Io, per me, credo che Emmanuel Filiberto avrebbe fatte le assemblee de’ nostri tempi a’ nostri tempi; ma ch’ei fece a’ suoi tutto quello che era da essi. Il fatto sta, che intorno a quelli venne meno la monarchia rappresentativa in tutta Europa, in Inghilterra stessa; e sottentrò una monarchia quasi assoluta, ma che si può meglio dire consultativa, perché fu temperata quasi dappertutto da vari Consigli che contribuivano in fare o sancire le leggi. Nella sola Inghilterra, dove non erano e non si fecero tali Consigli dai principi, la lotta diventò piú forte tra essi e i parlamenti, piú franca tra assolutismo e libertá, e vinse questa due volte. E perché dopo aver abusato della sua prima vittoria... la libertá seppe all’incontro usare moderatissimamente della seconda, ad ordinarsi lentamente, meravigliosamente per un secolo e piú, perciò ella fondò, perfezionò, compiè colá quella monarchia rappresentativa che fece, che fa la felicità, la grandezza, il primato di quella nazione tra tutte l’altre cristiane; quella monarchia rappresentativa, che di lá venuta sessant’anni fa, va vincendo a gran colpi di rivoluzione, e trionfando su quasi tutto oramai il continente europeo, e trionferà, aiutante Iddio,[57] su tutto.—Del resto, nell’anno medesimo che Emmanuel Filiberto chiudeva i suoi Stati generali, egli riordinò appunto que’ senati o corti supreme di giustizia, che mal vi supplirono tra noi come altrove, e regolò poi i tribunali minori. Nel 1561, incominciò ad ordinare la milizia nazionale; proseguì egli e proseguirono poi sempre tutti quanti i suoi successori, non eccettuati i men belligeri, in mutare e rifare tali ordinamenti; ora piú or men bene, ma sempre secondo i tempi e con operosità, con insistenza, con amore; tanto che non è cosa di governo in che’ si sieno essi compiaciuti, né cosa poi in che sieno stati cosí secondati da’ lor popoli. Gli ordinamenti militari, l’esercito, furono, se sia lecito dire, quasi patria costituzione ai piemontesi per poco meno che tre secoli. Ed ora cedano pure il passo a questa, ma di poco, in nome de’ destini del Piemonte e d’Italia, e della stessa monarchia rappresentativa. Libertà e milizia sono rivali altrove; ma (per la ragione che ognun sa, per le passioni ch’ognun sente) elle dovrebbon essere sorelle in Italia. Sieno almeno su questa terra intrisa di tanto sangue militare de’ padri, de’ fratelli e de’ figli nostri. Addì 17 dicembre 1562, Emmanuele Filiberto rientrò in Torino, e vi rimase poi quasi sempre, diverso da’ maggiori che prediligevano il soggiorno al di lá delle Alpi. Ed a Torino ricondusse, restaurata prima a Mondoví, l’universitá degli studi che n’era uscita durante l’occupazione straniera. Nel 1563, estintasi la discendenza diretta degli antichi marchesi di Saluzzo, il marchesato fu occupato da’ francesi, e s’accrebbe cosí di nuovo la potenza di essi nelle regioni subalpine. Nel 1564, il duca incominciò la cittadella di Torino; ed altre fortezze fece poi, ad imperio addentro, e difesa all’infuori. E nel medesimo anno incominciò ad ordinare le finanze. Nel 1565, aiutò Malta contro a’ turchi; e nel 1572, mandò sue galere a Lepanto, ed aiutò poi de’ suoi nuovi reggimenti or Francia or Austria contra gli acattolici. Contra quelli giá antichi ne’ suoi Stati, i valdesi dell’Alpi, si volse non senza inopportunità, od anche crudeltà per qualche tempo; ma lasciolli in pace poi. Nel 1573, ordinò che gli atti pubblici si facessero in lingua italiana; e sempre chiamò, protesse, pose[58] nell’universitá di Torino letterati di altri paesi italiani. Egli fu primo a dirozzare i suoi popoli, beati o macedoni d’Italia; primo ad italianizzarli colla coltura. Nel 1574 solamente riebbe tutti gli Stati suoi, vuotati di qua e di lá da’ francesi e spagnuoli; e questo spiega e scusa come dieci anni addietro avesse sofferta l’usurpazione di Saluzzo. Dal 1576 al 1579, accrebbe gli Stati, comprando feudi imperiali dai Doria ed altri signorotti. Nel 1579 ordinò la zecca, e nel 1580 mori; cosí fino all’ultimo operando, legislatore, ordinatore, rinnovatore della sua monarchia. E tal vedemmo giá dopo le antiche origini Amedeo VIII; e tali vedremo uno o due altri poi di quella casa. Della quale resta cosí spiegato il perché, il come crescesse; come, sola forse fra le dinastie europee, continuasse senza rivoluzioni o mutazioni violente; fece ella medesima via via, sempre, indefessa, le mutazioni volute, ma prima che violentata dai tempi. I tempi mutan sempre; ondeché i veri conservatori sono quelli che mutan con essi; non gl’immobili, che a forza di resistere si fanno impossibili, e rovinano sé e altrui. Ad Emmanuel Filiberto debbono i posteri una nazionalitá che altri popoli loro invidiano, dice di lui uno scrittore italiano, non piemontese: noi consentiamo volentieri.
14. Carlo Emmanuele I [1580-1630].—La differenza tra Emmanuel Filiberto e gli altri legislatori italiani de’ venti anni addietro si vede chiara all’effetto ne’ primi lor successori. Progredí e fecesi grande quel di Piemonte; scesero e s’impicciolirono via via i Medici e gli altri. Salito a una signoria rinforzata dagli ordinamenti di pace, dagli apparecchi di guerra fatti dal padre, si potrebbe dire che Carlo Emmanuele volle essere l’Alessandro di quel Filippo. E sarebbegli forse riuscito, se avesse avuto un solo scopo, l’Italia. Ebbelo, ma con un secondo: farsi grande di lá dell’Alpi, ed anche piú lontano. Perciò non s’avanzò come avrebbe potuto verso lo scopo principale, e lasciò nome d’ambizioso piú che di grande (benché datogli questo da’ contemporanei), e d’avventato piú che di forte, ed anche di doppio piú che di leale. Leali, forti e grandi appaiono e sono piú facilmente gli uomini d’un solo scopo; compatiti, è vero, e derisi da’ faccendieri,[59] dagli enciclopedici, e dagli incostanti, che ne han molti e vari; ed anche piú dai pigri di spirito e da’ gaudenti, che non vogliono e non possono averne nessuno, e vivono alla giornata. Carlo s’avventò prima contro a Ginevra, perduta da sua famiglia fin dal 1536; e non gli riuscendo, tornò contro essa ad ogni tratto per vent’anni e piú, fino al 1603, che rinunciovvi e fece pace con essa. Intanto aprì guerra contro Francia; ed approfittando delle contese civili e religiose che ferveano colà sotto ad Enrico III, ultimo de’ Valois, s’avventò contra Saluzzo, quella spina francese che rimaneva in corpo alla monarchia piemontese. Occupolla a forza nel 1588; e quindi una lunga e varia guerra su tutta la linea dell’Alpi, che condusse egli di qua, e Lesdiguières di lá. Nel 1590, occupò Aix, Marsiglia, e si lasciò da alcuni cattivi francesi acclamare conte di Provenza. Ma ciò era nulla; mirava alla corona di Francia che altri cattivi volevan tôrre ad Enrico IV; e perciò, non solo combatté, che era giá stolto e male, ma intrigò, che era peggio. Fu pessimo, se è vero, quel che segue: che fatta pace a Vervins nel 1598, e lasciata a giudicio del papa la lite di Saluzzo, e andato Carlo a Parigi nel 1599, ivi entrasse nella congiura del Biron contra al re, alleato ed ospite suo. Ed egli negò sempre e si turbò di tale accusa; ma resta in lui la macchia d’esservisi esposto con gli intrighi precedenti. Ad ogni modo, Enrico IV, principe poco tollerante, e che tagliava coll’ardita franchezza le perfidie reali o temute, ruppe la guerra nuovamente nel 1600, ed invase Savoia. Seguiva finalmente il trattato di Lione [17 gennaio 1601], per cui casa Savoia cedette Bressa, Bugey e Valromey, province in seno a Francia; e Francia cedette Saluzzo, provincia in seno a Italia. Savoia perdeva in territorio ed anime; ma vi guadagnò di quadrare i suoi Stati italiani, di non aver in corpo un vicino potente e cosí suo nemico naturale, e di farsene anzi un naturale amico contro al nemico anche piú naturale suo e d’Italia, casa d’Austria. Fu detto che Arrigo IV avea fatto un cambio da mercante, e Carlo Emmanuele uno da principe e politico; ma non è vero. Cambiando ciascuno province innaturali con province naturali a’ loro Stati, vi guadagnarono amendue; e[60] questi sono sempre i migliori e piú durevoli trattati. Il fatto sta che d’allora in poi Carlo Emmanuele s’accostò a Francia, e rimase per lo piú con essa. E questa alleanza fu per produrre cose grandi, quando Enrico IV, quel gran re che avea pacificata ed ordinata Francia, si volse a voler riordinar Europa contro alla preponderanza delle due case Austriache. Seguinne [25 aprile 1610] quel trattato di Bruzolo, il quale, dice uno scrittore lombardo, «trasformava i duchi di Savoia in re de’ lombardi». Ma fu ucciso allora, come ognun sa, Enrico IV, e non se ne fece altro; e «quel regno de’ lombardi rimase ne’ duchi di Savoia un desiderio che non si spense mai». Ad ogni modo, da questi due trattati di Lione e di Bruzolo fecesi un gran progresso nella politica, e, se si voglia, nell’ambizione di casa Savoia: ché ella fu d’allora in poi costantemente, esclusivamente italiana. Morto, nel 1587, Gugliemo Gonzaga, duca di Mantova e marchese di Monferrato, e nel 1612 il figlio di lui Vincenzo, e nel medesimo anno il figlio di questo, Francesco, che lasciava una sola figliuola fanciulla, succedette Ferdinando cardinale; il quale, legato negli ordini, non poteva aver figliuoli, ed a cui rimaneva sì un fratello Vincenzo, ma anch’esso senza figliuoli, ondeché la successione eventuale rimaneva in Maria, quell’ultima fanciulla de’ Gonzaga. E giá due volte casa Savoia avea preteso a tal successione; pretesevi ora Carlo Emmanuele, e volle almeno la tutela di Maria, per farla sposare al proprio figlio, e riunir cosí tutti i diritti. Negatagli, s’avventò, al solito suo, sul Monferrato [1613]. Spagna nol volle soffrire; seguinne una guerra di quattro anni, seguiron trattati vari; quel del 1617 restituiva lo statu quo; ma intanto un duca di Savoia solo avea resistito a Spagna. Poco appresso sollevavasi la Valtellina cattolica contra i grigioni protestanti e signori di essa. La prima fu aiutata da Spagna, i secondi da Francia, Savoia e Venezia. Riaprissi ed estesesi la guerra. Savoia e Francia fecero un’impresa insieme contra Genova; e qui di nuovo cadde il duca in sospetto di complicità ad una congiura contro a quella repubblica. Ritrassesi poi Francia di quella guerra, e rifecesi pace a Monzone nel 1626, tra le due potenze grosse; e le piccole, Savoia fra le altre,[61] dovettersi acquetare. Morto poi, nel medesimo anno, il cardinale e duca Ferdinando Gonzaga, e nel 1627 Vincenzo fratello di lui, succedettero lor nipote Maria e il marito di lei Carlo Gonzaga giá duca di Nevers, e cosí tutto francese. Fu per esso Francia, e furono contro esso Austria ed il mutabile Savoiardo, tratto e dall’ambizione antica d’aver il Monferrato, e dall’essergliene data una parte fin d’allora. Guerreggiossi acremente in tutto Piemonte; e il vecchio e infermo ma ancora prode duca vinse i francesi nel 1628, ne fu vinto nel 1629, perdette Savoia, Pinerolo, Saluzzo; e stava alla riscossa sulla Maira quando, infermato, morí ai 26 luglio 1630. Pochi dí prima [18 luglio], era stata presa Mantova dagli spagnuoli alleati suoi. Pro’ guerriero, buon capitano secondo i tempi, ardito, pronto, bel parlatore, fu amato da’ soldati ch’ei pagava male ma conduceva bene, adorato da’ sudditi a cui procacciava le miserie, ma l’operositá, ma l’alacritá, ma l’onor della guerra; continuò, compiè gli ordinamenti civili del padre; parlò, operò italiano, protesse molti illustri, Tasso, Tassoni, Marini, Chiabrera, Botero; in una parola, raccolse piú che mai in sua casa e suoi popoli tutto quello che rimaneva di vita nazionale durante il mezzo secolo di suo regnare. È impossibile non far come i sudditi di lui, non amarlo a malgrado tutti i suoi difetti: fu uomo di buona volontá italiana.—Il rimanente dell’Italia d’allora val pochi cenni. Oltre la successione dei Gonzaga che turbò l’Italia, due altre ne furono che senza turbarla ne mutarono alquanto la distribuzione. Succeduto ad Alfonso II, duca di Ferrara e Modena, Cesare suo figliuolo naturale [1597], il papa non gli volle lasciar Ferrara feudo pontificio; e disputatone alquanto, l’ebbe per trattato [1598]; e la casa d’Este rimase bastarda e ridotta a Modena, fino a che s’estinse.—In Urbino, avendo il vecchio Francesco Maria II della Rovere perduto nel 1623 il figliuolo unico che lasciava una figliuola unica granduchessa di Toscana, ei rinunciò al ducato, feudo pontificio ancor esso, che fu riunito cosí agli Stati della Chiesa.—In Parma e Piacenza, ad Ottavio Farnese, morto nel 1586, succedette Alessandro figliuolo di lui, che fu illustre capitano negli eserciti spagnuoli[62] e combatté a Lepanto, ne’ Paesi bassi, di cui fu governatore, ed in Francia. E per questi meriti fu lasciata finalmente, fin dal tempo di suo padre [1585], la cittadella di Piacenza a’ Farnesi. Ad Alessandro, morto nel 1592, succedettero Ranuccio II figliuolo di lui, e morto questo nel 1622, il figliuolo di lui Odoardo.—In Toscana, a Francesco I, morto (dicesi di veleno) nel 1587 senza figliuoli, succedette il fratello di lui Ferdinando I, giá cardinale, che fu buon amministratore dello Stato, buon promotor di commerci ed agricoltura e lettere, e fece guerra ai ladri interni ed ai barbareschi, a cui prese una volta Bona in Africa. Al quale morto nel 1609, succedette Cosimo II, figliuolo degno di lui. Al quale, morto nel 1622, succedette il fanciullo e dammeno Ferdinando II. E tutti o quasi tutti questi principotti furono molto protettori di lettere, ma al modo nuovo che diremo poi.—E tali pure i papi di questo tempo: Gregorio XIII che riformò il calendario nel 1582, e pontificò fino al 1585; Sisto V [Peretti, dal 1585 al 1590], che fu il gran distruttor de’ ladri, il grande avanzator dell’opere d’Alessandro VI e di Giulio II a pacificar gli Stati della Chiesa, del resto persecutor d’eretici in Germania e Francia, grande edificator di monumenti in Roma; Urbano VII [Castagna], che regnò pochi giorni nel 1590; Gregorio XIV [Sfondrato, 1590-1591], che compiè l’opera di Sisto V contro ai ladri e banditi; Innocenzo IX [Facchinetti, 1591]; Clemente VIII [Aldobrandini, 1592-1605], che ricevette in grembo alla Chiesa Enrico IV di Francia, e riuní Ferrara; Leone XI [Medici, 1605]; Paolo V [Borghese, 1605-1621], che scomunicò Venezia, e finito San Pietro, vi pose suo nome; Gregorio XV [Ludovisi, 1621-1623], istitutor della congregazione della propaganda; Urbano VIII [Barberini, 1623-1644]. I nomi de’ quali, rimasti quasi tutti di famiglie grandi per ricchezze, accennano che parecchi di questi papi non si salvarono dal vizio del secondo nepotismo; ma fuor di ciò furono tutti buoni pontefici, e, secondo i tempi, buoni principi.—Di Venezia, sarebbe a dire quella accanita disputa ch’ella ebbe [1606-1607] con papa Paolo V, e in che si fece famoso fra Paolo Sarpi di lei teologo. Gli storici, le memorie del tempo, e Botta poi, si fermano lungamente in essa, ed in alcune altre[63] che furono e prima e dopo tra’ papi e principi italiani. Ma noi, oltreché v’avremmo poco spazio, e che tali contese tra le potenze temporali e la ecclesiastica ne vorrebbon pur molto per essere bene spiegate e capite, confessiamo di porvi oramai poca importanza. Queste dispute, per qualche ecclesiastico o qualche affare che i tribunali civili ed ecclesiastici avocavano a un tempo a sé, per li diritti d’asilo nelle chiese, per istabilire od estendere il tribunale dell’Inquisizione, parvero, in vero, grossi affari a que’ tempi ove non n’eran de’ grandi; e son segni appunto di ciò. Ma ciò detto, non mi paiono piú importanti che tanti altri affari speciali di giurisprudenza o legislazione civile o militare o marinaresca, che tralasciamo per forza. Ché anzi, se abbiamo a dir tutto il pensier nostro, crediamo che parecchi di coloro i quali s’estendono in ciò, ciò facciano (a malgrado la noia propria e de’ leggitori) per rivolgergli a quel pochissimo che resta di tali dispute a’ nostri dí, ed in che essi pongono tuttavia un’importanza che noi non sappiamo assolutamente vedere. Non è la potenza ecclesiastica l’usurpatrice de’ nostri dí; tal non era nemmeno nel Seicento; giá difendevasi, indietreggiando dalle sue pretensioni antiche fin d’allora, ed ella si difende ed indietreggia ora piú che mai; ondeché, tutto ciò che si rivolge d’ire e d’attenzioni contro ad essa, sono ire ed attenzioni perdute contro a’ veri usurpatori. «Dividi e impera» è vecchio arcano d’imperio, e messo in pratica fino a ieri ed oggi. Ed egli implica e fa lecito e debito il suo contrario, l’arcano di liberazione, «uniamoci per liberarci»; uniamoci principi e popoli, nobili e non nobili, tutti gli educati, e gli ineducati stessi, educandoli; e militari e civili, e massime laici ed ecclesiastici, secolari e regolari, fino ai frati, fino ai gesuiti, fino ai piú esagerati, e giá colpevoli di lá o di qua, che vogliano unirsi a virtuosamente operar per la patria, fino a coloro che avessero perseguitati od anche calunniati non solamente noi, ma gli stessi amati da noi[2]. Piú attenzione forse [64]meriterebbe, se ne avessimo luogo, una guerra tra Venezia e gli uscocchi, pirati dell’Adriatico [1601-1617], protetti o almen tollerati da casa d’Austria; un trattato fatto a Madrid [1617] vi pose fine. E l’anno appresso [1618] successe quella congiura che parve mirare a non meno che alla distruzione della repubblica; e che compressa, secondo l’uso di lei, con prontezza e misterio, resta dubbio quanto fosse vera e pericolosa, e se di semplici venturieri, o se promossa da Spagna, o se anzi da uno o due dei governatori spagnuoli in Italia che volessero ribellarsi e farsi essi signori.—Del resto, i due Stati spagnuoli, Milano e il Regno, peggiorarono via via. A Filippo II, il Tiberio della monarchia spagnuola, erano succeduti Filippo III [1598] e Filippo IV [1621], che ne furono poco piú che i Claudi o i Vitelli. Governaron per essi un duca di Lerma, un d’Uzeda e un conte duca d’Olivarez, via via piú assoluti a Madrid, al centro di quel grande imperio. S’imagini ognuno come governassero i viceré e governatori lontani. Depredavansi le entrate ordinarie, supplivasi con istraordinarie; vendevansi, ripiglianvansi i feudi, si alzavano, s’esageravano gli appalti, non si badava ai popoli ma all’erario, o piuttosto questo stesso non era se non un pretesto, una via per cui passavano le ricchezze, cioè, senza metafora, il sangue de’ popoli. Ma a che perdere spazio in tutto ciò? Quando anche n’avessimo piú, non potremmo far meglio che rimandar i leggitori all’immortal ritratto fattone dal Manzoni. Niuna storia, nemmen quella splendidissima di Botta, può arrivar a dare una cosí viva e giusta idea del disordine, delle prepotenze, delle depredazioni, delle pompe, degli avvilimenti in che giacquero i popoli italiani sotto al governo ispano-austriaco.
15. Vittorio Amedeo I, Francesco Giacinto, Carlo Emmanuele II [1630-1675].—Se la Provvidenza avesse dato immediatamente al Piemonte un secondo regno di mezzo secolo e d’un principe simile a Carlo Emmanuele I, casa Savoia sarebbe forse diventata regina di mezza Italia, ovvero ella si sarebbe rovinata del tutto. Ma la Provvidenza sembra aver destinata quella casa a un crescer costante, ma lento; ed ella frappose ai due regni, simili per[65] lunga e grande operositá, un intervallo di quarantacinque anni, e tre principi minori con due reggenze.—Succeduto Vittorio Amedeo I [luglio 1630], continuò la guerra della successione di Mantova pochi altri mesi; poi si venne a’ trattati; e per quelli di Cherasco [6 aprile 1631] e Mirafiori [5 luglio 1632] rimasero. Mantova e Monferrato al Nevers-Gonzaga; Alba, Torino ed alcune altre terre a Savoia. Ma questa ebbe a dar Pinerolo a’ francesi, e cosí fu riaperta a questi l’Italia, e disfatto il benefizio di Carlo Emmanuele quando aveva avuto Saluzzo in cambio alle province francesi. E posossi per poco. Ché, signoreggiata Francia dal Richelieu, questi riprese l’idea d’Enrico IV di diminuir casa d’Austria, massime in Italia, ed a ciò [11 luglio 1635] fu firmato in Rivoli un trattato tra Francia e Savoia, a cui aderirono Parma e Mantova, ed applaudí Urbano VIII, il papa Barberini che fu o apparve primo dopo il Caraffa a prender noia del giogo spagnuolo e volgersi a Francia. Cosí riaprissi la guerra, che durò poi variamente ventiquattro anni. Ma Vittorio Amedeo, generalissimo della lega, non la condusse che due anni. Morí ai 7 ottobre 1637.—Allora si aggiunse una contesa di famiglia, e diventò guerra civile, la sola che sia stata mai in Piemonte. Succedeva ad Amedeo suo figlio di cinque anni, Francesco Giacinto; e fu presa la reggenza dalla vedova madre di lui, Cristina di Francia, figliuola di Enrico IV, donna di alti e gentili spiriti, come il padre. Aveva contro a sé, Spagna aperta nemica; Francia o almen Richelieu avidi amici che volean tiranneggiarla; e i due cognati, Tommaso buon guerriero al servigio di Spagna, e Maurizio pure spagnuolo di parte, che le contrastavano la reggenza appoggiandosi bruttamente a Spagna, nemica allora di lor famiglia, nemica naturale di ogni principe indipendente italiano. Dichiararonsi mentre Leganes e gli spagnuoli invadevano.—Morí in questo [giugno 1638] il duca fanciullo Francesco Giacinto; e succedette suo fratello piú fanciullo Carlo Emmanuele II. Nel 1639, il Piemonte fu quasi tutto de principi zii. Nella notte del 26 e 27 luglio, sorpresero Torino. Madama reale (come si chiamava la duchessa) ne fuggí prima in cittadella, poi qua e lá fino a Grenoble, ma lasciando il[66] figliuolo chiuso in Monmelliano con ordine al governatore di non dar né figlio né fortezza, nemmeno per niuno scritto di lei; e cosí salvollo dal Richelieu che lo voleva. Nel 1640, fu ripresa Torino, e tornovvi madama reale. Nel 1642, si fece accordo tra lei e i cognati; e le rimase la reggenza fino al 1648, e naturalmente poi per piú anni il governo del figliuolo maggiorenne ma adolescente. E durò la guerra ma lungamente tra Francia e Spagna. Ravvivossi nel 1656 colla presa di Valenza, ma senza grandi risultati nemmeno. Erano i tempi della decadenza in Ispagna, e della Fronda in Francia. Finalmente, addí 17 novembre 1659, facevasi la pace de’ Pirenei tra Spagna e Francia; e fu firmata per questa dal Mazzarino, cardinale italiano e successore al Richelieu nel ministero. E cosí liberato Piemonte da amici e nemici, regnò Carlo Emmanuele II tranquillo, splendido, edificator di chiese, palazzi e ville, protettor di lettere, buono ed elegante principe. Disputò vanamente per il titolo di re di Cipro con Venezia; e pacificatosi, le mandò il marchese di Villa suo generale ed un corpo di truppe, ad aiutar Candia assediata dai turchi. Mosse due cattive guerre contro a’ valdesi, e le finí lasciando le cose come prima. Nel 1670, aprí tra’ dirupi di Savoia una strada a Francia, opera alla romana, ammirata e superata da Napoleone, che se Dio voglia sará superato da’ principi nostri, aiutati dalla presente civiltá. Nel 1672, mosse guerra a Genova; ma non riuscí a nulla nemmeno esso, e si rifece pace nel 1673, per mediazione e minacce di Luigi XIV di Francia. Morendo [12 giugno 1675], fece aprir le porte del palazzo, per vedere il popolo suo che amava riamato. Fu de’ pochissimi di casa Savoia, che non conducessero le armi sue.—Il resto d’Italia non ebbe in questo tempo nemmeno il solito vantaggio di giacere in pace. I ducati settentrionali, Parma, Modena, Mantova con Monferrato, furono attraversati da combattenti, e sforzati di prendere parte a quasi tutta la guerra fino alla pace de’ Pirenei. Oltreché, essendo Ottavio Farnese carico di debiti, ed avendo ipotecato a’ creditori il ducato di Castro e Ronciglione, papa Urbano VIII (forse per investirne i Barberini suoi nepoti) li sequestrò; e ne nacque, frammista alla guerra[67] grossa, una piccola, in cui Venezia, Modena e Toscana mossero per il Farnese [1641-1644], finché fu fatta pace [1644]. Ma succeduto a Ottavio Ranuccio II figliuolo di lui, e guastatosi per la nomina di un vescovo con papa Innocenzo X, si riaprí la guerra; e questi sequestrò di nuovo Castro e Ronciglione, che furono incamerati e ritenuti, anche dopo la pace ed altri trattati, per sempre, dalla Santa Sede. E rimase confermata la riunione d’Urbino alla morte di Francesco Maria, l’ultimo Della Rovere [1636]. D’allora in poi, da due secoli in qua, gli Stati della Santa Sede furono tali quali sono ora (salvo che l’Austria occupa ora militarmente Ferrara, e stabilmente un lembo di Oltrepò).—In Modena successero Alfonso IV, figlio di Francesco I [1658], e Francesco II, figlio di Alfonso IV [1662].-In Mantova e Monferrato, giá diminuito, successero Carlo II figliuol del primo [1637], e Carlo III (che vedrem l’ultimo di quella terza schiatta di Monferrato) figliuol del secondo [1665].—In Toscana, al pacifico e letterato Ferdinando II succedette il pacifico e letterato Cosimo III [1670].—In Roma, ad Urbano VIII Barberini, succedettero, Innocenzo X [Panfili, 1644-1655], che perseguitò i nipoti del predecessore, e ingrandì i suoi; Alessandro VII [Chigi, 1655-1667], che non volle dapprima ma finí con nepotizzare egli pure, e che per una zuffa di servitori di casa sua e dell’ambasceria francese, ebbe a soffrir le prepotenze di Luigi XIV e fargli scuse; Clemente IX [Rospigliosi, 1667-1670], e Clemente X [Altieri, 1670-1676], nepotisti essi pure.—Venezia ebbe a sostenere una gran guerra contro a’ turchi, che le assaliron la bella ed ampia isola di Candia: e vinseli in due battaglie navali, ma perdette l’isola finalmente nel 1669.—Genova fece poco piú che poltrire, salvo quella volta che si difese contra Carlo Emmanuele II. E le province spagnuole pativano, ed erano spogliate peggio che mai; ma Milano senza muoversene; Sicilia e Napoli, all’incontro, mostrando velleità piccole e varie di sollevazioni. Il fatto sta, che, dei grandi imperii antichi o nuovi i quali furono al mondo, niuno forse fu piú mal connesso, piú mal costituito, piú mal governato che quello spagnuolo. Vantavasi che vi splendesse a tutt’ore il sole girando intorno[68] all’orbe. Ma quest’era appunto il gran vizio di esso; era immane e disseminato, forse oltre alla potenza governativa di qualsiasi governo, certo oltre a quella di que’ principi oziosi, e di que’ lor ministri e cortigiani depredatori. E giá s’era venuto sfasciando, scemando quell’imperio per ribellioni numerose: quella de’ mori di Granata, che, vinti e cacciati in Africa, lasciarono scemata la popolazione spagnuola; quella de’ Paesi bassi, staccatisi ed ordinatisi in bella e durevole repubblica; quella di Portogallo, rivendicatosi in regno indipendente; quella di Catalogna, erettasi essa pure a repubblica, quantunque per poco. Ultimi a seguir tali esempi furono i pazientissimi italiani; anzi ultimi e minimi, senza disegno, senza vigoria, senza prudenza, senza costanza, senza pro. Una carestia ne fu causa od occasione in Sicilia. Sollevossi la infima plebaglia contro al pretor di Palermo, che aveva scemate le pagnotte; poi contro a Los Velez viceré. Un Nino della Pelosa fu primo capopopolo; vollero accostarsi a’ nobili, e far re un de’ Geraci che avean nome di esser sangue dei re Normanni. Ma né questi volle, né gli altri nobili si scostarono da Spagna, né il popolo perdurò; e Nino con tre altri furono strozzati, quaranta mandati alle galere. Poi, una rissa tra alcuni servitori d’un nobile e alcuni plebei risuscitò il chiasso. Giuseppe d’Alessio, battiloro, ne rimase capo, fu gridato capitano generale del popolo, sindaco perpetuo di Palermo. Los Velez s’imbarcò, ed Alessio fece da viceré, governò assoluto e pomposo. Altre città si sollevarono. L’Alessio perdé il cervello, richiamò il viceré; ed unitisi, viceré, nobili ed ecclesiastici insieme, e stancandosi, al solito, il popolo, fu preso e decapitato, l’Alessio con una dozzina d’altri o piú, e tutto tornò come prima. —Né diversamente in Napoli, quantunque ivi fosse l’estremo della tirannia spagnuola. Narra il Botta che piú di cento milioni di scudi, cioè un cinquecentocinquanta milioni di franchi, i quali al ragguaglio del valore attuale de’ metalli sarebbono un miliardo e piú, furono tratti dal Regno in tredici anni [1631-1644] da due viceré; e che molte famiglie di Puglia e Calabria migrarono a’ turchi; e che un viceré si vantò di lasciar il Regno ridotto a tale, che quattro famiglie non vi rimanevano ove si[69] potesse cuocere una buona vivanda; e che disse un altro;—E’ si lagnano di non poter pagare? Vendan le mogli e le figliuole!—Succedette un viceré men cattivo, l’almirante di Castiglia, un respiro; ma poi il duca d’Arcos, di nuovo predatore e crudele. Il quale non sapendo piú di quale erba far fascio, quali gabelle aggiungere alle tante poste e cresciute, posene una sulle frutte, che sono lá pascolo de’ piú poveri. Al 7 luglio 1647, volendosi levar la nuova tassa, un fruttaiuolo rovescia irato i panieri, e li calpesta; si fa tumulto, e vi si pone a capo Masaniello, un pescivendolo, bel giovine e di credito fra’ popolani. S’avventano a’ palazzi de’ nobili, e vi rompono ed ardono quanto possono, ma senza predare; gridano voler i privilegi, lo Stato come era sotto Carlo V, ma non rinnegano l’obbedienza al re presente, e come in Sicilia, fanno un capitano generale del popolo, Masaniello. E questi pure governa con prudenza, giustizia e gran pompa alcuni dí. Cento sedici mila della milizia napoletana ei rassegna, non caccia il viceré, ne è trattato da pari a pari. Dura cosí un otto dí; poi anch’egli n’impazza a un tratto, dopo una visita al viceré che fu creduto l’attossicasse. Ma è chiaro che sarebbe stato piú facile e piú spedito farlo ammazzare, che farlo impazzir con veleno. Ad ogni modo, abbandonato dal popolo, alcuni congiurati l’ammazzarono a schioppettate come una fiera [16 luglio]. Il popolo lo seppellí con tardi onori, e non si posò. Fecero un secondo capitano generale, un nobile, Toraldo principe di Massa; e insospettitine, l’uccisero. Ne fecero un terzo, un popolano, archibusiere, Gennaro Annese. Sotto il quale o piú ribelle o traditore, o forse or l’uno or l’altro, s’inasprí il popolo, rinnegò l’obbedienza, ricorse al papa e a Francia da’ quali fu respinto, e al duca di Guisa, un signor venturiere francese discendente dagli Angioini. Venne costui, e governò il popolo coll’Annese; poi si guastò con lui, e Annese si raccostò all’Ognate nuovo viceré; e i due insieme, coll’almirante di Castiglia venuto su d’una flotta spagnuola, cacciarono il duca, che fu preso e condotto a Spagna, e tenutovi prigione a lungo; mentre l’Annese traditore fu tradito dagli spagnuoli, e preso pur esso e decapitato ed impiccati alcuni altri popolani. E cosí[70] finirono queste sollevazioni [1648]. Poco appresso il Mazzarino le volle ravvivare, e mandò con una flotta francese il principe Tommaso di Savoia, giá tutto spagnuolo, or avido di tôrre a Spagna un regno. Ma questi non approdò nemmeno. Succeduto poi a Filippo IV il figliuolo di lui, Carlo II, incapacissimo ed ultimo degli Austriaci spagnuoli [1665], sollevossi [1674] Messina, e chiamò francesi, e bandì re Luigi XIV, e guerreggiossi ivi e in gran parte dell’isola quattro anni; fino a che Luigi XIV e i francesi l’abbandonarono, e gli spagnuoli incrudelirono nelle vendette.—Ed anche a Fermo si tumultuò in simili modi, cioè inutilissimamente. Noi vedemmo giá intorno alla metà del secolo decimoquinto il tempo aureo delle congiure. Ora alla metá di questo decimosettimo si può dir quello delle sollevazioni popolari ne’ principati (perciocché non parlo di quelle fatte giá nelle nostre repubblichette, dove elle furono quasi mezzo legale o costituzionale di governo). Del resto, inefficaci vedemmo le congiure, ed inefficaci vediamo le sollevazioni. Ma, scellerate le prime senza dubbio e sempre, niun uomo ardirebbe dir sempre scellerate le seconde; non quelle sorte senza congiura, senza ambizioni, per giusta ira comune contro ad una vera e scelleratissima oppressione. Ma qui sta il punto, qui la gran differenza tra quelle sollevazioni del Seicento, e quelle che si fanno o si vorrebbon fare nell’Ottocento; ché allora appunto erano reali ed estreme le oppressioni, le tirannie, e toglievano le vite o i mezzi delle vite, le ultime sostanze al popolano, alla moglie ed a’ figli di lui: mentre ora non sono tali tirannie; e ciò che «tirannia» si chiama, non pesa su quelle vite o quell’ultime sostanze, né nemmeno su que’ popolani, ma piuttosto od anche solamente sulle ambizioni, sulle opere de’ ricchi nobili o borghesi, sulla partecipazione che essi desiderano a’ governi; la quale, sia pur giustamente desiderata, non è desiderata dall’universale del popolo, non importa a lui. Dal che si conchiude poi facilmente: primo, che quelle sollevazioni del Seicento furono senza paragone piú innocenti che non sono o sarebbon queste nostre; e secondo poi, che se quelle piú innocenti e sorte dall’offese vere fatte agli interessi popolari furono pure mal sorrette[71] dal popolo, molli, brevi, insufficienti, inefficaci, tanto piú è naturale che sieno queste, le quali si fanno o farebbono senza il motore degli interessi universali.
16. Vittorio Amedeo II [1675-1700].—Or torniamo all’ultimo quarto del languido Seicento, e finiamolo.—In Piemonte incomincia un nuovo regno anche piú lungo che non quello di mezzo secolo di Carlo Emmanuele I, sorge un principe anche piú grande, Vittorio Amedeo II. Fanciullo di nove anni, crebbe sotto la reggenza di sua madre, Maria Giovanna, nata d’un ramo collaterale di Savoia. Né fu turbata se non da una sollevazione di Mondoví [1679], fattasi contro alle tasse, e in breve per allora repressa. Nel 1681, Carlo Gonzaga carico di debiti vendeva Casale a Luigi XIV, il quale aveva giá Pinerolo, e diventava cosí piú che mai signore in Piemonte. E dicesi volesse diventare del tutto, e perciò favorisse un progetto di matrimonio del duca di Savoia con una erede presuntiva di Portogallo; sperando, ch’egli andrebbe a regnar lá, e Piemonte, governato da lungi, se ne scontenterebbe e volgerebbesi a Francia. Ma perciò appunto sollevossi l’opinione piemontese contro tale idea; e resta memoria, che uno della corte dicesse al duca, con parola piú grossa che non dico io:—Che altri sudditi andate voi cercando? Piú buona gente di noi non la troverete in nessun luogo.—Né, tolta la rozzezza, fu mai detta piú gran veritá, o piú utile a ridir ora per tôr di mezzo molte vane speranze e molti vani timori: non esiston popoli e principi piú fatti gli uni per gli altri, piú indissolubilmente uniti dai secoli e dalla natura, che piemontesi e casa Savoia.—Ad ogni modo, fu rotto il matrimonio portoghese. E intanto fatto adulto il duca e continuando la madre a voler reggere, egli sostò alquanto per rispetto e vergogna, ma scoppiò poi per natura, e prese in mano il governo. Era poi il tempo della maggior potenza o prepotenza di Luigi XIV, e si faceva sentire anche in Italia. Nel 1684, guastatosi con Genova per non so che affar di sali, la facea bombardare crudelmente, e il doge andava a far le scuse a Versailles. Quali tempi! Nel 1686, spingeva il giovinetto duca a volgersi contro a’ valdesi, e cacciarli di lor valli; come egli Luigi XIV[72] (dopo revocato l’editto di tolleranza di Nantes) avea cacciati gli ugonotti. Nel 1688, volle sforzare papa Innocenzo XI a lasciar l’asilo de’ malfattori nel palazzo dell’ambasciador di Francia a Roma; e non gli riuscendo, sequestrò Avignone. Ma quel buono e forte papa resistette allora colla pazienza; e tra breve resistette e sollevossi il duca di Savoia con l’armi. In Roma e Savoia era ogni resto di virtù italiana; l’ecclesiastica ne’ papi, la militare ne’ duchi piemontesi. Ai 3 giugno 1690, s’aggiunse Vittorio Amedeo alla lega di quasi tutta Europa contro al prepotente Luigi XIV, e riaprí lor valli a’ poveri valdesi. Scese Catinat a capo d’un esercito francese, e devastò Piemonte, incendiando case e villaggi, ed ammazzando popolazioni innocenti; e vinse una gran battaglia a Staffarda [1690]. Ma vinse il duca a Cuneo [1691] ed invase Delfinato [1692]; e stava per saccheggiare a rappresaglia, quando il vaiuolo sorvenutogli lo salvò di quella nequizia, e lo fece ritrarsi. Vinse Catinat una seconda gran battaglia a Marsiglia [1693]; ma perdé Casale nel 1695. Ondeché, stanco giá Luigi XIV, e volendo provedere colla pace alla prossima eventualitá della morte e della successione di Carlo II di Spagna, s’allentò in Italia la guerra, e s’incominciarono negoziati; e si conchiusero con un trattato [30 maggio 1696], per cui Vittorio Amedeo riebbe tutto suo Stato, Pinerolo stessa, quella ultima spina straniera rificcatagli in corpo. Che piú? In questo trattato, uno de’ piú belli firmati mai da casa Savoia, Vittorio Amedeo fece da arbitro d’Italia cosí, che vi patteggiò la neutralitá universale di essa. La quale poi non riconosciuta da Spagna sua antica alleata, ei si volse contro essa, e la sforzò ad aderire; e cosí egli condusse alla pace universale, che si fece poco appresso a Riswick [1698]. E quindi esso il glorioso guerriero e pacificatore, e il pacificato Luigi XIV, e Spagna, e tutti, posarono aspettando, ed apparecchiandosi con nuovi trattati (tutti inutili poi) all’evento della grandissima successione.—Nel resto d’Italia, intanto, non eran succeduti guari altri casi. In Parma, era a Ranuccio II succeduto il figliuolo di lui Francesco [1694].—Ed era succeduto nel medesimo anno a Francesco II, Rinaldo suo figliuolo, in Modena.—In Mantova e Monferrato[73] continuava Carlo II, il venditor di Casale.—E continuava Cosimo III in Toscana.—In Roma pontificò Innocenzo XI [Odescalchi, 1676-1689], buon papa, non nepotista, quegli che resistette a Luigi XIV, quegli che confortò l’immortal Sobieski, gl’immortali e generosi polacchi, a salvar dai turchi, cioè dalla distruzione [1683], quella casa d’Austria, quell’aristocrazia, quella Vienna, or tanto immemori! Seguirono Alessandro VIII [Ottoboni, 1689-1691]; Innocenzo XII [Pignatelli, 1691-1700], papa ottimo anch’egli, che non solamente non fu nepotista, ma fece una bolla [1692] contro al nepotismo, e vi pose l’obbligo di giurarla a tutti i cardinali entranti in conclave e a tutti i papi nuovi; onde fu, non estirpato pur troppo, ma scemato il brutto vizio, durante il secolo seguente. E governò lo Stato non solamente colla bontà solita, ma con ordine insolito colà.—Finalmente, Venezia anch’essa parve ridestarsi alquanto in quegli anni; ché aggiuntasi ad Austria e Polonia nella guerra contro a’ turchi, guerreggiò fortemente, costantemente, quindici anni [1684-1699], ed ebbe un ultimo grand’uomo di guerra e di mare, il Morosini; il quale conquistò a sé il nome di «peloponnesiaco», ed alla patria la Morea, Egina, Santa Maura e parecchi luoghi di Dalmazia. La pace di Carlowitz [1699] sancí tutte queste conquiste; sancì il primo indietreggiare della potenza ottomana, giunta al colmo, minacciante Germania e la cristianità poc’anni addietro.
17. Una digressione.—Io non so lasciare il tristo Seicento, senza spender alcune righe a combattere qui uno storico sempre eloquente e ben intenzionato, per vero dire, ma troppo sovente cattivo politico, a parer mio, cattivo intenditor de’ tempi che descrive, e di quelli a cui scrive. Il quale dice dunque di questi del Seicento: «Gran differenza si osservava allora in Italia fra i paesi soggetti alla signoria spagnuola ed a quella di Savoia d’un lato, e le due repubbliche di Venezia e di Genova, lo Stato ecclesiastico e la Toscana dall’altro: quelli erano infelicissimi; questi se non appieno felici, almeno in minor grado di infelicità costituiti. Della quale diversità assai manifesta è la cagione: i primi obbedivano a signori che si dilettavan di guerra; i secondi, a chi era amatore di pace». Ora io qui[74] veggo tre errori importanti a notare, siccome quelli d’uno scrittore il quale è forse piú di nessun altro nelle mani de’ nostri compatrioti; tre errori dico, uno storico, uno politico, ed uno filosofico o morale.—Errore storico o di fatto parmi il dire, che fossero egualmente o similmente infelici i popoli della monarchia di Savoia e quelli delle province spagnuole. Certo le sollevazioni popolari cosí frequenti, cosí grosse, cosí centrali de’ due regni spagnuoli, non furono nella monarchia di Savoia. Qui non s’ebbero, se non quelle molto minori, parziali, e per cause speciali, de’ valdesi e di Mondoví. E qui, all’incontro, fu fatta una sollevazione, tutta lealtà ed amore, da’ torinesi contra a’ francesi, un dí del 1611, che si sparse la voce, aver questi morto il duca Carlo Emmanuele I; il quale fu pure il principe di Savoia che abbia mai stancato di piú guerre e piú tasse i popoli suoi. Ancora, quell’altro Carlo Emmanuele II che morí in mezzo al popolo suo introdotto in palazzo (di che non so forse una piú bella scena in nessuna monarchia), quel Carlo Emmanuele II, egli pure avea stanco di guerra nella prima metà del regno suo e stanco di edificazioni nella seconda metà i popoli suoi. Come tuttociò? Come tant’amore reciproco? Certo, o bisogna dire che i piemontesi d’allora fossero il piú vil popolo del mondo ad amar cosí i loro oppressori (il che è dimostrato falso dalla loro perseveranza ed alacrità militari, che son qualità incompatibili coll’avvilimento de’ popoli); o bisogna dire che fosse pure alcun che, che unisse que’ principi e que’ popoli piemontesi sinceramente, strettamente, appassionatamente tra sé, a malgrado le gravezze. Né è poi difficile a scoprire quell’alcun che. Appunto, perché non vili originariamente, e non corrotti dalla invecchiata civiltà e dalle scellerate politiche del resto d’Italia, ma anzi nuovi, ma virtuosamente rozzi e quasi antichi erano que’ piemontesi, perciò virtuosamente, alacremente soffrivano le inevitabili gravezze recate dagli stranieri, e pesanti sui principi loro non meno che su essi; e soffrendole insieme, si compativano, si stringevano, si amavano; ed insieme con amore operando, erano meno infelici nelle sventure, felicissimi ne’ ritorni di fortuna. E poi, qual paragone fare tra le gravezze,[75] tra le tasse piemontesi, fossero pure eccessive ma rimanenti in paese, e quel miliardo che lo stesso Botta accenna portato via in tredici anni dal solo Regno di qua del Faro? Qual paragone tra le vite spente sui campi, od anche tra gli stenti di guerra, e quelle spegnentisi a poco a poco sotto alle spoliazioni fatte dai viceré stranieri, e lor cortigiani spagnuoli o regnicoli, e lor donne, e lor servi, ed i servi de’ loro servi? Quale sopratutto (se agli effetti umani si miri solamente) tra la stessa immoralità, libera almeno, della corte piemontese, e quelle infami parole, «vendan le mogli e le figliuole»? No, no, non son sogni poetici o filosofici, sono realità della natura umana (non cosí corrotta, grazie al cielo, come la dicono troppo sovente quello ed altri storici piangitori), sono realità le consolazioni della nazionalità, dell’unione, del sacrifizio, dell’amor reciproco di principi e popoli, concordemente soffrenti o trionfanti.—Più grave ancora parmi l’error teorico o politico del dividere l’Italia del Seicento troppo innaturalmente: Savoia indipendente e province spagnuole da un lato, e tutti gli altri Stati piú o meno dipendenti dall’altro lato. Qui è tutto perduto di vista quel sentimento d’indipendenza, che è giá altrove troppo sovente negletto da quello ed altri scrittori di nostre storie; e che, ripetiamolo, è quello pure che ispira e guida senza eccezione tutte le storie dell’altre nazioni antiche e moderne. Quando cosí veramente, come non furono, fossero stati del paro infelici Piemonte indipendente e province spagnuole, quando del paro piú felici gli altri Stati italiani, la divisione non dovrebbe farsi a questa norma della felicità, ma a quella sempre, a quella sola della indipendenza. O siamo italiani, o non siamo. Ma se, come certo il voleva ed era Botta, noi siamo; non sono i gradi di felicità, ma quelli della nazionalità, a cui dovremmo badare per istabilir le differenze, le divisioni degli Stati italiani. Dal dí, che, sceso Carlo VIII, incominciarono ad essere in Italia Stati stranieri e Stati nazionali, questa differenza fu, è, e sarà sempre la essenziale da osservare; quella, rimpetto a cui non sarebbe da badare a felicità, se non che appunto la felicità materiale per lo piú (si ritenga a mente il miliardo), e sempre poi la[76] morale (si ritenga il consiglio di vender moglie e figliuole), furono, sono e saranno dalla parte della nazionalità o indipendenza. —Finalmente, error morale o filosofico mi par che sia il dire cosí assolutamente causa d’infelicità la guerra, causa di felicità la pace. Noi viviamo in tempi di pace, e, dirollo francamente contro a molti di qua e di lá, virtuosa perché operosa pace, in generale. Ma se, ma quando o dove la pace nostra non fosse operosa, quando e dove somigliasse a quella oziosissima in che marciva tanta parte d’Italia nel Seicento, io m’affido che nessuno un po’ altamente senziente direbbe piú siffatta pace felice. Certo cbe le vite degli uomini sono un gran che; certo che lo spegner vite in pace a vendetta, a profitto privato od anche pubblico, senza missione, od anche con missione, ma senza necessità, è un gran delitto; e ciò fu mostrato, ciò svolto mirabilmente da un altro illustre scrittor nostro, il Gioberti, nelle piú belle pagine di lui. Ma in guerra, ma lá dove il sacrifizio delle vite è volontario, legittimo, bello e santo, egli è pure talor felice a chi il fa, e sempre alla patria per cui si fa; ed è, perdonamelo tu, o figliuol mio, meno crudele agli stessi sopravviventi. Senza sacrifizio della vita non si fa nulla di grande, nulla anzi di normale in questo mondo. Il mondo va innanzi a forza di vite sacrificate. Una vita divina ed umana sacrificata è il piú gran fatto della storia umana. Una intiera metà del genere umano, quella che chiamiamo la debol metà, fa il sacrifizio della vita continuamente per noi. Senza un sacrifizio uguale, senza il compenso della guerra principalmente, la viril metà rimarrebbe inferiore a quella chiamata debole; non compenserebbe sacrifici con sacrifici, non darebbe vita per vita a quelle dolci creature che gliela offrono ogni dí. E in Italia, dove pur troppo colla scemata operosità sono scemate le occasioni de’ pericoli virili, non è opportuno, né virtuoso, scemar con parole la dignità della guerra; dico, della legittima guerra in difesa o ricuperazione de’ diritti della patria o della cristianità.—E mi si perdoni essermi fermato a segnalar siffatti errori. Gli errori de’ grandi sono i soli che ne vaglian la pena; e chi ciò fa, fa atto di rispetto a lor grandezza.
18. Le colture straniere derivate dall’italiana in questo periodo [1559-1700].—Noi dicemmo che i diversi popoli cristiani, tedeschi, francesi e spagnuoli, accorsi da parecchi secoli in Italia, non presero, dopo la rivoluzione comunale, guari nulla dalla nostra civiltà. Ma presero incontrastabilmente non poco dalle nostre colture fin dal secolo decimoquarto; molto, quasi tutto, quando nel decimosesto essi si mescolarono con noi, invadendoci. Parrebbe che i primi a prenderne avrebber dovuto essere tedeschi, cosí mescolatisi molto piú anticamente. Ma, fosse la diversità delle due nature settentrional-tedesca e meridionale-italiana, o che, quando appunto essi furon maturi a prendere nostre colture e mentre giá le prendevano, essi fossero disturbati dalle preoccupazioni, dall’invidie religiose della Riforma, il fatto sta che essi non furono né primi, né secondi, né terzi, ma solamente quarti a questo grande e bel convito da noi imbandito. Né furono primi i francesi, che pur parrebbono aver ciò potuto; essi pure ebbero, quantunque in grado minore, l’uno e l’altro impedimento.—Ad ogni modo, primi furono gli spagnuoli, fratelli nostri meridionali, gemelli nostri di lingua, e come noi, la Dio grazia, rimasti puri da quelle contese religiose che distraggon naturalmente da tutto. Già accennammo che la lingua spagnuola fu, piú anticamente che non l’italiana, scritta nelle loro leggi e ne’ loro canti nazionali, o romances; ma, salvo in queste e poche altre poesie, ella non comparisce letterariamente scritta, se non guari al principio del secolo decimosesto. E comparisce allora primo, o de’ primi, Garcilazo de la Vega gentilissimo poeta, tutto imitatore, ma non servile, del Petrarca e de’ nostri bucolici del Quattrocento. E seguiron via via altri pur tali, che non nomineremo, per non rifare senza necessità di quegli elenchi, co’ quali lo scrittore scontenta sempre tutti i leggitori; gli eruditi, che li trovano mancanti; gli altri, che li trovano sempre soprabbondanti di nomi illustri. Noteremo bensì che la poesia spagnuola si staccò dalla nostra, e superolla di gran lunga sul teatro; dove, tra molti altri, fiorirono Lope de Vega e Calderon, superiori a tutti i contemporanei, salvo l’inglese Shakespeare. Ma di nuovo procedettero da noi e da’ classici[78] latini risuscitati da noi, i prosatori spagnuoli, gli storici principalmente, primo e principale Mariana, che diede, fin dal secolo decimosesto, a sua patria ciò che non abbiam dato ancora alla nostra, una storia nazionale. All’incontro, pur si staccarono da noi i novellatori spagnuoli, e sommo fra essi, tra i sommi di dappertutto, Cervantes, lo scrittore del Don Chisciotte. In altri generi di prosa non fecer gran frutto; era naturale, non son frutti da colture serve, o peggio da tiranneggiate. E poco fecero in filosofia spirituale; nulla (tralasciando sempre le glorie ignote scoperte da’ frugatori), nulla in filosofia materiale. Ma fecer molto piú che niun popolo non italiano, in arti. Qui piú che in null’altro vedonsi gemelli i due popoli meridionali. Come tutti, gli spagnuoli preser lor arti dalle nostre; ma le preser primi, e vi furono sommi dopo noi, incontrastabilmente secondi. Juan Juanez, il divino Morales ed altri numerosissimi, fra cui s’alza quella triade di Ribera, Velasquez, e sopra tutti Murillo, fanno una scuola ridivisa in altre cosí ricche d’artisti e di mirabili opere d’arte, che non ha l’ugual finora in Francia, Fiandra, Olanda, Germania, o peggio, Inghilterra. E tutto ciò era fatto, ed anzi, giá finito, giá decaduto al finir del secolo decimosettimo.—Seguí seconda delle colture derivate dall’italiana nuova e dall’antica risuscitata, la inglese. Il grandissimo Shakespeare e il gran Bacone sono tutti e due del principio del secolo decimosettimo, quando non era vero fior di coltura fuori d’Italia e Spagna. E il primo prese dall’una e dall’altra i soggetti, i modi, tutte quelle quasi materialitá dell’arte che i sommi non si dan guari fatica a mutare (come fanno i piccoli che non posson altro), certi che sono quelli di riuscir grandi con qualsiasi strumento in mano. Bacone poi egli pure prese molto da’ nostri, dal suo contemporaneo Galileo principalmente; e se non temessi cadere anch’io in quel vizio uggioso di attribuirei noi cosí ricchi le glorie altrui, direi che prese tutta l’essenza di sua gloria, il metodo sperimentale, non solamente giá inventato, ma praticato da Galileo. E terzo grande di quella gran coltura trovasi poi, a mezzo il secolo decimosettimo, Milton, che anch’egli fu e si professò italiano in molte parti, che fu dantesco[79] in alcune, benché poi, come tutti i grandi, simile a sé solo in quelle che fanno sua grandezza. E finalmente sorse verso la fine del medesimo secolo, quarto grande di colá, grandissimo dappertutto, Newton. Questi non imitò nessuno, s’innalzò sulle spalle a tutti, Copernico, Keplero (la sola luce di coltura germanica in tutto questo periodo), e Galileo. E tutto ciò pure era fatto colá alla fine del secolo decimosettimo; ma non era finito. Ché senza decadenza, dopo un riposo, dopo una serie di minori per mezzo secolo, ricominciò colá una nuova etá di poeti, e novellatori, e filosofi materiali e spirituali, e storici, ed oratori, e scrittori economici e politici; giunti quasi tutti in cima a ciascuno di quei generi.—Intanto sorgeva, terza delle derivate, la coltura francese, e (ci si conceda la frase fatta triviale dagli esageratori) sorgeva gigante intorno alla metá del secolo decimosettimo. Prima d’allora, non erano che Montaigne, De Thou, Malherbes. Ma intorno a quell’epoca, dopo le guerre religiose della lega, tra quelle dell’ultimo libero fiatar dell’aristocrazia francese dette della Fronda, sorgono a un tratto sotto Luigi XIV (il quale anch’egli colse cosí le frutta maturate prima di lui) Descartes, Pascal, Corneille, Racine, Molière, La Fontaine, Malebranche, Bossuet, Massillon, Bourdaloue, Sévigné, uomini e donne immortali tra una folla od anzi un esercito disciplinato di minori. I quali tutti, piú che altrove, furono e si professarono seguaci de’ latini, degli italiani e degli spagnuoli primogeniti loro. Veggonsi squarci, scene intiere italiane nelle commedie, citazioni italiane nelle lettere famigliari, classici italiani studiati da Boileau e dagli altri critici; Régnier ed altri, scriventi poesie e prose italiane; e la lingua elegante, la lingua di moda ed affettata in corte, essere stata l’italiana; appunto come s’affettò poi da noi la francese, ed or s’affetta l’inglese, con grave ma inutile scandalezzarsi di alcuni nostri. Sempre, dappertutto s’affettaron le lingue de’ piú colti ne’ paesi piú incolti: né giovano scandali ed esortazioni; il solo rimedio che vi sia, è scriver bene ed utilmente anche noi; il solo modo di porre o ripor una lingua alla moda, è di porla o riporta all’opera, dico a molta e grande[80] opera.—E di famiglia piú che mai italiana furono l’arti francesi; e tali si mostrarono principalmente i due sommi artisti di colá, Poussin e Claudio, che vissero in Italia, e ritrasser figure e paesi tutto italiani; e tutti gli altri poi, i quali, salvo Lesueur, studiarono e imitarono in Italia. Ed in Francia pure tutto ciò era fatto in poco piú di cinquant’anni, al chiudersi del secolo decimosettimo. Ma in Francia neppure non era finito; che anzi (mi duole il dirlo per que’ misogalli che or abbondano tra noi, ma troppo tardi di mezzo secolo), che anzi, non fu mai colá niun intervallo o riposo, non fu piú una sola generazione letteraria o scientifica senza i suoi grandi, fino a’ nostri dí.—Ed ora, senza contare le colture minori, né la germanica allor sorgente in Leibnizio, ora, dico, che si fece, in che si progredí egli contemporaneamente in Italia? in quell’Italia madre della coltura antica latina presa allora a modello universale, madre del risorgimento di quella, madre della sola coltura moderna che fosse stata da tre secoli, stipite dunque indubitato di tutte quelle colture straniere or cosí splendide? In Italia caddero allora piú o meno tutte quante le colture; caddero le une a un tratto, le altre a poco a poco ma pur pronte, tutte quelle lettere che giá trovammo costanti compagne delle libertá interna ed esterna, la poesia, la storia, l’eloquenza, la filosofia spirituale; ritardaron piú lor caduta le arti, che trovammo men costanti alla libertá, piú cortigiane, ma pur caddero; e sole fecero un vero e gran progresso quelle scienze materiali, che trovammo le piú indifferenti alle due libertá. Né caddero certamente le nostre colture per difetto di principi protettori, di grandi mecenati, di corti letterate; ché anzi, grandi, corti e principi d’allora, ne faceano pompa e gara; caddero a malgrado, anzi a cagione di queste stesse protezioni, corrotte in ozi, corrotte a’ vizi, corrotte perciò di gusto inevitabilmente. E quindi, questo nostro Seicento, o piuttosto questi centoquarant’anni di che trattiamo, sono forse il piú chiaro e compiuto commento che si trovi in tutta la storia umana, di questa veritá cosí importante a capacitarcene da senno tutti noi, scrittori liberi, scrittori protetti, o protettori: che la decadenza politica delle nazioni[81] trae e mantiene inevitabilmente seco la decadenza delle colture; che certo sono cose buone le protezioni, le spese, i premi, le onoranze, i musei, le biblioteche, le scuole, le cattedre e le universitá, ma ch’elle non servono di rimedio sufficiente alle colture decadute, finché non si rimedia alle decadute civiltá.—Ma veniamo a’ particolari di ciò che furono tra quei grandi stranieri, i pretesi grandi nostri de’ centoquarant’anni. Non si dimentichi mai tal contemporaneitá da chi voglia giudicarne rettamente, utilmente.
19. Colture di questo secondo periodo [1559-1700].—Chi voglia vedere a un tratto che fossero i principi protettori, le corti ospitali e i letterati protetti ed ospitati di questo periodo, può vederlo nella vita di Torquato Tasso. Altro che la corte di Can grande e Dante! Piú giú in protezioni non s’andò mai, né da una parte né dall’altra. Eppure niuna natura forse mai nacque poetica e generosa come quella; e perciò piegando si ruppe. Nacque [11 marzo 1544] in Sorrento di Bernardo Tasso da Bergamo, poeta di conto e giá cortigiano; avea dunque esempi domestici, e quindici anni d’etá nel 1559, all’epoca della servitá d’Italia. Studiò leggi; lasciolle, e intanto fece il Rinaldo, e incominciò la Gerusalemme. E dedicato il primo al cardinale Luigi d’Este, entrò in quella corte adolescente. S’innamorò (che par chiaro da molte testimonianze) di Leonora, sorella di quel cardinale e del duca Alfonso secondo; ed a coprir quell’amore, o poterne pur poetare, amò o finse amare una seconda e forse una terza Leonora. Questi amori principeschi e queste finte, o, come si dicevano, schermi, eran di moda fin da’ tempi di Dante e di Boccaccio. Ma eran fuor di tempo in questi secoli, d’amoreggiamenti bensí, ma di gradi regolatissimi, di corti ordinate a ciò che chiamavasi «etichetta» o «sussiego» spagnuolo. Né par che fosse mai a Torquato niun amore felice. Povero poeta! Niuno forse visse mai tanto d’imaginativa come lui; niuno conobbe meno le gravi felicitá della famiglia. Cosí passò sua mesta gioventú in Ferrara, e viaggiando or in Italia, ed una volta a Parigi col protettore; e facendo l’Aminta ed avanzando nella Gerusalemme. Crescean sue glorie, ma con esse le invidie, le amicizie[82] traditrici, le protezioni fatte sentire, e il suo irritarsi, esaltarsi e divagare; ondeché, per istudio che se ne sia fatto (e niuno forse fu fatto tanto), mal si discernono le colpe de’ protettori e del protetto; e si conchiude con certezza, che mal potean durare l’un con gli altri. L’opinione piú volgare è che scoppiasse, forse concitato dalla gloria, il suo amore; e il duca, offesone, trattasse da pazzo (per clemenza!) il poeta cortigiano; e cosí trattandolo, il facesse impazzir davvero. Un’altra parmi possibile a sostenersi: che il povero Torquato, inquieto per natura e malcontento come Dante, come è inevitabile a un generoso caduto in tal purgatorio, pensasse mutar sito almeno, e passare alla corte o d’Urbino, o di Mantova, o di Firenze, o di Torino; e che di ciò s’indispettisse il padrone (cosí chiamavasi ed era); e questi dispetti reciproci fosser la sola o prima o seconda causa del mezzo impazzir del poeta, seguito da persecuzioni, seguite dall’impazzir ulteriore. Scoppiò tutto ciò, ad ogni modo, un dí che Torquato trasse il pugnale contro a un altro cortigiano in camera della duchessa. Fu imprigionato brevemente, poi rilasciato a condizione di curarsi della pazzia. Ma l’ingiunzione o la cura esacerbarono il male; entrò, volontariamente o no, in un convento di frati (una delle sue malinconie eran gli scrupoli); peggiorò, fuggí nel 1577, capitò a Sorrento dalla sorella, poi a Roma; fu perdonato, tornò in corte a Ferrara. Poi ne fuggí una seconda volta; fu a Mantova, a Venezia, ad Urbino, a Torino; e tornò a Ferrara una terza volta [1579], trattovi dall’abito o dall’amore. Ed ivi, fosse nuovo scoppio di questo o dell’ira sua o del duca, o dell’incompatibilitá reciproca, ivi in breve fu di nuovo preso e chiuso in Sant’Anna, l’ospedale de’ pazzi. Mentre era lí, fu pubblicato in parte, e per tradimento, il suo poema in Venezia [1580], poi tutto con suo consenso [1581]; mentre era lí, l’accademia della Crusca gli si avventò contro bruttamente; e lí egli impazzí davvero, o poco meno; e lí fu tenuto sette anni. Liberato finalmente per intervenzione di altre corti, di quasi tutta Italia [5 luglio 1586], errò nuovamente a Genova, a Mantova, a Bologna, Loreto, Roma, Napoli, di nuovo Roma, Firenze, Mantova, Roma, Napoli, e finalmente a Roma per la quarta ed[83] ultima volta. Volea tornare a Ferrara! Il duca non volle, e fu piú savio. Ritirato al convento di Sant’Onofrio, ivi morí [25 aprile 1595] piú tranquillo che non era vissuto; indi salí ad un’altra realitá, egli che non avea capita mai questa della presente vita. Predecessor di quegli illustri infelici di Rousseau, di Chatterton e di Byron, forse piú grande, certo migliore e piú realmente infelice che tutti questi, lasciò un poema (sia detto a malgrado una moda presente contraria) mirabile di poesia, ma giá macchiato di que’ concetti che pervertirono poi letterariamente le lettere italiane, piú macchiato di quella mollezza allettante e penetrante che pervertí moralmente ed effeminò quelle lettere.—S’accrebbero poi i due pervertimenti, e talor anche per eccezione si fermarono e indietreggiarono ne’ seguenti e ad ogni modo minori poeti: Guarini [1537-1612], Chiabrera [1552-1637], Tassoni [1565-1635], Bracciolini [1566-1645], Marini [1569-1625], Fulvio Testi [1593-1646], Lippi [1606-1664], Salvator Rosa [1615-1673], Filicaia [1642-1707], Menzini [1646-1704], Guidi [1650-1712], Zappi [1667-1719]; oltre poi gl’infimi e piú pervertiti.—Nella prosa, Paolo Segneri [1624-1694] ha nome di primo oratore sacro tra gl’italiani; ma lontano da’ grandi francesi, è concettista pur egli; e tali sono poi parecchi altri predicatori contemporanei e seguaci di lui, con tanto piú scandalo, quanto piú grave è l’ufficio loro che non quello di poeta. In istoria, sono forse men parolai, meno retori che i loro predecessori, ma meno eleganti e men profondi, fra Paolo Sarpi [1552-1623], Davila [1576-1631], Bentivoglio [1579-1644], Pallavicini [1607-1667]; ed all’incontro, parolaio e fiorito oltre alle convenienze storiche, seicentista insomma, mi sembra il Bartoli [1608-1685]. Il Boccalini [1556-1613], scrittor politico, è da onorar senza dubbio, per essersi rivolto contro agli spagnuoli, tiranni d’Italia; ma vi si rivolse con leggerezza forse soverchia per argomento cosí grave ed affliggente. Meglio il Paruta [1540-1598] e il Botero [1540-1617]; scrittori seri e per il tempo virtuosi, ma non abbastanza grandi per farsi leggere, passati i tempi per cui scrissero, non abbastanza efficaci per aver lasciato effetto nella patria. E quindi resta forse[84] superiore ad essi il Gravina [1664-1718], gran giureconsulto.—Lo Scamozzi [1552-1616], il Dati [1619-1676], il Baldinucci [1624-1696], scrittori d’arti, non arrivano all’autoritá ed all’efficacia de’ primi cinquecentisti, e massime non a quelle di Leonardo e Vasari; ma occupati nelle cose loro piú che nelle parole, si tenner puri almeno dalle affettazioni. E cosí Montecuccoli, gran capitano ed ottimo scrittore dell’arte e delle azioni proprie [1608-1681].—Del resto, non lasceremo quelle lettere del Seicento, e quel vizio d’affettazione che appunto si chiama da noi «seicentismo», senza notare: che esso fu, per vero dire, delle lettere italiane piú che delle straniere contemporanee, in generale; ma che nemmeno queste non ne andarono scevre, sia che il prendessero da noi, imitando insieme colle vecchie virtú nostre anche i nostri vizi nuovi, sia che all’incontro noi maestri prendessimo questo brutto vizio da’ nostri primi scolari, gli spagnuoli. Certo, che il seicentismo pare aver colá preceduto il Seicento come e piú che da noi; e certo è che vi giunse a’ medesimi o maggiori eccessi, e v’infettò piú grandi, Lope e Calderon istessi: ed io direi lo stesso Cervantes; se non che mal si distingue in lui, ciò che ei n’abbia da senno o per celia. Ad ogni modo, non è dubbio, il seicentismo ebbe allora suo regno piú o men lungo e piú o meno assoluto, e suoi nomi particolari in ogni paese; «gongorismo» in Ispagna, «eupheismo» alla corte d’Inghilterra, e stile, modi, donne ed uomini «preziosi» a quella di Francia ed al palazzo Rambouillet.
20. Continua.—Lontani poi d’ogni affettazione come scrittori, e superiori in tutto a’ lor contemporanei italiani, furono i cultori di scienze materiali, Galileo [1564-1641], Torricelli [1608-1647], Viviani [1622-1703], Cassini [1625-1712], Redi [1626-1697], Malpighi [1628-1694], Magalotti [1637-1712], Vallisnieri [1661-1730]: ma grandissimo fra essi, motor di essi, anzi di tutto il progresso scientifico che si palesò a que’ tempi, Galileo. Attese nella prima gioventú alla musica, al disegno, alla poesia, alla medicina. Ma venuto per istudiar questa a Pisa, studiò matematiche; e nel 1589 ne fu eletto professore. Subito lasciò l’orme antiche, professò con novitá; e subito ne portò le[85] pene solite, l’ira di coloro che non sanno o non voglion esser nuovi, l’invidia de’ mediocri che si paragonano da vicino. Intanto, come pur succede, era onorato da’ piú lontani. Chiamato a Padova, v’andava nel 1592 e vi rimaneva fino al 1610; in che pubblicava il Nuntius sidereus. Allora era richiamato a Pisa «senza obbligo di leggere né risiedere». Risiedé a Firenze principalmente, e come in corte al granduca. Egli avea trovate giá allora parecchie conseguenze ed applicazioni del moto del pendolo, il telescopio rifrattivo, i satelliti di Giove ed altre novitá; e con queste e con vari scritti erasi fatto seguace e confermatore del sistema di Copernico, pubblicato, del resto, fin dal 1543, e tollerato d’allora in poi dalla curia romana. Ma incominciò ora un frate a Firenze ad assalirlo; e in modo degno del secolo, bisticciando sul nome giá immortale, e sul testo sacro della Bibbia «Viri galilaei, quid statis adspicientes in coelum?». E qui è da confessare, il Galileo cadde in un errore, di che fu ripreso dal Sarpi contemporaneo suo, un error da grand’intelletto speculativo mal pratico degli uomini, quello di credere di poter con ragioni tolte da una serie di cognizioni e d’idee persuader coloro che sono tutto fuori di quella serie, e tutto dietro ad un’altra. Egli il primo cambiò «la questione fisica ed astronomica in teologica», egli forse discusse con superbia acquistata dai meriti contro a superbie immeritate; e queste, urtate, si sollevarono. Andò a Roma piú volte a spiegarsi, a spiegare; ne tornò via via con divieti piú urgenti di non sostenere il sistema. Egli il promise; e non so s’io dica che vi mancò nel 1632, quando stampò i suoi Dialoghi, posciaché li fece prima approvare a Roma. Ad ogni modo, l’approvazione non bastò; nuovi frati e non-frati gli si sollevarono contro; l’Inquisizione citò il vecchio poco men che settuagenario; egli v’andò, fu processato, sostenuto in casa al fiscale dell’inquisizione, esaminato, e, dicono alcuni, negano i piú, torturato. Finalmente fu condannato a ritrattarsi, ed alla prigionia; la quale gli fu mutata per grazia in confino, a casa dell’amico Piccolomini arcivescovo di Siena, e poi a Bellosguardo ed alla propria villa d’Arcetri. Ed ivi visse gli ultimi anni suoi; ivi perdé gli occhi[86] nel 1637, e morí addí 8 gennaio 1641. Il processo di Galileo è brutto senza dubbio per li prelati che v’ebber parte; ma le carceri, i tormenti aggiuntivi sono gravi esagerazioni, e piú grave quella di attribuire alla Santa Sede l’opera dell’Inquisizione. Del resto, non rifarem noi l’errore di Galileo; lasceremo la questione teologica; e tenendoci alla politica, noteremo che quella persecuzione resta gran vergogna della corte che la mosse, di quella che la sofferse, di tutto il secolo in mezzo a cui si fece; e che se i due nomi di Tasso e Galileo bastano a dimostrare la perennitá, la varietá, la feconditá dell’ingegno italiano anche in secolo di massima decadenza, le due vite di que’ grandi bastano a dimostrar viceversa quanto fosse indegna di essi, discorde da essi la loro nazione in quel secolo.—E quindi si potrebbe argomentare a priori ed a fortiori, che questo non poté esser grande in quella filosofia spirituale che alcuni pretendono conformare le generazioni, ma che io crederei anzi per lo piú conformata dalle qualitá morali, intellettuali e religiose di esse. E restano poi le opere di que’ filosofi (molto vantati ai nostri dí, per vero dire, o per la smania di aggiungere alle incontrastate glorie nostre le contrastabili, ed ai grandi secoli nostri un secolo di piú, o talor per la smania peggiore di trovar grandi i nemici del cattolicismo), restano, dico, le opere di Vanini [1535-1619], Giordano Bruno [1550-1600], Campanella [1568-1639] e di Telesio [n. 1509], a dimostrare, che fu mediocre la filosofia spirituale italiana a que’ tempi; se pur mediocri si voglian concedere le filosofie ingegnose, acute, ardite ed anche in parte progressive, ma mal logiche, mal compiute, non consistenti in sé, non tetragone, non combinanti le proprie parti, e retrograde anzi in molte parti; le filosofie insomma che progrediscono andando allato ma non dentro la via della veritá. Del resto, non saremo noi a negare un grande benché mal promosso pensiero del Campanella. Povero frate in un convento ideò la liberazione d’Italia dagli spagnuoli. Lontano d’ogni pratica, fu un generoso sognatore.
21. Continua.—Se fosse vera in qualche parte quella tristissima teoria che tiene inevitabile in ogni cosa umana la successione[87] periodica dell’accrescimento, dello splendore culminante, e della decadenza, certo ella dovrebbe esser vera principalmente in fatto d’arti. Perciocché, mirando queste al diletto, ed uno de’ maggiori diletti umani consistendo certamente nella novitá, e la novitá dopo l’ottimo essendo necessariamente men buona, pare immanchevole che dopo l’ottimo debba venire il men buono e il cattivo. Eppure il fatto non fu sempre cosí, non fu, se non con tante eccezioni e varietá, che ne rimane annientata la regola, la trista teoria. Nella Grecia e nell’Italia antiche, per esempio, lo stile ottimo durò parecchi secoli; in Egitto, nell’Indie, nella Cina non vi s’arrivò mai. E cosí nell’Italia, feconda a tutto, quando non sieno troppo contrari i venti, feconda principalmente a quell’arti che s’adattano meno male ai cattivi, nell’Italia moderna decaddero sí la scuola primitiva toscana e le nuove romana, veneziana e lombarda, ma sorse e risplendette la nuova scuola bolognese, che non si può dir né culminante né decadente; e la decadenza vera non incominciò se non dopo questo periodo secondo di splendore. Lasciamo dire i tristi profeti; la natura umana non è infinita per certo, ma è pur certamente indefinita; e in arti principalmente ella può trovar del nuovo e bello senza fine, purché non s’abbassi, non s’avvilisca, non si faccia incapace essa stessa. Del resto, essendosi avanzata l’arte incipiente in ciascuna delle scuole italiane con una virtú principale e distinta, l’arte giá progredita non poteva guari progredire ulteriormente se non ecletticamente, scegliendo il buono d’ogni scuola antica o nuova; le imitazioni delle virtú primitive son sempre affettazioni, e somigliano al bamboleggiar de’ vecchi. Ciò intesero, od anzi a ciò furono portati da lor natura e lor tempo, i nostri artisti bolognesi; ed a ciò, del resto, i loro contemporanei spagnuoli e francesi. Fondatori di quella scuola eclettica che non si dee dir derivata veramente né dal Francia né da altri piú antichi, furono Ludovico Caracci [1555-1619] e i due cugini di lui, fratelli tra sé, Agostino [1558-1601] ed Annibale [1560-1609], oltre altri di quella privilegiata famiglia. Seguirono Guido Reni [1575-1642], Albano [1578-1660], Domenichino [1581-1641], Guercino [1590-[88]1666], tutti grandi, oltre una schiera di minori, fino intorno alla metá del secolo decimosettimo. Allora solamente decadde questa scuola e con essa tutta l’arte italiana. Perciocché eran decadute l’altre intanto; la toscana dopo Michelangelo e il Vasari che dicemmo, e il Bronzino [1502-1570]; benché vi risplendessero ancora Pietro da Cortona [1596-1669], e il Dolci [1616-1686]. La veneziana decadde giá coi Bassano [1510-1592], il Palma giovane [1544-1628?] e il Padovanino [1590-1650]. La romana, decaduta giá dopo Raffaello, decaduta piú dopo la morte degli allievi di lui, decadde peggio che mai dopo la generazione terza, che fu del Baroccio [1528-1612], Michelangelo da Caravaggio [1569-1609], e Carlo Maratta [1625-1713]. E dieron lampi la scuola napoletana per Salvator Rosa [1615-1673] e Luca Giordano [1632-1705]; la genovese per Luca Cambiaso [1527-1585]; e la piemontese stessa per Moncalvo [1568-1625].—La scoltura, portata da Michelangelo ad uno stile piú ardito e grande che non puro e posato come l’antico, decadde tanto piú presto; le arditezze e le esagerazioni furono portate al colmo dall’Algardi [1602-1654], e massime dal Bernino [1598-1680]. I quali poi insieme col Borromini [1599-1667], il Guarini [1624-1688] e parecchi altri, portando i medesimi vizi nell’architettura, fecero peggiorar questa, oltre l’altre due arti sorelle; e secondati dalle magnificenze de’ principi, de’ grandi e de’ religiosi di que’ tempi, moltiplicarono in Italia que’ palazzi, quelle ville, quelle chiese, il cui stile fu vituperato giá (or quasi rionorato per istrano capriccio) sotto nome di «barocco». E fu di tale stile guastata la facciata stessa di San Pietro; ma se ne salvò per felice eccezione il Bernino nella colonnata che le serve di pronao.—La musica all’incontro (la piú cortigiana dell’arti senza paragone) progredí indubitabilmente in questi tempi. Ma forse s’ammollí passando dalla chiesa ai teatro. Moltiplicaronsi le opere in musica lungo tutta la seconda metá del secolo decimosesto. Perfezionaronsi coll’invenzione del recitativo, or quasi sbandito. L’Euridice del Peri, cantata nel 1600 a Firenze, ha nome (pur disputato) di prima opera cosí compiuta. E in esse e nella musica di chiesa risplendettero, Carissimi, Mazzocchi,[89] Allegri [1640], Scarlatti [1650-1725]. Il famoso Miserere della cappella pontificia è dell’Allegri. Né questo fu tuttavia il secolo d’oro della musica italiana. Giá l’accennammo, fu riservata siffatta consolazione, qualunque sia, ai nostri dí.
22. Gl’italiani fuor d’Italia.—Né lasceremo questi tempi senza fermarci a una gloria italiana giá antica, ma che si moltiplicò in essi senza paragone. Fu accennato da noi in altro scritto (ed era contemporaneamente, piú che accennato, fatto in gran parte dal Ricotti): una storia intiera, e magnifica, e peculiare all’Italia, sarebbe a fare degli italiani fuor d’Italia. Tutte le nazioni senza dubbio ebbero fuorusciti volontari o no: ma niuna cosí numerosi o cosí grandi come la nostra. Si potrebbe incominciare quella storia da Paolo Diacono, lo storico di sua gente caduta, in corte a Carlomagno; e continuar poi, non solamente con quegli oscuri e innominati mercatanti italiani che estesero l’industria e il commercio in tutta Europa e vi furon noti sotto nome di «lombardi», ma coi nomi di molte famiglie che cacciate dalle nostre discordie e nostre invidie repubblicane portarono fuori (in Avignone e Provenza principalmente) quei nomi giá illustri nella loro prima patria, diventati grandi alcuni nella seconda. E verrebbero insieme o poi i grandissimi nomi di Gregorio VII, Lanfranco, Pier Lombardo, sant’Anselmo, san Tommaso, san Bonaventura e Marco Polo; e quelli di tutti e tre i padri di nostra lingua, Dante, Petrarca e Boccaccio; e Cristina da Pizzano e il Poggio e l’Alciato; e il sommo Colombo, ed Amerigo, e i Cabotti, ed altri che portarono fuori l’operositá italiana, ai tempi che ella si potea sfogare addentro sotto l’ombra di quel che v’era d’indipendenza e di libertá.—Ma cadute queste, l’operositá italiana si portò, proruppe, si sfogò fuori in tutti i modi, in quasi tutti i paesi d’Europa. Guerrieri di terra e di mare, uomini di Stato e di Chiesa, artisti, scrittori, onorandi molti, miserandi quasi tutti, fecondarono di loro opere e di lor sangue le terre straniere. Due Strozzi, Piero [1510-1558] e Leone [-1554], fuggirono da’ Medici di Firenze e servirono Francia, dove il primo fu poi maresciallo, e il secondo grand’uomo di mare; ed ebbero e lasciarono numeroso séguito di[90] parenti e compagni d’esiglio lá combattenti e soffrenti. Cosí Sampiero da Bastelica [1501-1567], due Ornani ed altri còrsi fuggenti pur in Francia la tirannia genovese. E cosí altrove altri capitani anche piú illustri, Emmanuel Filiberto ed Alessandro Farnese, de’ quali dicemmo, Ambrogio Spinola [1571-1630], il Medici marchese di Marignano [1555], Alfonso [1540-1591] ed Ottavio Piccolomini [1599-1656], il Montecuccoli [1608-1681], oltre una turba di guerrieri minori; cosí il Paciotto ed una turba d’ingegneri; cosí i Doria, gli Spinola ed una turba d’uomini di mare (genovesi principalmente) a servigio di parecchie potenze europee. Un Ferrante Sanseverino principe di Salerno passò d’uno in altro esilio fino a Costantinopoli, tornò in Francia, cantò le brame della patria in lingua propria e nella spagnuola; e la sua vedova accattava poi nella reggia francese onde alzargli una tomba. Un calabrese, fattosi frate e preso da’ turchi nell’andar a studio a Napoli, si fece turco, e sotto nome di Occhiali diventò famoso corsaro e pasciá, e combatté contro a’ cristiani a Lepanto; e, feroce schiumator di mare, scendea talora a rivedere le patrie marine e i genitori, mentre sue ciurme predavano all’intorno. Un conte Marsigli di Bologna [1658-1730] fu di vent’anni a Costantinopoli, militò per Austria sotto al Caprara, fu fatto prigione e schiavo de’ turchi, e dopo molte vicende ne fuggí; diresse la fonderia de’ cannoni in Vienna e vi fece sperimenti sulla forza della polvere, fece l’ingegnero, il diplomatico, il militare in mezza Europa, fu indegnamente (come pare) condannato da un Consiglio di guerra per la perdita di Brissac ove militava; e ritiratosi in Provenza, e finalmente in Bologna sua patria, finí coltivatore indefesso di lettere e scienze.—Del Mazzarino [1602-1661], povero prete calabrese salito in grazia di parecchi grandi, e finalmente di Richelieu, a cui succedé nella potenza di primo ministro di Francia, sono piene le storie.—E s’aggiunsero i fuorusciti cortigiani delle due Medici regine di Francia, e quelli tratti allo splendore di Luigi XIV, il Davila storico, i Mancini, i Concini, i Gondi, i Cassini astronomi, ed altri molti. E finalmente in Francia e Svizzera e Germania per causa di religione migrarono[91] i Socini, i Sismondi, i Diodati, Telesio, Campanella, Radicati, Olimpio Morata, Celio secondo, Curione ed altri in folla; senza contar le dimore piú o meno protratte in Francia e Spagna di molti artisti nostri, Tiziano, Benvenuto Cellini, Primaticcio, Giovan da Udine ed altri quasi innumerevoli. Mirabile ingegno italiano che, chiusagli una via, ne sa trovar altre ed altre infinite; che, chiusagli la patria ad operare, opera fuori, cerca, trova campi in tutti i paesi, in tutte le colture! Che non farebbe, se trattenuto, fomentato, concitato insieme ed assodato in patria da quella indipendenza e quella libertá che son la somma o le sole buone tra le protezioni? La civiltá intiera troverebbe il conto suo ad apparecchiargli tal campo. Ma non è a pensarvi; gli stranieri non l’apparecchian mai, han troppo a fare a casa loro. A noi starebbe applicar tutto quell’ingegno nostro a tale apparecchio. Se non che, l’ingegno solo non basta a ciò. Ci vuol volontá e costanza e moderazione e devozione, tutte le facoltá, tutte le virtú dell’animo di tutti gli uomini; ma sopra tutte, quella del coraggio: dico il civile, il politico, il militare, tutti i coraggi. Diceva giá Danton, essere necessarie alle rivoluzioni tre virtú: audacia, audacia ed audacia. Ma egli parlava delle rivoluzioni diventate scellerate, come la sua. Nelle buone, l’audacia si traduce in coraggio, coraggio e coraggio. Chi non sa portar armi in mano, porti catene, e stia zitto.
23. Il terzo periodo della presente etá in generale [1700-1814].—L’ingrata necessitá di essere troppo brevi ci fece finora accennare e dividere i fatti italiani da sé, senza accennar le relazioni di essi co’ fatti stranieri. Ma questo non ci è piú possibile trattando del secolo decimottavo e del principio del decimonono. Né i motivi delle guerre, né le guerre né le paci, che mutarono continuamente l’Italia, non furono piú italiane. Quattro guerre e quattro paci si fecero nella prima metá del secolo decimottavo; due, per la successione di Spagna; due, per quelle di Polonia e di Austria; poi, dopo una lunga pace, una serie di guerre per la rivoluzione e per l’imperio francese. Qualunque divisione di que’ tempi si facesse indipendentemente da questi grandi eventi europei, genererebbe confusione od anzi falsitá d’idee ne’ leggitori.[92] Non pochi sono a’ nostri dí, governanti e governati, conservatori e progressisti italiani, i quali hanno la funesta smania dell’isolamento d’Italia, del trascurare ed ignorar volontariamente le condizioni, gl’interessi, le opinioni e quasi l’esistenza di quant’è straniero, o, come dicono con inconcepibil disprezzo, di quant’è oltremontano ed oltremarino. Ma noi (che speriamo non esser sospetti, in fatto almeno di nazionalitá ed indipendenza, e che ci esponiam volentieri ad esser detti uomini d’una sola idea e d’un sol libro), crediamo, all’incontro, essere due cose assolutamente diverse e talor contrarie, indipendenza ed isolamento. Il fatto sta, che quegli ultimi avi nostri del secolo decimottavo, lontanissimi essi dalle vane teorie dell’isolamento, intendentissimi anzi degli affari europei, furono pur quelli, i quali seppero cosí prender tutte le buone occasioni di guerra e di pace per liberarsi dalla potenza spagnuola, per scemar l’austriaca sottentrata, per accrescer gli Stati italiani, e farli progredire al segno dei piú avanzati contemporanei, sul continente. E quanto agli italiani della fine del secolo decimottavo e del principio del decimonono, se non furono superiori alle difficoltá, alle calamitá sorvenute, non ad altro forse è da attribuire se non appunto alla lunga pace che li avea, lor malgrado forse, isolati e disavvezzi dall’armi.—In tutto, noi ottocentisti abbiamo il vizio di voler essere troppo grandi uomini, di non apprezzar se non grandezze inarrivabili, di disprezzar quelle a che potremmo arrivar noi, ed arrivarono quegli avi nostri. Il Settecento fu in Italia molto piú grande che non è opinione volgare. Botta e Colletta hanno il merito di aver saputo andar oltre a quell’opinione; ed io confesserò fin di qua di voler andar oltre essi ancora. Non mai forse l’Italia progredí a un tratto tanto, come dal Seicento al Settecento, in indipendenza, in ordini civili, in colture. Questi ultimi avi nostri fecero lor ufficio, lor progressi, meglio che non molti antichi piú lodati. Cosí facessimo noi i nostri! Cosí, tra’ nostri stolti disprezzi de’ settecentisti, e le piú stolte ambizioni di assomigliarci ai cinquecentisti, quattrocentisti o trecentisti, non corressimo il rischio di rimaner poco piú che seicentisti. Ma di ciò, piú autorevoli[93] che non noi, giudicheranno gli storici futuri. Ed aspettiamovici pure: nostri o stranieri, ne giudicheranno, come progrediti, severamente.
24. Prima guerra della successione di Spagna [1700-1714].—Carlo II, re di Spagna e dell’Indie, cioè di quasi tutta America, di numerose possessioni in Africa ed Asia, di ciò che or chiamiamo Belgio, di Milano, delle Due Sicilie e di Sardegna, morí il 1º novembre 1700 senza figliuoli. Pretendevano alla grande successione, Leopoldo d’Austria imperatore, per sé come agnato, e Luigi XIV per uno de’ nipoti suoi, come discendenti di Maria Teresa sorella di Carlo II, e in particolare (per non ispaventar colla riunione delle due corone) per Filippo secondogenito del Delfino. Ma perché Maria Teresa avea, sposando Luigi XIV, fatta rinuncia alla successione, vi pretendevano Ferdinando di Baviera figlio d’una sorella minore di lei, che non avea rinunciato, e finalmente Vittorio Amedeo II di Savoia come pronipote di una figlia di Filippo II. Tutti questi aveano giá negli ultimi anni fatti e rifatti trattati di partizioni della successione preveduta. Ma siffatti trattati aveano offeso e il languente re di Spagna, e piú la nazione spagnuola, gelosa d’indipendenza anche dopo perduta ogni libertá; ondeché, per non diveller le membra della monarchia, Carlo II l’avea con testamento de’ 2 ottobre lasciata intiera a Filippo di Francia, che cosí diventò quinto di Spagna, e, s’ei non accettasse, a Leopoldo imperatore.—Naturalmente accettarono Luigi XIV e Filippo V; il quale, ito subito a Spagna, fu riconosciuto in tutta la monarchia, e cosí in Italia, Napoli, Sicilia, Sardegna, Milano. Ma sollevaronsi gli altri pretendenti, ed Inghilterra, Olanda, Germania, spaventata per la riunione delle due monarchie in una sola famiglia, benché non sotto a una sola corona. La guerra incominciò a mezzo l’anno 1701; stavano da una parte Francia, Spagna, Baviera, il duca di Savoia, che forse avrebbe voluto fin d’allora mettersi contro, ma che, serrato tra Francia e Milano, non poteva; e finalmente Ferdinando Gonzaga, effeminatissimo principe che aprí Mantova ai francesi, e si rifugiò vilmente egli e sue donne a Casal Monferrato. E furon, dall’altra, Austria, e tra breve Inghilterra ed[94] Olanda, unite per trattato [7 settembre 1701] in quella che fu detta la «grande alleanza». Venezia, neutrale al solito, dichiarò lasciar passare chi volesse ne’ suoi Stati, eccettuate le terre chiuse; e nelle terre chiuse si passò poi come nelle aperte. Cosí all’incirca in quelle de’ Farnesi, degli Estensi e del papa barcheggianti. Casa Savoia sola continuò a contare in Italia, anzi incominciò allora a contare in Europa. La prima fazione in Italia (lasciando una congiura fatta in Napoli per casa d’Austria, e secondo il solito mal capitata) fu la discesa del principe Eugenio di Savoia capitano d’Austria, e giá gran capitano nelle guerre anterioriá d’Italia e di Turchia. Passò per Roveredo, la Pergola, Serchio, Vicenza; cosí eludendo Catinat, grande e provato capitano anch’esso, che coll’esercito franco-piemontese stava a guardia in Val d’Adige, dell’antiche chiuse d’Italia contro Germania. Quindi, sapientemente ed arditamente evoluzionando e combattendo, Eugenio passò Adige e Mincio, e Catinat fu deposto. Sottentrògli Villeroi, capitano di corte che si lasciò battere a Chiari [1º settembre], e sorprendere e prendere in Cremona [1º febbraio 1702]. Sottentrògli Vendôme che sostenne le cose francesi; e combattessi una battaglia dubbia a Luzzara [15 agosto], a cui assistette Filippo V, venuto di Spagna a visitar Napoli e Milano.—Il rimanente di quell’anno, e mezzo il seguente 1703, passarono tra molte fazioni, ma niuna di conto in Italia, niuna decisiva nemmeno altrove. Ma intanto volgevasi dall’una parte all’altra Vittorio Amedeo duca di Savoia. Fosse ira delle insolenze spagnuole e francesi, o aviditá e mutevolezza alle promesse austriache, o legittimo intendere della propria indipendenza minacciata tra Francia e Milano franco-spagnuola, ad ogni modo entrò Vittorio Amedeo in trattati coll’Austria. Luigi XIV se ne accorse; e a’ 29 settembre 1703 Vendôme disarmò e fece prigioni i piemontesi del suo esercito. Il duca rispose dichiarando guerra a Francia e Spagna [7 ottobre], che, accerchiatone com’era tuttavia, fu bella arditezza; e firmando con Austria e gli alleati di lei un trattato [25 ottobre], per cui gli eran promessi il Monferrato (che si prevedeva disponibile fra poco, dopo la morte di Carlo Gonzaga, senza figliuoli) ed Alessandria, Valenza,[95] Lomellina e Val di Sesia, oltre poi mezza Francia orientale da conquistarsi.—Nel 1704, fu pressato il duca ad occidente da La Feuillade, che prese Savoia [gennaio] ed occupò Susa poi; ad oriente, da Vendôme che gli occupò Vercelli ed Ivrea. Il caldo della guerra fu in quell’anno in Germania; dove, addí 13 agosto, combattessi la gran giornata di Hochstädt o di Blenheim, tra austriaci con inglesi, capitanati da Eugenio e Marlborough da una parte, e francesi con bavari dall’altra, sotto Marsin e Tallard. Vinsero i primi; i francesi furono rigettati dal Danubio al Reno. E in Ispagna l’arciduca Carlo, figliuolo secondo dell’imperatore, incominciava la guerra movendo da Portogallo e prendendo nome di re di Spagna; e gli inglesi prendean d’un colpo di mano quella Gibilterra [4 agosto] che non lasciaron piú mai, di che fecero una delle stazioni principali di lor potenza accerchiante il globo, ma che rimase vergogna indelebile a Spagna, e causa perenne d’avversione tra le due nazioni.—Nel 1705 poi (perciocché in tutta questa guerra come nelle altre del presente secolo si distinsero piú che mai le campagne d’anno in anno, prendendosi regolarmente i quartieri d’inverno e combattendosi da primavera ad autunno avanzato), La Feuillade prese Nizza [9 aprile] al duca di Savoia; e Vendôme presegli Verrua [10 aprile], e sconfisse poi Eugenio a Cassano [16 agosto]. Intanto in Germania moriva Leopoldo imperatore, e succedevagli Giuseppe I [6 maggio]; e Villars teneva a bada Marlborough e la lega. E in Ispagna Carlo arciduca e re prendeva Barcellona [9 ottobre], e ne faceva sua piazza d’armi, e come la capitale di suo regno in Ispagna. E cosí giá piegavano le cose di Francia.—Ma precipitarono nel 1706. Vendôme vinceva sí a Calcinato [19 aprile], ma era chiamato quindi a Fiandra. E La Feuillade poneva assedio a Torino [13 maggio]; e pressandola per poco men che quattro mesi, l’avea ridotta agli ultimi, a malgrado una bella guerra spicciolata fatta all’intorno da Vittorio Amedeo, quando sopravenne il principe Eugenio di Germania, con bellissima marcia per le terre di Venezia e la destra del Po. Riunitosi col prode e perdurante duca presso a Moncalieri, girò (grande arditezza in lui, pari vergogna ai[96] nemici) intorno al campo assediante; poi furono insieme principe e duca sulla vetta di Superga, a concepir di lá l’imminente battaglia; e il duca fece alla Vergine il voto di quella chiesa ove or riposa, sommo fra i successori di lui, Carlo Alberto. E quindi scesi, assalirono, rupper le linee, sbaragliarono l’esercito francese, addí 7 settembre. Rimasevi ucciso il Marsin venutovi a comandare, ferito il duca d’Orléans venutovi ad obbedire dolorosamente contra il proprio parere, che era d’uscir dalle linee. Questa battaglia di Torino fece perder l’Italia a Francia e Spagna. Non serví una loro vittoria [9 settembre] nel Mantovano. Si difesero qua e lá fino al fine dell’inverno. Intanto continuò sí Villars a difendere la frontiera germanica; ma in Fiandra erano pur battuti Villeroi e l’elettor di Baviera da Marlborough a Ramillies [23 maggio]. In Ispagna, l’arciduca re Carlo entrava in Madrid [16 giugno]; ma Filippo vi rientrava [22 settembre].—Nel 1707, i francesi, difesisi qua e lá tutto l’inverno, vuotarono il Milanese e tutta l’Italia superiore per capitolazione [13 marzo]. Susa sola rimaneva: fu loro presa dal duca di Savoia [3 ottobre]. E allora, aiutata dagli eventi, riuscí una sollevazione. Addí 7 luglio sollevossi Napoli per Austria; in breve non rimase che Gaeta a re Filippo; fu presa addí 3 ottobre; e tutta la penisola fu sgombra di franco-spagnuoli. Ma tentata un’invasione in Provenza dal principe Eugenio e dal duca di Savoia [11 luglio], e posto da essi assedio a Tolone, furono costretti a levarlo [22 agosto] e ripassare in Italia. E in Ispagna il Berwick, generale (e gran generale) di Francia e Spagna, vinse una gran battaglia ad Almanza [25 aprile], e tutto il regno, salvo Catalogna, tornò a Filippo V. Alla frontiera di Germania Villars ruppe le linee nemiche di Stolhoffen [22 maggio], e, passato il Reno, invase Franconia.—Nel 1708. venuto a Delfinato questo capitano, che fu vero Fabio francese, tenne a bada il duca di Savoia tutto l’anno mentre disputavano l’imperatore e il papa per la supremazia di Parma e Piacenza ed altri diritti della Chiesa, e per la ricognizione di Carlo III di Spagna. Morí poi [5 luglio] Carlo III Gonzaga; e passarono Mantova all’imperatore, e Monferrato a Vittorio Amedeo II.[97] E intanto i francesi erano di nuovo battuti da Eugenio e Marlborough ad Oudenarde [11 luglio] ed altri campi di Fiandra; e proseguivano, all’incontro, lor vantaggi in Ispagna.—Nel 1709, Eugenio e Marlborough proseguirono lor vittorie, n’ottennero una nuova e grande a Malplaquet contra Villars [11 settembre], e presero Mons [20 ottobre]; onde non servirono alcune vittorie minori de’ francesi in Germania e Francia; e si posò in Italia.—E quindi, nel marzo 1710, aprironsi in Olanda i primi negoziati per la pace, con gran vantaggio, con piú grandi pretensioni, anzi con insolenza, per parte degli alleati. Luigi XIV, stanco e minacciato da presso, era disposto a cedere Spagna, a lasciar ispogliare il nipote. Non bastò; gli alleati vollero che egli si aggiungesse ad essi per ispogliarlo; anzi poi, che lo spogliasse esso stesso. Si sollevarono gli animi di quel gran re, di quella gran nazione, men leggiera, piú perdurante che non si dice; ruppero i negoziati [25 luglio], ricominciarono la guerra, e continuarono a perderla in Fiandra e in Ispagna. Addí 20 agosto, perdettero la battaglia di Saragozza; addí 5 settembre, Filippo V lasciò Madrid per la seconda volta. Ma questo fu il termine delle sventure di Francia; e incominciarono i premi meritati della perduranza di lei. Passò a Spagna Vendôme con un nuovo esercito francese, ricondusse Filippo V a Madrid [3 dicembre], vinse e prese Stanhope a Brihuega, vinse Stahremberg a Villaviciosa in due gran giornate [9, 10 dicembre].—E quindi ricominciarono, ma tutto diversamente, i negoziati nel 1711; aiutati da uno di que’ casi che di rado mancano agli uomini, alle nazioni perduranti. Morí [17 aprile] Giuseppe imperatore, e successegli l’arciduca re Carlo VI; il quale cosí riunendo in sé le due potenze austriache separate da Carlo V in poi, volse contro a sé tutte quelle paure di preponderanza che erano poc’anzi contra Francia. E allora passarono parecchi degli alleati a’ desidèri di pace; Inghilterra e Savoia sopra tutti, che, avendo guadagnato alla guerra, non si curavano di porre a nuovi rischi i guadagni. Anna regina d’Inghilterra, e l’opinione pubblica, anche piú regina colá, tolsero il ministero ai whigs che erano per la guerra, e diederlo a’ toryes pacieri. I negoziati furono[98] per allora segreti, e continuossi la guerra, ma mollemente, senza grandi eventi in niun luogo, e con vantaggi francesi in Fiandra e Spagna. Ma nel 1712 aprironsi i pubblici negoziati ad Utrecht fin dal 29 gennaio; e al 17 luglio si fece tregua tra Francia ed Inghilterra. Quindi, rimasto solo l’esercito imperiale, fu vinto a Denain dal Villars [24 luglio], e perdé poscia in Fiandra tutti i vantaggi degli anni precedenti. E continuarono quelli de’ francesi, e si posò in Germania e Italia.—Finalmente, nel 1713 [11, 17 aprile], firmaronsi ad Utrecht cinque trattati: di Francia con Inghilterra, Savoia, Portogallo, Prussia e Paesi bassi; per cui Francia abbandonò gli Stuardi e riconobbe la successione della casa di Hannover a’ tre regni britannici; Filippo V (che avea giá rinunciato, per sé e i successori, alla corona di Francia, come i successori di Luigi XIV alla corona di Spagna) rimase re di Spagna e delle Indie com’erano stati gli Austriaci; salvo Gibilterra e Minorca lasciate ad Inghilterra, le province settentrionali (il Belgio presente), Milano, Napoli e Sardegna ad Austria, e Sicilia a casa Savoia. La quale, oltre a tale acquisto e il titolo annessovi di re, acquistò pure l’intiero Monferrato, Alessandria, Valenza, Lomellina, Val di Sesia, e tutte le terre dell’Alpi rimanenti a Frallcia al di qua, cedendo all’incontro Barcellonetta, sola che avessimo al di lá.—Quindi rimaneva sola Austria coll’imperio contra Francia e Spagna; e guerreggiò infelicemente lungo tutto quell’anno. Addí 10 luglio, Stahremberg abbandonò Catalogna e Spagna. E l’anno seguente 1716, a Rastadt [6 marzo], ed a Bade [7 settembre], furono firmati due altri trattati, per cui l’imperatore e l’imperio s’aggiunsero a quelli d’Utrecht. E cosí dopo quattordici anni tornò in pace e rimase mutata la cristianitá europea; il grosso della potenza spagnuola passato di casa d’Austria a casa di Francia: e passate Italia dalla preponderanza austro-spagnuola alla preponderanza austriaca propriamente detta, tanto piú grave e forte quanto piú vicina. Ma era scemato lo sminuzzamento della penisola per la cessazione dello Stato di Mantova e Monferrato; erasi accresciuta in dignitá, in territori la predestinata casa di Savoia; e cosí[99] preparati i progressi ulteriori de’ trentacinque anni seguenti. Perciocché i trattati del 1713 e 1714 furono al secolo decimottavo ciò che veggiamo esser quelli del 1814 e 1815 al decimonono, fondamento su cui s’alzò la politica di tutto il secolo. Ma gli avi nostri (dico appunto e principalmente gli italiani) furono o piú savi o piú forti o piú felici in ciò, che seppero a poco a poco corregger gli errori lasciati ne’ trattati fondamentali. E forse fu dovuto a ciò solo, che furono allora in concordia, che operarono congiunti principi e popoli nostri. Così solamente è possibile giovarsi a ben comune delle occasioni; le quali all’incontro tra’ divisi non fanno altro che accrescere la divisione.
25. Guerre di Morea e di Sardegna e Sicilia [1714-1720].—Tre morti importanti avvennero nell’anno 1714: quella di Luigi XIV, a cui succedendo Luigi XV fanciullo, rimase Francia governata dal duca d’Orléans reggente; quella di Anna regina d’Inghilterra, a cui successe Giorgio I di Hannover; e quella di Maria Luisa di Savoia moglie di Filippo V, alla quale successe nel medesimo anno Elisabetta Farnese, sorella di Francesco duca di Parma e Piacenza. Fu trattato questo secondo matrimonio di Filippo V dall’Alberoni, un preticello italiano venturiero ed intrigante, che diventato tra breve cardinale e ministro principale e quasi assoluto di Spagna, fu causa di nuovi turbamenti in tutta Europa.—Intanto, al fine del medesimo anno 1714, ruppesi guerra tra il Turco e Venezia. Quello voleva riconquistar Morea, e riconquistolla nel 1715 facilmente alla decrepita repubblica. Questa non si riscosse, se non alle minacce turche contro alla vicina Corfù; fece allora apparecchi, assoldò lo Schulemburg capitano straniero, e strinse alleanze. Austria entrò in guerra; e il vecchio vittorioso Eugenio condussela felicemente dall’Ungheria, ottenne una gran vittoria a Petervaradino, e prese Belgrado. Venuto poi lo sforzo turco nel 1716 contro a Corfú, questa fu cosí ben difesa da Schulemburg, che, dopo un ultimo assalto respinto ai 18 agosto, i barbari si ritrassero. Nel 1717, combattessi in mare; e i veneziani, ora soli, ora aiutati da alcune navi di Malta, del papa, di Toscana e di Portogallo e Spagna, ebbero il vantaggio. E nel 1718 [21 luglio] fu firmata la pace di Passarowitz,[100] per cui rimase spoglia Venezia della recente conquista di Morea e ridotta a quell’isole che or son dette Ionie, ma accresciuta Austria delle due forti città di Belgrado e Temeswar.—Né posava Austria ai patti di Utrecht e Rastadt; negoziava per ricongiunger Sicilia a Napoli, e dar in cambio a re Vittorio Sardegna, tanto minore. D’altra parte, Spagna, condotta dall’ambizioso Alberoni, ambiva il medesimo riacquisto, e di piú quelli di Napoli e Sardegna; e negoziava pur con Vittorio per tutto ciò riavere d’accordo con lui, e dargli in cambio Milano tanto piú vicina, ma da conquistarsi contro Austria. Naturalmente Vittorio non aderiva all’ambizione austriaca; e andava lento, forse troppo, a secondar la spagnuola. Ma dimorato giá presso a un anno nel nuovo regno e incontratevi tutte quelle difficoltà che sempre sono in una nuova signoria, e di piú un’aspra contesa ecclesiastica col papa che volea approfittar dell’occasione per distruggere un tribunale secolare sulle cose ecclesiastiche (detto «della Monarchia», ed istituito fin dall’origini di quel regno), Vittorio regnava mal fermo colà. E l’avventato Alberoni troncò le peritanze della diplomazia con una di quelle rotture subitane di trattati, le quali, colle reciproche guarentigie fin d’allora stabilite tra gli Stati della cristianità, erano giá scandalose e di difficilissima riuscita. Ai 22 agosto 1717, un’armata di terra e mare raccolta a Barcellona invase subitamente Sardegna, e conquistolla contro Austria, a malgrado gli scandali e le proteste di tutta Europa. Che anzi, addí 30 giugno 1718, un nuovo armamento spagnuolo scese in Sicilia, e s’accinse a conquistarla contra Savoia. Ma si riscosse piú efficacemente allora la diplomazia, e conchiuse trattati [agosto-dicembre 1718], per cui s’unirono contra i Borboni di Spagna, non solamente Inghilterra, Olanda, Savoia ed Austria, ma quella Francia che li avea lá stabiliti, e per essi avea combattuto quindici anni poc’anzi. Tanto fin d’allora contavan poco le alleanze di famiglia! Tanto non sono durevoli se non le alleanze di popoli, fatte secondo i loro durevoli interessi! Una flotta anglo-olandese ruppe la spagnuola nell’acque di Siracusa [11 agosto]. Un esercito tedesco approdò in Sicilia; e vi si guerreggiò con successi vari negli anni seguenti. Ma intanto l’Alberoni concitato,[101] come succede, dalle proprie e prime avventatezze ad altre maggiori, andò tant’oltre con gli intrighi od anche le congiure in Francia contro al reggente, e in Inghilterra contro alla casa di Hannover, che rivoltisi tutti contro a lui, e spaventatone l’onesto e debole Filippo V, lo cacciò; e lui cacciato, si rifece pace facilmente addí 17 febbraio 1720. Spagna rimase spoglia di Sardegna; ma la casa de’ Borboni spagnuoli vantaggiata delle successioni eventuali di Toscana e di Parma e Piacenza a don Carlo figliuolo della regina Farnese, quando avvenissero le estinzioni, che si prevedevan vicine, delle due case de’ Medici e de’ Farnesi. Re Vittorio rimase spoglio di Sicilia, e mal compensato con Sardegna; ed Austria accresciuta, soddisfatta della riunione di tutto il regno delle Due Sicilie. E l’indipendenza italiana scapitò cosí di quanto perdette il principe nativo, di quanto acquistò lo straniero preponderante. Con Austria signora di Milano, Mantova e le Due Sicilie, Italia era fatta piú dipendente che mai. Ma, allora, fu per poco.
26. Pace di dodici anni; guerra della successione di Polonia [1720-1735].—Seguì una pace di dodici anni in Europa. Re Vittorio ne approfittò ad ordinare il nuovo Stato di Sardegna, gli antichi di Piemonte, l’istruzione pubblica principalmente, l’università di Torino, il collegio delle province da lui fondato. Molti professori chiamò di fuori. Guerriero egli soprattutto, ma gran principe in tutto, si compiaceva, s’accerchiava degli uomini e massime de’ ministri piú capaci in ogni cosa; sentiva di rimaner superiore a chiunque, non solamente col grado, ma coll’ingenita grandezza. L’Ormea fu ministro principale di lui e del figlio poi; e fu allevato da lui il Bogino successor dell’Ormea. Fu donnaiuolo in gioventù; e fatto vecchio e pio, volle sposare una gentildonna lungamente amata, la contessa di San Sebastiano. E fosse poi vergogna di ciò effettuare dal trono, o, come fu detto, imbroglio politico ove si fosse messo ed onde non sapesse uscire, o stanchezza del lungo agitato regno, ad ogni modo lasciollo [3 settembre 1730] al figliuolo Carlo Emmanuele III, e si ritrasse privato a Chambéry. Ma fosse ambizione della vecchia sposa, o propria ridestatasi tra l’insueta inoperosità,[102] passato appena un anno, venne a un tratto a Rivoli presso Torino, e poi [25 settembre] a Moncalieri; e chiamato Del Borgo ministro e notaio della corona, gli ridomandò l’atto della rinunzia, e nella notte tentò, ma non gli riuscì, farsi dare la cittadella di Torino. Adunatosi, agitatosi intanto il Consiglio di re Carlo, fu da questo dato ordine di arrestare il padre. Eseguissi nella notte del 27 al 28; fu rapita la San Sebastiano e condotta a Ceva; rapito e ricondotto a Rivoli, prigione del figlio, il vecchio vincitor di tante battaglie. Infuriò, languì un anno; domandò, ottenne riaver la moglie, tornare in Moncalieri; vi morí ai 31 ottobre 1732. Brutto fine, brutto principio di due belli e felici regni.—Il Piemonte fu tra’ paesi d’Italia quello che piú si avvantaggiò della pace. E tentavansi riordinare pure Milano e il regno di Napoli e Sicilia dagli austriaci. Ma non vi riuscivan guari essi, e come signori nuovi, e come stranieri; ed anche perché, essendo Carlo VI imperatore senz’altra prole che due figliuole, egli e suo governo attendevano a poco piú che ad assicurar la successione a Maria Teresa, la prima di quelle, e n’agitavano la diplomazia di tutta Europa.—Delle due grandi repubbliche, Venezia languiva sempre piú; si divertiva, apprestava i carnovali a’ gaudenti di tutta Europa: Genova, all’incontro, era turbata dalle sollevazioni de’ còrsi. Governati in modo assoluto, tirannico e corrotto, come sogliono i sudditi non partecipanti al governo delle repubbliche, scoppiarono nel settembre 1729 per una angaria fatta a un povero vecchio nella riscossione de’ tributi. Tumultuossi in vari luoghi, fecersi assembramenti, levaronsi armi; due volte i sollevati assaliron Bastia e si ritrassero. Governatori, capitani, pacieri nuovi vi furono invano mandati da Genova. S’innalzarono, si mutarono parecchie volte i capipopolo. Finalmente, brutto rimedio ad italiani contra italiani, piú brutto a un governo libero, i genovesi chiamarono gli austriaci ad aiuto, ad arbitri; e venuti gli austriaci, e fatto l’uno e l’altro ufficio, statuirono cessazioni d’armi, paci, indulti, e di soprappiù una Camera imperiale, che giudicasse in appello tra sudditi còrsi e signori genovesi [1732-1733]; e cosí i signori ebber lor signoria diminuita, e i sudditi[103] lor sudditanza accresciuta d’una nuova supremazia; non insolito né indegno fine di tali appelli. Ma durò poco quel cattivo accordo; risollevaronsi i còrsi fin dal 1734, ed ordinaronsi nel 1735 piú che mai in istato indipendente sotto a tre capi, Giaccaldi, Giafferi e Giacinto Paoli.—Tra gli Estensi non fu novitá se non nell’anno 1737, che morí il duca Rinaldo e successegli Francesco III.—In Roma, a Clemente XI [Albani], lungamente pontificante fin dal 1700, succedettero Innocenzo XIII [Conti, 1721], Benedetto XIII [Orsini, 1724] e Clemente XII [Corsini, 1730]; e tutti regnarono tranquilli e virtuosi.—Agitatissimi, all’incontro, furono in questo tempo il governo degli ultimi Medici e Farnesi in Toscana e Parma, per li patti fatti, come dicemmo, nel 1720 dalle potenze straniere per quelle successioni. Non consultati, non consenzienti, protestarono e negoziarono a lungo in tutta Europa, inutilmente. In Toscana morí [31 ottobre 1723] Cosimo III Medici e successegli suo figliuolo Gian Gastone, vecchio giá di cinquantadue anni, senza figliuoli, e principe coltissimo, ma perdutissimo di costumi. Resistette gran tempo alla successione dell’infante don Carlo; vi s’arrese finalmente per trattato dei 25 luglio 1731, protestò contro segretamente, pretese (un po’ tardi) restituir la libertá fiorentina, ricevette guarnigioni straniere, e finalmente l’infante, l’erede stesso [dicembre 1731].—In Parma, morto il duca Francesco addí 26 febbraio 1727, succedettegli il fratello Antonio vecchio di cinquantasette anni, il quale protestò pur egli contro alla successione impostagli, e prese moglie l’anno appresso ma non ebbe figliuoli, e morí al 10 gennaio 1731. Quindi gl’imperiali preser possesso del ducato, e lo diedero secondo i trattati all’infante don Carlo, che vi venne in ottobre 1732.—Ma questo fu il secolo delle successioni contrastate; e se alle piccole de’ principati italiani bastò la diplomazia, alle piú grosse furono necessarie le guerre. Aprissi quella del regno di Polonia per la morte di Federigo Augusto di Sassonia, succeduta addí 1 febbraio 1733. Ognuno sa che presso a quella nazione valorosa, ma pur troppo impolitica, e perciò da gran tempo infelice, le successioni regie si facevano nella impolitica forma delle elezioni. Due[104] competitori erano allora: Stanislao Leczinzki, giá stato re al principio del secolo e cacciato poi per opera della Russia, ed Augusto elettor di Sassonia figlio dell’ultimo. E perché in questa estrema imprudenza caddero di eleggersi i re sotto influenze straniere, stavano, per il primo, Francia il cui re Luigi XV avea sposata una figlia di lui; per il secondo, Carlo VI imperatore zio di lui, e Russia antica nemica del primo. E perché quando Austria e Francia entrano in guerra l’una contra l’altra, è inevitabile v’entri Italia o almeno casa Savoia intermediaria, e cosí abbia a scegliere fra le due una alleata secondo il proprio interesse; perciò re Carlo Emmanuele scelse Francia, che gli offriva la conquista del desiderato Milanese. Fecesi in Torino [26 settembre] il trattato, per cui oltre a quella conquista fu stipulato, che farebbesi pur quella di Napoli e Sicilia, da darsi all’infante don Carlo che lascerebbe Parma e Piacenza al fratello don Filippo.—Aprissi subito la guerra con una campagna d’inverno. Il vecchio Villars condusse gli ausiliari francesi; re Carlo, tutto l’esercito. Varcaron Ticino, entrarono in Pavia, in Milano [3 novembre]; n’assediarono e presero il castello, e Pizzighettone, Novara, Tortona, e via via tutto il paese fino all’Oglio. Carlo Emmanuele s’intitolò duca di Milano. Ma l’error suo qui, l’error forse di tutta sua vita, fu quella prudenza eccessiva, che teme passar il segno del necessario. Non pensò che bisogna conquistar due in guerra per serbar uno in pace. Si contentò di difender le conquiste fatte, e rattenne i francesi che volevan pure spingere la guerra oltre Oglio e Mincio, alle bocche del Tirolo, e cacciar gl’imperiali d’Italia. Lo stesso ottuagenario Villars se ne disgustò; e partito per Francia morí per via a Torino, deriso dai piú quasi rimbambito; ed era forse di spiriti piú giovanili che non i derisori. Scese quindi tranquillo l’esercito austriaco sotto Mercy, e si guerreggiò per quel ducato di Parma, che avrebbe dovuto esser a spalle dell’esercito gallo-piemontese. E vinsero questi lí a Parma una gran battaglia sotto il Coigny addí 29 giugno 1734, e s’avanzarono poi di lí in due mesi e mezzo poche miglia fino alla Secchia. Dove, non guardandosi, furono sorpresi e mezzo rotti a Quistello da[105] Königseck [14 settembre]; e quindi si ritrassero e pur rivinsero una gran battaglia a Guastalla [19 settembre]. Re Carlo vi capitanò e vinse: e tornò quindi a Torino. Si posò l’inverno; si rifece guerra l’anno appresso 1735, ma piú molle che mai, quantunque col rinforzo d’un esercito spagnuolo, tornato giá dalla conquista di Napoli e Sicilia.—Perciocché sin dal fine del 1733 era approdato in Toscana quest’esercito spagnuolo, a capo di cui pastosi l’infante don Carlo s’era mosso per Roma contro a Napoli. Poca, quasi nessuna resistenza fecero il viceré Visconti e i tedeschi, che erano pochi e sproveduti; ritrassersi a mezzodí sull’Adriatico fino a Bari, ad aspettar rinforzi attraverso quel mare. Entrò don Carlo in Napoli, applaudito, festeggiato, e da coloro che sempre sono affetti a una signoria antica quantunque straniera e cattiva, e da que’ migliori che speravano un regno finalmente nazionale. E l’ebbero in effetto; incominciò Carlo quella dinastia de’ Borboni, che or buoni or cattivi son pur diventati napoletani, italiani. Né s’indugiò qui come nell’Italia settentrionale. Mosse subito il Montemar, capitano degli spagnuoli, contro ai tedeschi che risalivan da Bari. A Bitonto s’incontrarono, si combatterono addí 25 maggio 1734. Vinse il Montemar, e ne fu fatto duca di Bitonto e governator di Sicilia. Alla quale poco appresso movendo, approdò a Solanto, entrò in Palermo, ed inseguì poi il resto de’ tedeschi chiusi in Messina; assediolla ed ebbela a patti [25 marzo 1735], nettando cosí di tedeschi i due regni.—Poco appresso [3 ottobre] furono firmati tra Francia ed Austria i preliminari, a cui mal volenterose pur aderirono in breve Spagna e Sardegna; e cosí [19 novembre] fu conchiusa a Vienna la pace generale. Per essa Augusto rimase re di Polonia, onde giá aveva cacciato Stanislao; questi fu fatto duca di Bar e poi di Lorena, sua vita durante, dovendo passare poi questa provincia a Francia; Francesco duca di Lorena, marito di Maria Teresa l’erede d’Austria, dovea passare granduca di Toscana alla morte di Gian Gastone Medici; don Carlo rimase re di Napoli e Sicilia; Parma e Piacenza passarono all’imperatore; e re Carlo di Sardegna acquistò Novara, Tortona e la supremazia de’ feudi delle Langhe,[106] piccola parte di grandi speranze. Ma l’Italia tutta insieme fu quella che s’avvantaggiò piú: un nuovo gran regno nazionale, una nuova gran diminuzione della signoria straniera; questa ridotta a Milano, Mantova, Parma e Piacenza. Da due e piú secoli, da Carlo VIII e Ferdinando cattolico in qua, non mai erasi trovata pesta da piedi stranieri cosí poca terra italiana. Il secolo decimottavo non parlava di nazionalità come il nostro, e, per vero dire, non vi pensava guari; i popoli erano contati per nulla, i principi europei pensavano, trattavano francamente per se soli. Vergogna, che cosí facendo facesser meglio per li popoli che non quelli i quali hanno ora per le bocche continuamente il bene de’ popoli, e li divelgono e sminuzzan poi ad utile proprio; piú apparente, del resto, che non forse reale, piú momentaneo che non definitivo.
27. Breve pace. Guerra della successione austriaca [1735-1749].—Seguirono una breve pace, una lunga e poco men che inutile guerra. Durante la pace incominciarono, Carlo Emmanuele in Piemonte, Carlo Borbone nel suo regno, que’ miglioramenti di che diremo quando si compierono. Ma Toscana fu quella che migliorò piú in questo intervallo. Morì [9 luglio 1737] Gian Gastone, ultimo e forse pessimo dei degeneri Medici, e succedette, secondo i trattati, Francesco marito di Maria Teresa, e primo di quella casa Lorenese, o seconda Austriaca, che essa pure si italianizzò. E cosí s’italianizzino meglio e davvero queste due famiglie di Toscana e di Napoli; io lo ridico, dopo ed a malgrado gli ultimi e sì vari eventi. I quali, non che mutare, hanno sancita la mia opinione, che dalla sola unione di principi e popoli sia da sperare l’indipendenza italiana; i quali hanno mostrato quanto vicini noi siamo a questa quando uniti, quanto discosti appena disuniti; i quali, fra i numerosi e gravi insegnamenti lasciati a’ posteri, lasciano questo sommo, che l’impresa o rivoluzione dell’indipendenza non si debba complicare di niun’altra né di dinastie né di territori che giá sieno materialmente indipendenti. Si gridò, si griderà altre volte «indipendenza italiana!», ma non se ne ebbe finora il concetto, l’idea, ed anche meno la passione vera. E finché non si concepisca[107] che non è paragone tra l’indipendenza e tutti gli altri temporali doni di Dio; finché l’idea e la passione della indipendenza non ispengano le altre idee o passioni nazionali, il giorno dell’indipendenza non sarà venuto. Misere cose sono la mente, il cuore umano; di rado potenti, quand’anche concentrano lor forze; impotentissime sempre quando le distraggono, quando femminilmente, fanciullescamente, od anzi animalmente, corron qua o lá dietro a questa o quell’idea o passione.—Ma pensino i principi, che pur troppo sovente e dappertutto, e massimamente in Italia, si fanno di queste terribili fanciullaggini od animalità; e per amore, se non di noi, di loro stessi, non vi si espongano.—Nel 1740, ai 31 maggio, morí Federigo Guglielmo re di Prussia, e gli successe il figliuol suo Federigo II, detto «il grande»; e morí, ai 20 ottobre, Carlo VI imperatore, e gli successero negli Stati, Maria Teresa, sua figlia, e Francesco di Lorena. Ma a malgrado la prammatica fatta per tal successione da Carlo VI, e riconosciuta poi nei trattati successivi da quasi tutti i principi d’Europa, sollevaronsi allora parecchi; Federigo coll’armi, prendendo subito Silesia [dicembre]; gli altri, colle trattative ed alleanze. Una ne fu fatta a Nymphemburg [18 maggio 1741] tra Francia, Baviera e Spagna, a cui poscia s’accostarono Prussia, Sassonia e re Carlo di Sardegna. L’esercito gallo-bavaro penetrò in Boemia ed Austria [novembre]; l’elettor di Baviera fu proclamato re di Boemia; e in breve imperator Carlo VII [24 gennaio 1742]. Austria era agli ultimi; fu salva dal generoso amore de’ magiari alla giovine, bella e virtuosa Maria Teresa, dall’alleanza antica di sua casa con Inghilterra, e dal trattato da lei conchiuso [lº febbraio 1742] con re Carlo di Sardegna. Fu detto allora di semplice neutralità, ma in breve di vera alleanza. Può, deve far meraviglia questo accostarsi di casa Savoia a casa d’Austria in tale occasione, che sembra essere stata la migliore da molti secoli, di cacciar questa di Lombardia e d’Italia. Ma il fatto sta, che Francia e Spagna sembrano aver voluto allora dar Lombardia non a re Carlo di Sardegna, ma insieme con Parma e Piacenza a don Filippo di Spagna, fratello secondo del re giá spagnuolo di[108] Napoli; e se ciò si fosse effettuato, casa Savoia e Italia aveano a temere il ritorno della preponderanza spagnuola, quasi un ritorno del Seicento. Per altra parte, non è dubbio che una gran differenza sarebbe sorta dall’essere Lombardia e Parma e Napoli non province spagnuole come nel Seicento, ma Stati indipendenti sotto principi, che, spagnuoli o francesi d’origine, si sarebbero in breve italianizzati; ondeché, in tutto, io non so s’io lodi come giusta, o se forse io non biasimi come stretta e mal interessata questa prudenza di re Carlo Emmanuele nell’accostarsi allora a Maria Teresa. Ad ogni modo, bene o male istituita quella guerra, re Carlo la fece bene poi, a modo de’ maggiori. L’aprì in Italia fin dal 1742, assalendo Modena alleata di Spagna; e movendo quindi, per l’Emilia e la Romagna, contro all’esercito venutovi di Spagna. Ma fu tra poco di lá chiamato per l’invasione d’un altro esercito spagnuolo in Savoia [settembre]. Dove accorso re Carlo, respinse dapprima, fu respinto poi, ed invernò in Piemonte.—Nel 1743, combattessi a Camposanto sul Panaro una battaglia dubbia tra gli austro-sardi e gli spagnuoli, e questi si ritrassero; né segui altro fatto di conto colà od in Savoia. Francia, quantunque avesse dato il passo all’esercito spagnuolo, non era ancora in guerra con re Carlo. Ma avendo questi firmato in Worms un trattato di alleanza oramai aperta con Austria [13 settembre 1743], Francia gli dichiarò formalmente la guerra addí 30, ed entrovvi anch’essa dall’Alpi. Ma, in breve, per la stagione avanzata, vi si posò.—Nel 1744, l’esercito gallo-ispano, sotto il principe di Conti e l’infante don Filippo, assalì fortemente il Piemonte fortemente difeso da re Carlo. Incominciaron da Nizza, la presero; e in varie fazioni [aprile] ne cacciarono l’esercito piemontese. Poi, dopo molto dubitare e andar e venire, scesero per Val di Stura e l’Argentiera, presero le Barricate e Demonte, e assediaron Cuneo. Alla quale movendo re Carlo in aiuto, ne seguí, addí 30 settembre, una gran battaglia che, da una chiesetta lá in mezzo, fu chiamata della Madonna dell’Olmo, aspramente combattuta dalle due parti, perduta da re Carlo in ciò che si ritrasse a sera dal campo, ma vinta in ciò che fece entrar[109] soccorso nella piazza. Dalla quale poi e dal Piemonte si ritrasse l’esercito gallo-ispano oltre Alpi prima dell’inverno.—Intanto il Lobkowitz, coll’esercito tedesco, s’era avviato alla conquista di Napoli; ed erasi avanzato poco al di lá di Roma, fino a Genzano. L’esercito spagnuolo e napoletano s’era avanzato alla riscossa fino a Velletri; e quantunque cosí vicini, erano rimasti mesi e mesi i due eserciti a guardarsi, a tastarsi con piccole fazioni, che chiamavasi cent’anni fa un guerreggiar bello e scientifico, or par goffo agli stessi ignoranti. Una notte [10 agosto] il Lobkowitz sorprese Velletri, e poco mancò non isbaragliasse l’esercito nemico, ma fu ricacciato, e non ne seguí altro; fino a che tra le malattie e la noia si ritrassero, l’uno in Romagna e Lombardia e l’altro a Napoli, i due eserciti, derisi dalle popolazioni per via. In tutto, salvo il gran Federigo, il maresciallo di Sassonia, e forse forse il Maillebois, i generali della metà del secolo decimottavo, esageratori, affettatori degli artifìzi tattici e strategici, si potrebbon chiamare i seicentisti dell’arte della guerra.—Ai quali ora succederebbero volentieri, se si desse lor retta, i romantici; quelli che, pretendendo imitar Napoleone (il quale non hanno capito né studiato), vorrebbero guerreggiare senza regola, senz’arte, senza tener conto né di ostacoli naturali, né di fortezze, né di eserciti nemici, anzi senza esercito proprio, con quello solo che chiamano (senza conoscerlo) «entusiasmo». Del resto, costoro son conseguenti nel non voler guerre lunghe né eserciti regolari; non vi vorrebbon andare nemmen per ombra; mentre sorridon loro le guerre di entusiasmo, sempre brevi, non faticose, e di che si ritrae ciascuno facilmente, gridando:—Non v’è piú entusiasmo.—Nel 1745, Genova si alzò contro agli alleati di Worms che abbandonavan Finale al re di Sardegna, ed entrò nell’alleanza contraria di Spagna e Francia [1º maggio]. Quindi unironsi meglio le mosse dei due eserciti gallo-ispani. Il Gages, coll’esercito spagnuolo-napoletano, passando dal Panaro in sulla Magra, si congiunse intorno a Genova con don Filippo e Maillebois che venivan da Nizza; e guerreggiaron poi alcun tempo sul Tanaro e la. Bormida, preser Tortona [3 settembre], Piacenza, Parma, Pavia,[110] vinsero re Carlo in gran giornata a Bassignana [27 settembre], e quindi invasero Piemonte fino a Casale ed Asti, difendendosi solamente la cittadella d’Alessandria; invasero il Milanese, entrarono in Milano [19 dicembre]. Insomma, eran precipitate le cose austro-sarde in Italia; mentre crescevano anzi le cose austriache in Germania per la morte dell’imperator bavaro Carlo VII [20 gennaio], l’elezione a imperatore di Francesco I, il marito di Maria Teresa, e la pace conchiusa col piú terribil nemico d’Austria, Federigo II [25 dicembre].—Ma qui, contro all’uso impostomi dalla brevità, dirò d’un semplice negoziato riuscito a nulla; perché, riuscito a suo fine, ei sarebbe stato il fatto piú bello e piú importante di tutta questa storia; e il suo fallire fu uno de’ piú lamentevoli. Re Carlo di Sardegna aveva, nel trattato di Worms con Austria, introdotta una clausula (insueta sì, ma che accettata dall’altra parte davagli un diritto certo ed onorato), che potesse scostarsi dall’alleanza, avvertendo tanti mesi prima. Quindi egli aveva libertá di trattare con Francia. Trattò, e ne risultarono una prima convenzione firmata a Torino [26 dicembre 1745], un armistizio firmato a Parigi [17 febbraio 1746], ed un progetto di pace definitiva, per cui dovevano rimanere Parma e Piacenza, con alcuni accrescimenti all’intorno, a don Filippo; il Milanese a casa Savoia, ed accrescimenti a Genova, a Modena, a Venezia; Toscana sola, come rimase poi, a casa d’Austria; cosicché tutta Italia ne sarebbe rimasta in breve tempo indipendente, e divisa tra principi giá italiani o che sarebbero diventati italiani; e (per piú dolore) tutta Italia doveva poi stringersi in lega a mantener quella indipendenza. Venne il Maillebois, figlio del capitano di Francia, fino a Rivoli, a cinque miglia da Torino, per volgere questi preliminari in trattato definitivo; andò a Rivoli il Bogino, ministro e confidente di re Carlo; ma non si conchiuse, e si ruppe. Fu pretesa prudenza politica per serbar il contrapeso d’Austria? Vergogna, in tal caso! ché anche queste ricercatezze, questi contrapesi sono seicentismi politici; e l’Italia libera di stranieri, piena di principati nazionali, non avrebbe avuto bisogno addentro, ed avrebbe trovati fuori [111]piú utilmente que’ due medesimi contrapesi di Francia ed Austria, e tutta Europa poi interessata a sua indipendenza, quando fosse stata stabilita. Fu timore, dubbio della sincerità di Francia? Noi non possiamo da lungi giudicare se fosser giusti o no siffatti timori; ma la grandezza dello scopo potea valere alcuni rischi. Fu onestà, impossibilità di conchiudere, rispettando la fede agli alleati attuali? Rispondiamo, abbassando il capo, come il giusto ateniese: non desideriamo, a costo d’un tradimento, nemmeno l’indipendenza. Del resto, io scrivo qui d’un principe, di cui, io piú di nessuno, m’allevai a venerar la memoria; scrivo d’un ministro che venero quasi un grand’avo; ma perciò appunto mi si stringe il cuore al rincrescimento, che le venerate destre non abbiano, se era rigorosamente possibile, firmata, or son cent’anni appunto in Rivoli, quella indipendenza d’Italia che non era piú stata da dodici secoli, che non fu piú nel secolo corso d’allora in poi, che tentammo noi invano pur troppo, che si ritenterà, ma Dio solo sa quando e con qual successo. Povera Italia, non avesti finor ventura!—Continuò poi re Carlo, ottimo alla guerra. Sorprese in bella fazione i nemici in Asti, ripresela [5-6 marzo 1746], e liberò la cittadella d’Alessandria [11]. I tedeschi vinsero in battaglia a Piacenza il Maillebois [16 giugno] e ricuperarono Milano, Lombardia; e quindi austriaci e piemontesi, uniti sotto il Botta italo-austriaco, rigettarono i gallo-ispani nell’Appennino e poi nell’Alpi, si presentarono a Genova, l’ebbero a patti [7 settembre] con vergogna di quel governo, e la multarono di grosse somme, e l’oppressero di tirannie e di rapine non pattuite, ma solite contro a’ vinti prostrati. Ma, addí 5 dicembre, tirando alcuni tedeschi un mortaio de’ rapiti per una via che sfondò, voller far violenza ad alcuni popolani per ritrarnelo, e dieder loro busse all’uso patrio. Sollevaronsi lí i popolani, poi di via in via in tutta la città. E per le vie, alle porte, alle mura combattessi ne’ giorni seguenti tra tedeschi e genovesi cittadini, aiutati a poco a poco da’ campagnuoli che accorrevano. Al glorioso dí 10 dicembre, il popolo cacciò i tedeschi dalla città. E tra per sé e gli aiuti di Francia e Spagna la difesero poi dagli assalti rinnovati lungo l’anno[112] seguente; finché, assalito re Carlo nel contado di Nizza, e perduta ivi Ventimiglia e minacciato in sull’Alpi Cozie, ritrasse sue truppe d’intorno a Genova; e, a’ 3 luglio 1747, gli austriaci levarono le loro; e cosí rimase Genova liberata per quel bello ed ultimo sforzo di sua antica virtù.—Fu e rimane sventura che si trovassero colà combattenti piemontesi insiem con austriaci contro a’ genovesi: ma l’ingrata memoria dovrebbe rimanere piuttosto in quelli che furono allor vinti, e non rimane. Così si cancelli questa ed ogni simile da quelle due schiatte piemontese e ligure, le quali sono le due (per non dir altro) piú operose d’Italia; le quali, quando unite davvero, sinceramente, basterebbero non a compiere, ma a far immanchevole il compimento de’ destini d’Italia.—Pochi dí appresso successe il minacciato assalto pel Monginevra. Il cavaliere di Bellisle lo conduceva. Addì 19, i francesi assalirono i piemontesi, trincerati al colle dell’Assietta, capitanati dal Bricherasco. La fazione fu delle piú belle e calde della guerra. I piemontesi vinsero; i francesi si ritrassero oltre Alpi. La guerra continuò, ma languì d’allora in poi. Tutti erano stanchi; Spagna stessa; dove, morto Filippo V [9 luglio 1745], e succeduto Ferdinando VI figlio di lui e di sua prima moglie Savoiarda, era scemato il credito della Farnese, scemata l’ambizione per don Filippo figliuolo di lei. Adunaronsi prima in Breda, poi in Aquisgrana i plenipotenziari; e addí 30 aprile del 1748 firmaronsi i preliminari, addí 18 ottobre il trattato di pace; per cui rimase riconosciuta la seconda casa d’Austria, riconosciuto don Filippo duca di Parma e Piacenza, accresciuta la monarchia piemontese dei due brani dell’alto Novarese e dell’Oltrepò pavese, e Finale riconfermato a Genova. Facendoci forza, e scartando dalla memoria ciò che avrebbe potuto essere altrimenti, dobbiam conchiudere: che fu pace buona, fu progresso all’Italia, scemando la parte straniera, accrescendo la parte italiana di Parma, Piacenza, e de’ brani di Lombardia diventati piemontesi.—Due guerre minori, una delle quali risibile, turbarono altre parti d’Italia ne’ tempi or percorsi. L’Alberoni, cardinal legato di Ravenna, invase la repubblichetta di San Marino [ottobre 1739]; ma fu[113] disapprovato dalla corte di Roma, che restituì quello Stato. E continuò, pur risibile in parte, feroce e funesta in tutto, la ribellione de’ còrsi, aiutata dalle calamità narrate di Genova. Fin dal 1736, approdò lá un Teodoro barone di Neuhof, tedesco, venturiero, cavalier d’industria, come si diceva allora, che, trovato modo d’aver denari e munizioni di guerra dal bey di Tunisi, venne a far il re di Corsica. I poveri còrsi erano in cosí mal punto, in cosí poco senno, che quasi tutti il gridarono re [15 aprile]. Ma, a novembre, il nuovo Teodoro I lasciò i sudditi per andar a cercar nuovi soccorsi, nuove venture. Girò Italia, Germania, Olanda, dove fu incarcerato per debiti, ed onde pur uscì, traendo da quella buona gente nuovi aiuti, nuovi apparecchi di guerra. Con questi tornò a Corsica [settembre 1738], fu riconfermato re, ma cadde d’allora in poi, e partí in breve. Giafferi e Paoli erano i veri capi. Venner francesi in aiuto a Genova, e fecesi un nuovo accordo nel 1740. Ma ruppesi per la solita causa delle tasse nel 1741, e di nuovo si guerreggiò. Nel 1743, Teodoro tentò riprendere il regno, ma non fu nemmeno lasciato approdare, e se ne fu per sempre. Nel 1744 vi fu nuovo accordo. Nel 1745, ardendo la guerra contro a Genova, si ridéstò la sollevazione, aiutata da Sardegna ed Austria, combattuta da Francia e Spagna, fino alla pace d’Aquisgrana.
28. Pace e progressi di quarantaquattr’anni [1748-1789].—Seguirono, tra questa pace e la rivoluzione francese, due altre guerre europee, anzi dell’intiero mondo. La prima, detta «de’ sette anni», s’incominciò dall’Austria insolitamente unita a Francia, per abbattere la nuova potenza di Prussia in Germania; ma s’estese in breve a guerra d’emulazione marittima nelle colonie, e nell’Indie principalmente, tra Francia ed Inghilterra; e finí colla conferma della potenza prussiana in Germania, della britannica nell’Indie, destinate amendue a molto maggiori accrescimenti. La seconda fu la guerra d’indipendenza delle colonie inglesi-americane contro a lor madre patria; e finí colla indipendenza compiuta. Narrata dal Botta in una storia, la cui traduzione rimane in grande stima appresso a quegli americani, è gran[114] danno per noi che sia scritta con modi antiquati, i quali vi fanno men popolare e meno utile lo studio di quel grande esempio. Ad ogni modo, quelle due guerre apparecchiarono il mondo cristiano qual è al presente, tanto e forse piú che non facessero poi quelle stesse della repubblica e dell’imperio francese. Perciocché quella de’ sett’anni fece la grandezza, cresciuta poi e crescitura, della Prussia; e quella d’America fu la prima delle grandi guerre d’indipendenza, le quali son succedute e succederanno alle guerre di libertá.—L’Italia poi non prese parte a nessuna delle due; non alla prima, dove unite Francia ed Austria non era facile, forse non possibile, a casa Savoia il continuar ad accrescersi in Italia, non almeno co’ modi soliti. E la guerra americana poi era troppo lontana, non fu continentale europea.—Seguì dunque all’Italia una pace di quarantaquattr’anni, la piú lunga cosí di quante si trovan rammentate da’ primordi della storia di lei. E questa pace fu feconda a noi di riforme governative e di progressi senza dubbio; ma anche d’indebolimenti. forse politici, e certo militari. Perciocché, cosí va il mondo, cosí è la natura umana pur troppo, che quando i tempi son facili e tranquilli oltre al corso d’una generazione, la generazione che s’alleva in essi non impari le difficoltà, e cosí non quegli atti di vigore, quegli sforzi d’animo e di corpo che son necessari a vincerle; ondeché, quando poi ritornano, ché sempre ritornano le difficoltà, gli uomini nuovi si trovano disapparecchiati, incapaci ad esse. E quindi può essere fortuna che sorgano, od anche arte de’ principi e governanti lasciare o far che sorgano in mezzo alle paci prolungate, quelle operosità, quegli esercizi od anche quelle difficoltà, le quali, senza porre gli Stati a pericoli invincibili, tengano pure esercitate le generazioni novelle ai casi futuri. E ciò sentirono forse, per vero dire, i governi italiani di cent’anni fa; tantoché, anche senza aver chiara quell’idea, senza pronunciare quella parola di «progresso», che sorsero solamente al fine di quel secolo e si sono fatti ora universali, tutti operarono e progredirono piú o meno, indubitabilmente. Ma non è dubbio nemmeno, e i fatti posteriori lo dimostran pur troppo, che que’ governi nostri non[115] operarono, non progredirono abbastanza; che la generazione della fine del secolo si trovò oziosa, languida, insufficiente a’ nuovi casi. Innegabile insegnamento, incancellabile, irremovibile esempio a que’ posteri dei settecentisti, che operano e progrediscono ora non piú che come quelli, o men che quelli. La lentezza, l’andar a poco a poco, sta bene; è prudenza, è virtù non contrastata. Ma qui sta tutta la questione; vedere il punto giusto fino al quale è virtù, oltre al quale è vizio, è paura. E come di noi giudicheranno i posteri dai fatti nostri, cosí noi, giudicando degli avi dai fatti loro, non possiamo se non conchiudere: che quelli non apparecchiarono questi bastantemente.—Napoli fu quella che progredì piú nel secolo decimottavo; il passare da provincia straniera a Stato indipendente, fu progresso incomparabile per sé, e fonte poi di altri innumerevoli. Acquistar principe proprio, ministri, tribunali, magistrati, milizie nazionali addentro, ministri e consoli patrii a curar gl’interessi fuori; riversar le imposizioni (sien poche o molte od anche troppe) tutte in casa, son vantaggi superiori sempre a qualunque altro. Naturalmente poi, sorse la necessità di riordinar ad uso proprio quant’era stato ad uso di signori stranieri; e i riordinamenti intrapresi in tempi civili fanno sempre sparire molti residui di barbarie. Così fu operato nel Regno, ma timidamente; furono migliorate ad una ad una le leggi civili, criminali, commerciali, ma non ordinate in codici; undici legislazioni erano, undici rimasero. Furono scemati i diritti, cioè le eccezioni, cioè le ingiustizie feodali, ma non tolte di mezzo radicalmente, che era il solo rimedio buono a tal peste. E dalla depressione de’ nobili era giá nato e crebbe piú che mai un altro malanno, la oltrepotenza, l’ingerenza in tutto de’ curiali; e chi non creda a me, creda al Colletta, che ciò deplora. E furono scemati i diritti del fòro ecclesiastico, gli asili; fin dal 1741 fu fatto a ciò un concordato con Roma. Furono ordinate le finanze, ma poco bene; furon lasciate a impresa le tasse indirette, fu introdotto il lotto. Cacciati dal Regno gli ebrei; tentata introdurre l’inquisizione da un arcivescovo zelante, e repulsa dall’opinion pubblica, e quinùi dal re. Del resto, grandi abbellimenti in Napoli:[116] ampliato l’edifizio degli Studi; edificate le ville regie di Portici, di Capodimonte, di Caserta, il teatro di San Carlo [1737]; incominciati gli scavi di Ercolano [1738] e di Pompei [1750]. Strade magnifiche furono fatte, e dette «per le cacce» del re, intorno a Napoli; ma poche per il pubblico, e meno per le province lontane. Tutto ciò sotto a Carlo I e Tanucci ministro di lui. Morto poi [10 agosto 1759] Ferdinando VI re di Spagna senza figliuoli, succedevagli Carlo di Napoli, e prima di partire regolava la successione ai due regni disgiunti giá dai trattati. E perché de’ tre figliuoli suoi il primo era scemo di mente, egli piangendo fece riconoscere tale sventura, e dichiarò successor suo a’ regni di Spagna Carlo Antonio che era il secondo; e re di Napoli e Sicilia il terzo, Ferdinando fanciullo d’otto anni, con una reggenza finché non avesse i sedici compiuti. E il medesimo dí [6 ottobre] salpò per Ispagna, dove regnò poi sotto nome di re Carlo III, non senza gloria di riformatore piú ardito, eppure anche lá insufficiente. Continuò quindi in pace e progressi la reggenza napoletana dal 1759 al 1767; e cosí poi il regno effettivo di Ferdinando IV. Continuò a governar Tanucci; e continuarono le riforme, massime nell’istruzione pubblica e nelle cose ecclesiastiche. Eran secondate piú dall’opinione straniera che non dall’italiana o napoletana; ma questa obbediva agli ordini di Spagna, ché, come dice il Colletta, «una servitù vincea l’altra». Il re fu educato agli esercizi, a forza corporale, ma a rozzezza, grossezza, volgarità, e, come si vide a suo tempo, barbarie e debolezza unite. Ad una carestia del 1764 fu mal proveduto con troppi provedimenti e proibizioni: alla calamità del gran terremoto di Messina [1783], molto meglio. Un patto di famiglia [1761] strinse le quattro case borboniche. Nel 1776, cessò l’omaggio della chinea al papa, che protestò poi ogni anno. De’ gesuiti siam per dire. Nel 1777, il Tanucci, dopo quarantatré anni di potenza, fu cacciato dalla regina Carolina Austriaca; e furono d’allora in poi potenti e prepotenti essa ed Acton, un inglese venuto per ammiraglio nel 1779 e salito poi a ministro. E quasi ogni cosa si fermò, peggiorò d’allora in poi. La milizia e la marineria sì furono promosse, ampliate,[117] ma piú a pompa che a forza vera, e si vide pur troppo quando venner alle prove.
29. Continua.—Ed ora, risalendo la penisola, veniamo a Roma. Pontificò fino all’anno 1758 Benedetto XIV [Lambertini]; papa letterato, protettor di lettere ed arti, restauratore ed edificator di monumenti, non nepotista, pio, intenditor de’ tempi suoi, tollerante di essi; e cosí tanto miglior capo di quella Chiesa, la quale appunto, per esser immortale ed immutabile, debb’essere ed è adattabile a tutti i tempi.—Morì nel 1758; successegli Clemente XIII [Rezzonico, 6 luglio], meno arrendevole, piú severo, piú acre difensore dei diritti acquistati lungo i secoli dalla curia romana. Guastossi con Genova, con Venezia, con Parma, colle quattro corti borboniche. Ma non era tutta colpa sua. È vero che non erano piú tempi che tutte le libertá, tutte le colture, tutte le liberalità fossero degli ecclesiastici, venisser da essi; cosí venendo, fossero aiutate dall’opinione pubblica; è vero che la liberalità giá s’era fatta secolare, che l’opinione favoriva i principi alla ricuperazione di molti poteri tolti loro nel medio evo; ed è vero che rilasciarne molti poteva esser bello e liberale ne’ papi moderni. Ma era forse poco merito, ed era certo poca liberalità ne’ principi l’acquistarli: la liberalità (non si può dire e ripeter troppo) sta nel dare, e non nel prendere o nel far dar da altrui; e la vantata liberalità dei principi del secolo decimottavo fu tutta nel prendere o far dare, prendere o far dare diritti feodali dai nobili, prendere o far dare diritti ecclesiastici dalla Chiesa. Né dico che questo non fosse in tutto un progresso: ma dico che non era liberalità di principi; e che essi non diedero mai nulla del proprio, nulla dei diritti o degli acquisti o delle usurpazioni della sovranità, nulla di ciò che sarebbe stato ad essi liberalità e forse utilità il concedere. E dico che dei diritti feodali essi non fecero, non poterono far rilasciar troppi, ché troppo era quanto ne rimanesse. Ma dico (contro all’opinione di molti, lo so), che nella ricuperazione de’ diritti di sovranità contro alla Chiesa, molti, quasi tutti i governi del secolo decimottavo, principi o repubbliche, passarono il segno; come Genova, quando non volle lasciar mandare dal papa un visitatore[118] o riordinator ecclesiastico nella Corsica sollevata; come Venezia, quando volle regolar le relazioni tra ecclesiastici regolari ed ordinari; come le corti borboniche, quando, sequestrando Avignone, rifecero esse ciò che fu tanto e giustamente rimproverato ai papi, il mescolar le ostilità spirituali e temporali. Col re Carlo di Sardegna, solo forse moderato e rispettoso in tutto ciò, papa Rezzonico non si guastò.—Del resto, tutte queste dispute ecclesiastiche erano inasprite, ingrossate da un’altra, non so s’io dica maggiore, o se anzi non ne sorrideranno i posteri un dí, da una disputa, una sollevazione quasi universale contro a un ordine di frati, o monaci, o conventuali, o religiosi regolari che voglian essere, ed importa poco, contro ai gesuiti. Se mi fosse possibile schivar questo assunto, io lo schiverei, per non iscostarmi qui da molti miei consenzienti ed amici, e non parer accostarmi a coloro dai quali io dissento quasi generalmente. Ma io sacrificai testé affetti e riconoscenze molto piú strette; e sacrificherò queste, se mai, al dovere storico, di non omettere nella narrazione assunta ciò che, bene o male, degno o risibile, fu pure l’affare che piú occupò l’Italia, la cristianità in questi anni; ed al dovere conseguente di dirne ciò che credo verità, ciò che, cessati gli interessi, le parti, le passioni presenti, non parrà forse indegno del nome di «liberalità», ciò che sarà forse liberalità de’ nostri posteri. Io dissi gia la bella idea di sant’Ignazio, la bella istituzione de’ gesuiti, fatta per servire alla propagazione della cristianità tra gli infedeli, alla difesa della cattolicità contro a’ nuovi dissenzienti. E fecero i gesuiti l’opera prima magnificamente sempre intorno al globo, la seconda con grande operosità ed utilità da principio. Ma in questa io crederei che si guastassero prontamente: che portati dal loro zelo ne’ paesi tiranneggiati dai dissenzienti, v’imparasser troppe arti di nascondersi, di dissimulare o simulare; troppo ardore, troppa fiducia in sé, troppa ostinazione nella lor parte, indubitalmente buona nel suo scopo cattolico, ma soggetta a errori, come ogni umana cosa, ne’ mezzi, nelle applicazioni. Un cinquanta anni e non piú, giá il notammo, durò il trionfo, l’ampliarsi della Riforma; ed un cinquant’anni cosí la bella guerra difensiva dei gesuiti in Europa. Ma col fermarsi[119] i progressi della Riforma, collo scemare i pericoli che ci venivan da lei, scemò l’utilità europea de’ gesuiti; e scemò la purità della loro operosità. Certo, o mi pare, tra le vicende della lega in Francia essi non furono giá incolpevoli. Né il furono quando, cessate le guerre religiose, essi portarono le medesime arti, i medesimi fervori alle corti di Luigi XIV, di Giacomo II, e in altre. I conventuali d’ogni sorta furono chiamati per necessità nei pubblici affari, ai tempi che essi erano soli colti, che soli quasi sapean leggere e scrivere. Ma subito che altri furono a saper leggere e scrivere, e i religiosi ebber cosí perduto questo vantaggio, essi furono naturalmente gli uomini meno atti al mondo, meno educati e conformati a’ pubblici affari; le loro solitudini, le loro educazioni, le loro occupazioni ne li rendono incapacissimi. Molti ammirarono, or lodando, or esecrando, le destrezze, l’abilità, la politica de’ gesuiti: ma essi furono forse i piú impolitici, i piú mal abili degli uomini; mal abili in generale agli interessi secolari che non poterono imparar ne’ loro collegi; mal abili in particolare agli interessi politici che sono i piú difficili della vita secolare; abili soltanto, o poco piú, che ai loro interessi propri famigliari, cioè a quegli accrescimenti di sostanze, di fortuna, od anche di credito e di fama, che sono, come si vede nel mondo, la infima delle abilità. Se fossero stati abili, essi avrebbon fuggita non che la politica, ma fin le apparenze della politica, che non era, che non doveva essere loro ufficio, che doveva essere, che fu lor perdizione. La loro inabilità politica li fece cadere in parecchi men colpe che errori: la inabilità loro li fece parere caduti in piú errori che non caddero; li fece parer colpevoli delle male intenzioni che non ebber né poterono aver mai; li fece accattarsi gli odii, le invidie degli altri ordini religiosi, di molti ecclesiastici secolari, degli uomini di mondo e di lettere e d’affari, de’ magistrati, de’ ministri, e de’ principi. Ne’ tempi poi di che trattiamo, s’aggiunse contra essi un odio onorevole ad essi, quello de’ nemici della cristianità, i quali, comunque si chiamino, certo furono allora molti e potenti. Questi si valsero dell’invidie, delle divisioni interne nostre, esultarono di rivolger cattolici contra cattolici; i ministri de’ principi[120] esultarono di tal aiuto contro a que’ religiosi faccendieri incontrati ad ogni tratto; una regia meretrice, la Pompadour, esultò di punirli d’una loro severità, che, rara o no, essi rivolser certo una volta contra essa; i principi, piú o meno abbindolati, esultarono di far questo passo di piú nelle riforme ecclesiastiche tanto allora applaudite, esultarono di parer liberali, progressisti, o, come si diceva allora, «filosofi», senza costo proprio, ed anzi incamerando collegi, chiese, palazzi, masserie e masserizie, milioni. Insomma, i gesuiti furono cacciati di Portogallo [1758, anno primo del pontificato di Clemente XIII] da un Pombal, ministro assolutissimo anzi tirannico d’un re tiranno e dissoluto, sotto accusa di aver partecipato a una congiura contro alla vita di quel re, ove furono implicati e suppliziati i nemici particolari di Pombal. Furono cacciati di Francia nel 1764, al tempo aureo di Luigi XV e sue cortigiane maggiori e minori, di Choiseul cortigiano di esse, e del parlamento allor cortigiano di Choiseul; cacciati in séguito al fallimento d’uno di que’ padri in America ed al risarcimento negato dalla Compagnia, a molti errori insomma di questa. Furon cacciati di Spagna nel 1767 da Carlo III ed Aranda ministro di lui, sotto accusa di partecipazione ad una sollevazione popolana fatta per serbare i cappelli ed i mantclli aviti. E furono quindi cacciati nel medesimo anno, per impulso delle due corti borboniche maggiori, dalle due minori ed italiche, Napoli e Parma. E perché in Portogallo s’arrivò al sangue ed ai supplizi, e in tutti gli altri paesi la cacciata si effettuò con modi subitani, arbitrari, crudeli, avidi, segreti, e senza render conto pubblico di nulla, ei mi par poco dubbio che i nostri posteri liberali compareranno tutta questa cacciata a quella dei templari del medio evo, e si sdegneranno che tanti loro predecessori abbiano accettate come liberalità o progressi cosí fatte nefandità. Se non che, essi si sdegneranno forse anche piú che dopo tanti progressi veri fatti dalla opinione liberale d’allora in poi per tre quarti di secolo, e (che è piú o peggio) negli anni appunto che l’Italia avea per le mani la somma opera della sua indipendenza, ella quasi tutta, e non esclusi molti degli uomini maggiori suoi, si distraesse a simili odii,[121] simili faccende da frati e sacrestie. Né rimarrà nome di «liberalità» o «progressi», nemmeno a quelle paure, che fanno anch’oggi escludere i gesuiti soli dal diritto comune di tolleranza e di libertá. Ad ogni modo, le cacciate dei gesuiti occuparono tutto il pontificato di Clemente XIII; ondeché io non mi so meravigliare, se mai in alcuni particolari, che non abbiam luogo a cercar qui, egli oltrepassò i termini di una giusta resistenza.—Morto esso quindi nel 1769, gli succedé Clemente XIV [Ganganelli, 18 maggio]. Il quale, pressato dalle quattro corti borboniche, come giá era stato il predecessore, di abolire del tutto, dappertutto, l’abborrita società, resistette, indugiò d’anno in anno. Ma non fu aiutato in tal resistenza dalla società stessa, nella quale si pronunziò, si pose allora quella massima fatale «Sint ut sunt aut non sint», quella massima forse irreligiosamente superba e non ignaziana, e certo impolitica; irreligiosamente superba, perché la società sola della Chiesa divinamente istituita è immutabile quaggiú, e mutabili, riformabili sono le società istituite nella Chiesa, e cosí gli ordini religiosi che tutti si riformarono, salvo questo; massima poi non ignaziana, perché sant’Ignazio coordinò appunto meravigliosamente la società al secolo suo, ond’è a credere la coordinerebbe ora e si sdegnerebbe di non vederla coordinata ai secoli nostri; massima impolitica finalmente, perché i tempi son sempre potentissimi a respingere tutto ciò che non si coordina ad essi. Ad ogni modo, dopo quattr’anni di peritanze, Clemente XIV diede il breve di abolizione [21 luglio 1773]. Tale poi era l’andazzo assoluto, tirannico di quel secolo, di quel fatto, che Clemente XIV, il quale lo compiè dubitando ed invito, lo compiè pure tirannicamente e incarcerando il generale ed altri de’ padri. Ma se ne addolorò, ma languí, e in breve morí [1774], e fu detto di veleno. Portato a cielo dagli uni, esecrato oltre a ciò che par conceduto dalla carità e dal rispetto cristiano dagli altri, fu in effetto dottissimo, pio, virtuoso, sincero pontefice.—Succedette Pio VI [Braschi, 1774], e libero esso della preoccupazione de’ gesuiti, attese al miglioramento dello Stato. Ma, e per quell’indugio, e per la duplice natura di quel governo spirituale, ed in ciò immutevole,[122] e temporale, e per quella compagnia poco mutevole, ed anche poi per natura personale di Pio VI, che fu ne’ suoi principi papa nepotista, protettor di lettere ed arti, splendido, elegante, pomposo e quasi imitator de’ papi del Cinquecento; per tutto ciò le riforme dello Stato romano furono molto minori, che non quelle degli altri d’Italia. Fece musei, intraprese il risanamento delle paludi Pontine, fece un viaggio a Vienna, per iscemar l’ardore delle riforme, eccedente lá quanto facevasi da’ principi italiani. Ed interrotto poi dalle preoccupazioni delle rivoluzioni di Francia e Italia (nelle quali il vedrem finire non senza grandezza), tramandò cresciute poi a’ successori, anche presenti, le difficoltà e necessità delle riforme di quello Stato. Noi lasciam altri (dicevam noi al principio del 1846) invocare un Gregorio VII, che non ci par né possibile né desiderabile a’ nostri dí, né a niuno futuro e prevedibile, sulla Sedia romana; ma con tutto l’ardore d’un figliuolo rispettoso e devoto, d’un italiano che desidera la conservazione di tutti i principati italiani, noi invochiamo, noi preghiamo da Dio la grazia d’un Sisto V o d’un Gregorio XIII, od anche meglio; d’un riordinatore conforme ai tempi, di quello che è il piú antico, che fu giá il piú glorioso, che fu e può esser ancora il piú benemerito della civiltà cristiana fra gli Stati italiani.—E corsi pochi mesi, Dio esaudì la preghiera italiana e cristiana; e l’Italia e la cristianità alzarono un grido unanime di gratitudine e di amore. Poi, corsi pochi anni, il gran dono di Dio fu sciupato dai soliti eccessi italiani: eccessi d’ingratitudine e scelleratezza da una parte, eccessi di rigore vendicativo dall’altra: vittime in mezzo, Pio IX, l’Italia, la cristianità.
30. Continua.—Or accenneremo piú brevemente le riforme non dissimili fatte altrove.—Lente e poche furono dapprima in Toscana, governata da Richecourt in nome del signor lontano e straniero, l’imperator Francesco I. Non passaron guari le materie ecclesiastiche. Ma morto quello [18 agosto 1765], e succedutigli in Austria e nell’imperio il suo figlio primogenito Giuseppe II, e in Toscana il secondo Pietro Leopoldo, questi non solamente continuò le riforme ecclesiastiche, ma nel 1787[123] convocò un sinodo di vescovi toscani che fu riprovato da Roma. E fece insieme tanti e cosí vari ordinamenti civili, che sarebbe piú breve dire le cose da lui tralasciate che non le ordinate. Ai feudi, ai comuni, alle leggi civili e criminali, alle finanze, alla libertá dell’industria e de’ commerci, all’agricoltura, all’istruzione pubblica, a quasi ogni cosa si volse e provide cosí bene, che si potrebbe dire esserne riuscita Toscana lo Stato meglio ordinato di que’ dí, e modello perenne a qualunque principato assoluto. Ebbe sì il vizio di tali Stati; una polizia, una smania di sapere e regolare eccessiva, inquieta, incomoda, ficcantesi ad antivenire il male, non solamente colle leggi generali, che è dovere e possibilità de’ governi, ma colla prevenzione d’ogni caso, che è impossibilità. Ma questo fu male piccolo e passeggiero di natura sua. Peggiore e durevole fu che attese poco e male ad ordinar niuna milizia stanziale, che trascurò o disprezzò questa quasi spesa inutile in uno Stato piccolo ordinato ad economia e filosofia, e che tramandò questa trascuranza e questo disprezzo a’ posteri principi e popoli, i quali n’han portate le pene, e non se ne correggono perciò. Del resto, il Botta (libro L) ha tolto da uno scrittore straniero il cenno d’un governo deliberativo, che si pretende essere stato ideato da Leopoldo per Toscana; e non vedendo effettuata tale idea, il Botta dubita poi, se Leopoldo l’avesse veramente o se la lasciasse, «visti i mali prodotti da quelle assemblee in paesi illustrati da sole caldo». Ma s’ei l’ebbe e la lasciò, io crederei piuttosto ei la lasciasse per la solita ripugnanza che hanno i principi, che aveano particolarmente quelli del secolo scorso, a far concessioni. Ad ogni modo, morto Giuseppe II nel 1790, passò Leopoldo ad Austria ed all’imperio, e gli succedette in Toscana suo figliuolo Ferdinando III.—In Parma e Piacenza entrò a signoreggiar l’infante don Filippo per la pace d’Aquisgrana [1748]; e governò sotto lui Dutillot, un francese, de’ filosofi di quel tempo, che anch’egli fece riforme ecclesiastiche e buoni ordinamenti civili, e chiamò letterati d’altri paesi d’Italia e di fuori, fino alla morte del duca Filippo [18 luglio 1765], e poi durante la minorità del duca Ferdinando figliuolo di quello. Ma cresciuto[124] questo e preso il governo, cacciò Dutillot, e rimutò ogni cosa; da grandi contese, a grandi arrendevolezze per Roma; da progressi, a timiditá, immobilitá.—In Modena signoreggiò il duca Francesco III fino al 1742, e gli succedette poi Ercole Rinaldo ultimo degli Estensi, principe buono, e che solo forse de’ contemporanei non contese con Roma, ma che fu poco riformatore e gretto principe.—Delle due repubbliche poi, Venezia oziava, poltriva, marciva. Le contese con Roma erano solo moto che agitasse quella paludosa tranquillitá. Del resto, pace, beato far niente, carnovale quasi perpetuo, ozi e vizi. Non piú guerre continentali da due secoli e mezzo, non marittime contro a’ turchi dal principio del decimottavo; non riforme, non mutazioni, non miglioramenti di niuna sorta; commerci cessanti, perché, da maggiori che erano stati giá, diventarono, non progrediendo, prima pari, poi minori degli stranieri progrediti. La smania di difender qualunque cosa d’Italia, anche i malanni, fece difendere, lodare questa vergognosa decrepitudine veneziana; i nipoti, se risorti, ne giudicheranno. Dicesi delle aristocrazie che elle sono conservative; ed è vero; ma resta a sapere se sia bene o male il conservar le decrepitudini, e se conservandole si conservino gli Stati, o non anzi si precipitino.—Genova avea conservato piú commerci in pace, piú partecipazioni alle guerre italiane, senza dubbio; e l’ultimo fatto della propria liberazione era tale, che parrebbe averla dovuta rinnovare. Ma anche di lei si mani festò la vecchiezza all’incapacitá di saper reggere e serbare i sudditi. Continuarono dopo la pace d’Aquisgrana le parti in Corsica; rimastivi i francesi per aiutar Genova a tenerla, incominciossi a parteggiare per essi contro a Genova, e continuossi a parteggiar da altri per la libertá. Capo di questi era il Giafferi; fu assassinato dal proprio fratello [3 ottobre 1753]; crebbene, se n’inasprì sua parte; chiamò a reggerla Pasquale figlio di Giacinto Paoli, esuli amendue al servigio di Napoli. Natura forte, insulare, ma educata a civiltá, come quella poi di Napoleone, Pasquale Paoli avea del grand’uomo; e intese a liberar insieme e incivilire i suoi. Eppure (terribile insegnamento a chi anche con buone ragioni cerchi a dividere, o, se[125] si voglia cosí dire, a liberare l’una dall’altra due parti d’Italia), or vedremo a che riuscisse. Approdò a’ 29 aprile 1755; fu riconosciuto da gran parte del popolo, rigettato, combattuto solamente da Matra, uno de’ capi che in breve fu vinto e passò a’ genovesi. Paoli ordinò un governo rappresentativo repubblicano, lui capo, e quasi dittatore, con titolo di «generale del regno e capo del magistrato supremo di Corsica»; ordinò una milizia non permanente ma che accorreva ad ogni cenno suo, ad ogni bisogno. Con questa mantenne la libertá del paese, delle popolazioni, ma non riuscí a cacciare i genovesi da parecchie delle cittá; e fa meraviglia il veder rimasti esso e i còrsi non pochi anni in tal condizione precaria, in sulla difensiva, senza ultimar la cacciata de’ lor nemici. E fosse in essi impotenza, o fiacchezza, o lentezza, ciò fu lor perdizione. Due volte i genovesi richiamarono i francesi: la prima, nel 1756 per due anni; poi, nel 1765 sotto Marbœuf per quattro anni, ma fu per sempre. Addí 15 maggio 1768, a Versailles, Genova cedette l’isola a Francia, serbandovi una sovranitá nominale. Quindici mesi appresso [15 agosto 1769] vi nascea Napoleone; e quindi per que’ patti, per cosí poco tempo frapposto, resta disputato tra Italia e Francia il grand’uomo. Per tali patti la mala contesa d’italiani contra italiani ebbe il fine solito, la soggezione a stranieri; per tali patti resta divelta d’Italia quella nobil isola. Paoli resistette, perdurò un anno ancora. Ma Francia guerreggiava ora per sé; guerreggiò forte e grosso; e Paoli, vinto, lasciò l’isola addí 13 giugno 1769. Esulò in Inghilterra, onde il vedremo tornare, e di nuovo inutilmente.—Ed ora (trascurando le repubblichette di Lucca e San Marino e i principatuzzi di Monaco e Massa, che porterebbero a dodici la somma degli Stati indipendenti italiani a quell’epoca), or ci volgiamo all’ultimo e piú forte e vivo di essi, al Piemonte. Ma la sua vitalitá speciale, e allor sola, stava nella guerra; e dal 1748 in poi sempre rimase in pace. Dicemmo che quando s’aprí tra Austria e Prussia la guerra de’ sette anni, avendo Francia presa parte per Austria, quest’alleanza novissima allora tolse a Carlo Emmanuele III l’occasione solita di entrar in guerra. Fu sventura?[126] Ad ogni modo fu cessazione dell’operositá guerriera di Piemonte. L’esercito tenuto in piè, riordinato, esercitato non vi supplí. Né vi supplirono le operositá di pace, le riforme, i progressi civili fatti qui, del resto, anche meno arditamente che non altrove. Furono in tutto progressi di principato assoluto e non piú; riforme ecclesiastiche piú moderate che altrove; riforme feodali contro a’ signori; uniformitá, centralitá di governo; giustizia retta e severa; severo reggimento delle finanze; e per la prima volta da molto tempo, severi costumi, severa corte. Fu, in tutto, regno piú buono che grande, ed uno buono dopo uno grande è forse giá decadenza. La Sardegna, rozza ancora, quasi barbara, fu quella che si fece progredir piú, per portarla a quel segno delle altre province che si voleva arrivare, non oltrepassare. Lá furono fondate [1764, 1765] le universitá di Cagliari e Sassari. Ma in Piemonte bastò il mantenere, non si vollero forse avanzare gli studi. Ad ogni modo, avanzarono da sé; era giunto il tempo che Piemonte entrasse nelle colture italiane, e v’entrò splendidamente, come vedremo. Fu grave macchia di questo regno, Giannone esule da Napoli a Ginevra, e di lá venuto a Savoia per far sua pasqua, e cosí arrestato e tenuto poi prigione nella cittadella di Torino, dove morí il 7 marzo 1748. Tutto ciò per mal compiacere a Roma, a danno altrui, dopo averle dispiaciuto a profitto proprio. Morí Carlo Emmanuele III ai 20 febbraio 1773. Succedettegli suo figlio Vittorio Amedeo III, minore di lui. E fu servito da uomini pur minori; sia perché ogni principe li cerca pari a sé, sia perché gli uomini eran cresciuti dammeno in tempi piú facili. Amò, curò, esercitò molto, anzi esageratamente, la milizia; e per avere, nella pace non interrotta, un grosso ed allestito esercito, scompose le finanze assestate dal padre, e gravolle di grossi debiti, cattivo apparecchio alle guerre future. Istituí l’Accademia di Torino; amò piú che il padre le lettere e i letterati, e volle proteggerli; ma non dando loro libertá eguale a quella che giá cresceva per essi altrove, fu vergogna del regno suo, che i maggiori uomini di esso, Lagrangia, Alfieri, Denina, Bodoni ed altri, si facessero illustri o grandi,[127] trapiantandosi altrove. Del resto, fu principe buono, amato, ma quasi compatito da sudditi e stranieri.—Finalmente, nella provincia straniera, in Lombardia, incominciaronsi le riforme, i progressi sotto l’imperio di Francesco I e di Maria Teresa. Poi, morto il primo [18 agosto 1765], e succeduto lor figliuolo Giuseppe II all’imperio, e fatto fin d’allora co-reggente degli Stati austriaci dalla madre superstite, e succeduto a questa poi nel 1780, egli fu riformatore piú ardito di tutti, principalmente nelle cose ecclesiastiche; né vi si fermò, per le supplicazioni e il viaggio a Vienna, che dicemmo, di Pio VI. Frati, monache, ecclesiastici ordinari, beni di chiesa, asili, immunitá, a tutto mise mano. Del resto, migliorò ed ordinò in codici le leggi civili, le penali e quelle di procedura; migliorò gli ordini comunali, ordinò la pubblica istruzione, protesse dotti e letterati. E cosí acquistò gran nome, fu posto in cima de’ principi riformatori ed amici di libertá da que’ contemporanei di lui, a cui pareva esser liberati, al cader di que’ privilegi signorili e religiosi che eran pur diminuzione della potenza assoluta e straniera, al livellarsi di tutto e tutti sotto questa. Il conte di Firmian fu ministro a ciò in Italia, e fece Lombardia invidiata da quegli italiani troppo numerosi sempre, i quali, non desti al sentimento dell’indipendenza, non si curan d’altro che di vivere, tranquillamente amministrati, alla giornata.—E cosí in tutto s’era progredito incontrastabilmente; i popoli godevano, i letterati lodavano; gli amici stessi di quel progresso universale, di che incominciavasi a concepir l’idea e pronunziare il nome, esultavano, speravano. E come alla fine del secolo decimoquinto, cosí alla fine di questo decimottavo, l’Italia, poco men che tutta indipendente, pareva avviata a felici destini. Ma in breve si vide una seconda volta, che non è fatto nulla quando non è fatto tutto in materia d’indipendenza; che niun progresso nazionale dura, finché non è fatto quello il quale solo è guarentigia di quanti son fatti, solo buon avviamento a quanti mancano. E si vide che tutte le vantate riforme del secolo decimottavo non erano apparecchi sufficienti a ben ricevere l’occasione che s’avanzava, l’occasione che avrebbe potuto essere d’indipendenza finalmente compiuta, che fu all’ultimo di cresciuta dipendenza.
31. Le guerre della rivoluzione francese fino alla pace di Campoformio [1792-1797].—Il nome che rimarrá nelle storie universali future alla rivoluzione francese, quando altre passioni, altri interessi passeggeri saran succeduti a quelli che reggono ora l’Europa, sará probabilmente quello di restaurazione del governo deliberativo e rappresentativo sul nostro continente. Tutte le nazioni figliate dal congiungimento de’ popoli tedeschi co’ romani ebbero sí il governo deliberativo ma non il rappresentativo, assemblee deliberative ma non nazionali. Carlomagno si adattò al governo deliberativo, anzi lo restaurò; e fu cosí grande poi, che potrebbe bastar l’esempio di lui a provare che son compatibili tal governo e la grandezza personale del principe. Poi da Carlomagno al secolo decimoprimo cadde tal governo imperfettissimo, incapace di reggersi da sé. Sorti i comuni al fine di quel secolo, ne risultò, nelle numerose cittá italiane, quel governo repubblicano mal ordinato addentro e peggio fuori, di che abbiam notato a’ luoghi loro le origini, le vicende, ed il triste fine; ma risultò, nello stesso tempo all’incirca, quell’introduzione che pur accennammo de’ comuni, cioè dei loro deputati popolari nelle assemblee deliberative delle monarchie europee, delle tre grandi di Spagna, Francia ed Inghilterra principalmente. E allora si può dir fatta la grande invenzione della rappresentanza, allora passato il governo deliberativo a rappresentativo. Ma fu, come parecchie altre fatte a tempi immaturi, invenzione precoce, incapace di produrre gli effetti suoi. Decadde essa pure, fu negletta dai popoli quasi inutilitá, incommodo e carico; tralasciata dapprima, abolita poi quasi intieramente dai principi come difficoltá ed impossibilitá nel governo di loro Stati cresciuti. Tra il primo terzo del secolo decimosesto e il primo terzo del decimosettimo furono spenti tutti i governi rappresentativi, stabiliti governi consultativi (in breve caduti in assoluti) in tutta Europa, tranne Inghilterra. Nella quale fu fatto sí il medesimo tentativo, ma fallí; e dal tentativo fallito, dalla vittoria del governo rappresentativo riuscí questo nel 1688 finalmente quasi perfetto; e questa fu la prima restaurazione di esso, appena attesa allora, appena studiata per parecchi anni, sul[129] continente europeo. Un lungo secolo, centun anni dovetter correr prima che si pensasse a niuna imitazione. Vi si pensò, se ne incominciò in Francia nel 1789; e pur troppo il pensiero fu leggiero, l’imitazione breve, i pervertimenti molti, pronti e gravi e non finiti in quella pur essa incostante, pur essa misera nazione. Ma intanto, tra gli errori e le sventure di Francia, il gran pensiero, la grande imitazione dell’Inghilterra, la seconda e maggiore restaurazione del governo rappresentativo, s’è diffusa in Germania, in Spagna, in Grecia, in Italia, in tutto il continente europeo, tranne Turchia, Russia, e non so s’io dica alcuni principati italiani. Quindi non è dubbio che l’anno 1789 è per tutto questo continente una delle epoche piú grandi e piú atte a segnare e dividere le sue etá storiche, è l’èra della sua libertá rappresentativa restaurata. Ma perché l’Italia non entrò realmente in tal restaurazione se non cinquantanove anni appresso; e perché poi in quest’Italia, che non ebbe in essi, che non ha nemmen ora l’indipendenza, la stessa questione di libertá non è (per chi senta e sappia virilmente) se non secondaria; e perché, se ciò sia vero, noi abbiamo fatto bene, e se non sia, abbiamo errato con meditata sinceritá, e non ci possiamo quindi ricredere; perché, dico, ad ogni modo abbiamo da gran tempo divisa la storia italiana secondo questo interesse primiero dell’indipendenza, e cosí chiamato quest’ultima etá delle preponderanze straniere; perciò noi non possiamo se non comprendere in essa, ed anzi nel periodo terzo delle preponderanze francese ed austriaca, i venticinque anni corsi dal 1789 al 1814. Non è condizione piú anormale all’universale civiltá, che quella d’una nazione senza indipendenza; e l’anormalitá della condizione trae seco l’anormalitá della storia. E il fatto sta che la grand’èra europea del 1789 non introdusse per noi niuna condizione, niuna mutazione, niun fatto nuovo che sia rimasto grande e durevole. Ne preparò alcuni, è vero; ora incominciamo a saperlo; preparò questa libertá che incominciamo ad avere. Ma non possiamo dire che incominciamo ad avere l’indipendenza. E finché non l’avremo, io sfido chicchessia a dire se sia finita l’etá delle preponderanze straniere. Ad ogni modo,[130] il secolo decimottavo diede uno spettacolo duplice; da una parte, Inghilterra sola progrediente ed in quel governo rappresentativo di che ella aveva allora la privativa, ed in ogni sorta di felicità e grandezze interne ed esterne; dall’altra parte, l’Europa continentale incompiutamente progrediente in quelle riforme che noi accennammo per l’Italia, riforme ecclesiastiche e feodali, ma non riforme del principato, non restaurazioni di libertá. Molti dissero allora e poi di queste riforme che elle furono imprudenti, ed io credo che dican bene; imprudentissimo fu al principato riformar tutto, salvo se stesso; esser liberale de’ diritti altrui e non de’ propri; insegnare a’ popoli tutte le libertá, e negar loro quella civile e politica che essi desideran piú e che comprende l’altre. Non ci è mezzo; o non bisogna educare i popoli, o bisogna compier loro educazione; o non bisogna invogliarli, o bisogna dar loro ciò di che si sono invogliati e che prenderan male da sé; non bisogna voler parere, e non esser liberali.—Luigi XVI, re di Francia, fu il solo principe del secolo decimottavo che abbia voluto veramente essere e sia stato liberale. E fu detto e si dice che ei fu imprudentissimo in ciò, ne portò la pena egli, la fece portar a’ popoli suoi. Ma io dico all’incontro, che Luigi XVI non fu imprudente nell’intenzione, ma solamente nel mezzo adoperato, ma appunto nel non dar da sé tutto quello che voleva dare, e nel lasciarlo prendere; fu imprudente in quell’atto imprudentissimo fra tutti gli atti politici, di dare o lasciar prendere a un’assemblea numerosa, popolare, l’ufficio regio straordinario, dittatorio, di mutare lo Stato, di fare una rivoluzione, una costituzione. Gli antichi repubblicani greci e romani, tutti quanti, sospendeano la repubblica, il poter popolare, quando aveano a ricostituir lo Stato; concentravano per a tempo il governo legislativo in un solo uomo o pochissimi, un Licurgo, un Solone, un dittatore, i decemviri. I repubblicani italiani del medio evo, benché tanto dammeno, seppero pur sovente fare il medesimo, crear balie di pochi, per le moltiplici mutazioni di Stato che vollero fare e fecero. Fu riserbato ad un’etá, che era progreditissima sí in molte cose, e si credeva ma non era nella politica interna dismessa[131] da due secoli, il cader nell’errore grossolano di dar a fare una mutazione di Stato, una rivoluzione, una legislazione o costituzione ad un’assemblea popolare, di creare, nome novissimo, un’assemblea costituente. Questo errore trasse a tutti gli altri, alle colpe, ai delitti, agli scempi, alle nefanditá che tutti sanno, che tutti i buoni aborrirono e vituperarono giá, che ora è venuta una colpevol moda di lodare o scusare, o almeno non vituperare. La bontá dello scopo ideato da principio, ed arrivato all’ultimo, fa quest’inganno nelle generazioni presenti, dimentiche de’ fatti intermediari; e cosí noi liberali prendiamo quel brutto vizio, che condanniamo pure in altrui, di scusar i mezzi dallo scopo. Ma, mi si perdoni o no, io non mi vi arrenderò: brutto è giá l’arrendervisi tra le concitazioni della pratica, ma piú brutto nella tranquillitá dello studio; qui sarebbe premeditata adulazione per un po’ d’applausi. L’assemblea costituente del 1789 discostituí lo Stato, se stessa; fecesi governo solo, onnipotente, prepotente. L’assemblea, che le succedé nel 1791 con nome diverso, di legislativa, e facoltá minori ma poi esagerate, discostituí piú, fece o lasciò cadere quella monarchia deliberativa che sola era voluta da principio. E, nuova vergogna di quella nazione a’ que’ tempi, la terza assemblea, la Convenzione, abolí poi la monarchia senza nemmeno costituir la repubblica. Dal 1792 al 1796 che si costituí il Direttorio o governo esecutivo repubblicano, non vi fu né monarchia né vera repubblica rappresentativa; vi fu, incredibile esempio in questo secolo, una gran nazione non costituita, non governata, se non alla giornata, da’ pochi che si trovarono a caso in Parigi; or quel comune, or le sezioni di esso, ora una pluralitá, ora una minoritá dell’assemblea; or quelle di altre assemblee non legali, or l’uno o l’altro membro delle une o delle altre; un vero caos politico, un tal cumulo di scelleratezze e barbarie, da far forse scusar l’error contrario a quello detto poc’anzi, di abborrire lo scopo di libertá, in memoria de’ mezzi che l’instaurarono colá. Ma il sommo e piú pazzo delitto di quella rivoluzione fu senza dubbio l’uccisione del re. Non solo l’uccisione, ma il giudicio stesso d’un re è sommo delitto politico in qualunque regno: in uno[132] assoluto, perché ivi il re è la legge viva, lo Stato; ma forse anche piú in uno costituito ad assemblee deliberative, perché ivi il re è guarentito irresponsabile, incolpevole, dalla legge. E quindi, senza dubbio, gran delitto era stato giá nel secolo addietro il giudicio e la morte di Carlo I d’Inghilterra. Ma Carlo I non era buono e virtuoso principe come Luigi XVI; ma Luigi XVI era non solamente principe buono, ma liberale, e solo liberale de’ tempi suoi; ondeché la morte di lui fu insieme delitto di lesa maestá, lesa sovranitá, lesa nazionalitá, lesa liberalitá, lesi progressi, lesa civiltá; la morte di lui ritardò, chi sa di quanto tempo, i progressi di tutte le altre nazioni cristiane; la morte di lui fece e fa scusabili le paure, se sono queste scusabili mai, di tutti i principi d’allora in poi.—E quindi non solamente scusabile ma lodevole, a parer mio, fu il sollevarsi e confederarsi di tutta Europa, prime Austria e Prussia a Pilnitz [27 agosto 1791], poi via via il resto di Germania e Russia, Svezia, Inghilterra, Olanda, Spagna, Portogallo e pur troppo non tutta Italia, contro a quella rivoluzione diventata antiliberale e anticivile. Ed anche qui so di oppormi a molti, i quali giudicando da’ tempi presenti, da rivoluzioni minori e tutto diverse, sentenziano non dover gli stranieri, né per diritto, né per prudenza, frammettersi alle volontá di niuna nazione. Ma lá non era, non dovea, non potea supporsi volontá cosí anticivile in una nazione civile; oltreché, forse la civiltá e la libertá de’ popoli non iscapiterebbero nemmeno adesso o mai, se si venisse al principio di non soffrire nella cristianitá niuno evidente e scandaloso delitto, venga di giú o di su, di lesa civiltá o cristianitá. Del resto, chiunque esaminerá (come si fará poi senza dubbio) attentamente i fatti di que’ tempi, vedrá che le aggressioni vennero allora per lo piú da’ rivoluzionari francesi, assalenti tutti i principi europei come illegittimi o tiranni, tutti gli Stati come illegittimamente costituiti finché non fossero liberi, cioè sconvolti, a modo di Francia.—Se niuni poi, certo erano i principi e i popoli italiani in diritto, in dovere di difendersi da tali assalti; aggiugnevasi, ad essi deboli e vicini, il pericolo sommo che ne veniva a lor indipendenza nazionale. Eppure, vergogna italiana[133] simile a quella del 1494, come allora era stata lasciata quasi sola Napoli minacciata dagli stranieri, ed aveano titubato o barcheggiato gli altri, Savoia, Venezia, Firenze ed Alessandro VI, cosí ora fu lasciato solo Piemonte all’aiuto straniero austriaco, e barcheggiaron Genova, Venezia, Firenze, Napoli e Pio VI; tutti quanti. Ciò i governi; né furono migliori, piú sodi e piú politici i popoli nostri; gridaron gli uni pace, sempre pace, cioè ozio, finché la guerra non si fu appressata a poche miglia, e cosí affievolirono, invilirono i governi giá fiacchi e vili; e gli altri, i liberali di quell’etá (e diciam pure a consolazion nostra, che non portavano per anco tal nome, ma quelli di «repubblicani» o «giacobini»), fecer turpe alleanza di desidèri, di grida e di congiure colla turpe libertá, cioè colla mostruosa tirannia popolare francese. Diciamolo d’un tratto, non fosse altro, per abbreviare, e non tornarvi: principi e popoli, governanti e governati italiani della fine del secolo decimottavo, furono (salvo pochissime e tanto piú onorevoli eccezioni personali) insufficienti alla terribile occasione, mostrarono l’insufficienza delle riforme fatte lungo il secolo.
32. Continua.—Nel 1792 (morto giá Leopoldo imperatore al primo marzo, e succedutogli suo figliuolo Francesco II), si mossero gli alleati contra Francia dal Reno. Ma furono respinti a Valmy, a Jemmapes, e perdettero il Belgio e la riva sinistra di quel fiume fino a Magonza. E in Italia, mentre erano per via gli austriaci in aiuto a re Vittorio Amedeo III di Sardegna, furono tolte a questo d’un tratto, senza buona resistenza, Savoia e Nizza [settembre].—Nel 1793 [21 gennaio] salí sul palco Luigi XVI. Entrarono allora nell’alleanza molti principi che non v’erano ancora, e fra gli altri il papa e Napoli; e si sollevarono la Vandea, Lione, Marsiglia e Tolone, data poi in mano ad inglesi, a piemontesi, a napoletani [27 agosto]. Quindi, i repubblicani guerreggiavano infelicemente dentro e fuori; e perdean Belgio, Magonza e la sponda sinistra del Reno, fino alla fin dell’anno, che sotto Hoche ripresero le linee di Weissembourg e Landau. In Italia una flotta francese tentò la Sardegna, ma fu respinta [24 gennaio]. Corsica si sollevava contra[134] Francia sotto Paoli, tornatovi da qualche tempo; e vi venivan poi gl’inglesi, ed eran ricacciati all’ultimo; di che, come di provincia oramai tutta francese, non diremo altrimenti. Intanto i piemontesi ed austriaci tentarono riprendere Savoia e Nizza, e dar la mano a Lione e Tolone. Combatterono non senza vigore [8, 12 giugno] al colle di Rauss nelle Alpi marittime; ma furono respinti in ogni altro luogo; e caddero poi Lione [9 ottobre] e Tolone [19 dicembre]. A questa ripresa di Tolone, Napoleone contribuí come ufficiale d’artiglieria. Quest’anno 1793 fu il bruttissimo della storia interna di Francia. Ma confessiamolo a gloria di quel popolo; quella bruttezza fu ricompra dalla magnifica difesa della indipendenza. Salvo i regi, tutti s’unirono a tal difesa. Né serve attribuirla, come fanno alcuni, chi a Carnot, chi al terrore di Robespierre e consorti; né Carnot né il terrore non avrebbon valuto, senza quel sentimento d’indipendenza che fu solo buono rimasto allora a’ francesi, che fu tanto piú forte forse perché solo buono lor conceduto, e che bastò a ricondur poi la nazione a poco a poco a tutti gli altri, salvo la costanza. Alla quale pure essi verranno: ché quanto piú si scorron tempi o paesi, piú si vede confermato che questo sentimento genera, tosto o tardi, tutti gli altri buoni.—Nel 1794 poi, mentre cessava [28 luglio], per il supplizio di Robespierre e de’ suoi complici principali, quella somma tirannia che fu detta il Terrore, gli eserciti repubblicani uscivan di nuovo di Francia da ogni parte, riprendevano Belgio e la riva sinistra del Reno, invadevano Olanda e Spagna. In Italia s’avanzavan meno; trattenuti dall’esercito piemontese, non prendeano che le somme Alpi al piccolo San Bernardo, al Moncenisio, all’Argentiera. Ma tra l’Alpi marittime e l’Appennino violavano [aprile] la stolta neutralitá di Genova, e s’allargavano nella riviera di ponente, e né per questo si riscuoteva Genova. Né si riscuoteva Venezia, l’altra decrepita aristocrazia. Quindi, i francesi prendean Saorgio e il Col di Tenda ed altri passi, e scendean qua e lá in Piemonte. Combattessi principalmente [21 settembre] a Dego, destinato a maggior rinome. In quest’anno [23 maggio] a Valenciennes fu firmato tra Sardegna ed Austria[135] un trattato, che sarebbe stato fatale se non fosse stato stoltissimo allora ed annullato da’ fatti poi; un trattato, per cui casa Savoia dovea disfar l’opera de’ maggiori, riportar sua potenza in Francia, restituendo ad Austria altrettante province verso Lombardia.—Nel 1795 finalmente, quando i repubblicani francesi ebber riuscito a far una repubblica di due assemblee legislative con un Direttorio esecutivo [4 novembre], allora cominciarono a far paci colle potenze nemiche. E prima (brutto vanto) con Toscana [9 febbraio], che non era mai entrata né avrebbe potuto entrar seriamente in guerra; poi con Prussia [5 aprile], con Olanda [16 maggio], con Ispagna [22 luglio]. Quindi, giá non rimanendo essi in guerra continentale se non contro ad Austria e all’imperio e Piemonte, incominciarono in Germania a passar il Reno; ed in Italia ritentarono gli Appennini, e vinsero a Loano [23, 24 novembre], ma furono pur trattenuti al di lá.—Ma l’anno 1796 vide mutarsi a un tratto i modi e la fortuna di quella guerra, l’Italia, l’Europa, per l’elezione di Napoleone Buonaparte, giovane di ventisei anni, al posto di generale dell’armata d’Italia [29 febbraio]. Giuntovi appena [26 marzo], si cacciò tra l’Appennino, al centro della linea di difesa nemica, tra austriaci che vi stavano a sinistra verso Lombardia, e piemontesi a destra verso Piemonte. Vinse or gli uni or gli altri di qua, di lá, a Montenotte [11 aprile], a Dego [12], a Millesimo [14], a Mondoví [22]. E lí presso a Cherasco [28], i piemontesi abbandonarono la guerra, fecero una brutta tregua, mutata poi [18 maggio, a Parigi] in brutta pace; per cui lasciavano l’alleanza, cedean Savoia e Nizza; davano in mano ai francesi le migliori fortezze dello Stato, quelle fortezze vergini d’assalto, in cui e con cui avrebbon potuto e dovuto resistere, e cui date, si facean servi. Fu incredibil viltá, comparata alla virtú antica dei piemontesi, di casa Savoia; ma essi avean fatte almeno quattro campagne, una brutta, ma tre belle; avean tenuto lo straniero quattr’anni su quell’Alpi e quegli Appennini, ove eran accorsi con essi pochi austriaci, non un altro italiano. Conchiudiamo, che allora il migliore Stato italiano valea poco, gli altri nulla.—Intanto Buonaparte proseguí sua invasione, sue[136] vittorie. Subito passò il Po a Piacenza [7 maggio], concedé una tregua con multa al duca di Parma [9], combatté e passò l’Adda a Lodi [9]; entrò in Milano [15] trionfante ed applaudito da’ repubblicani, o, come li chiama Botta, gli «utopisti» italiani, esecrato dal grosso delle popolazioni che si sollevarono qua e lá. Trattenutone pochi dí, riavanzò, passò l’Oglio, entrò nel territorio della moribonda Venezia, che per la terza o quarta volta deliberò non tra pace o guerra, ma tra neutralitá armata o disarmata, e s’appigliò a questa. E vincendo poi a Borghetto [28 maggio], entrò in quel campo di guerra tra Mincio ed Adige, dove egli, il giovane ed arditissimo de’ capitani antichi o moderni, vi si fece quasi un Fabio indugiatore, vi si fermò, vi si piantò, vi aspettò quattro eserciti nemici, contentandosi di vincerli in una guerra difensiva e lunga di otto mesi intieri, dove poi quella devota vittima di Carlo Alberto non fu rimasto un mese senza che i capitani di bottega, di setta, di piazza, od anche di piú autorevoli assemblee, lo spingessero ad uscire, ad avanzare, a correr paese, a dar la mano a chiunque si sollevasse, a guarnir l’Alpi, ad estendersi, a perdersi, a perder la piú bella occasione che sia stata mai all’Italia. Ed a piú dolore e piú vergogna si ritenga, che il gran capitano francese aveva, lasciategli da’ veneziani, Peschiera, Legnago e Verona, mentre l’infelice italiano aveva contro sé queste tre fortezze, l’ultima delle quali accresciuta a tal segno da annullare in paragone l’importanza di Mantova stessa, e da essere il baluardo, la piazza d’armi, il palladio della potenza austriaca in Italia. Cosí dismessa ogni altra impresa, ogni altra idea, ogni altro pensiero, avesse egli assalito Verona seriamente, lentamente, destinandovi i mesi, gli anni, qualunque tempo! Ma, sinceramente, era egli possibile ciò? Forse sí; ma se mai, co’ due modi napoleonici: primo, lasciar dire, e ridur la guerra a quell’impresa; secondo, minacciar di far fronte addietro, contro ai perturbatori della patria. Ma non erano né dovevano essere modi nostri. Vi pensi, sí, per un’altra volta, l’Italia. I campi di guerra dati dalla natura non si mutano per andar de’ secoli; l’arte, rinforzandoli, li fa anzi piú importanti. E da Mario e i cimbri, o forse prima, fino[137] a noi, quel campo di Mincio ed Adige fu, è e sará quello ove si combatterá, se mai, la causa nostra. Diavi allora la patria campo libero, e senza disturbi a’ suoi soldati. Chi sta al terribile ed onorato gioco dell’armi è suscettivo, concitabile, iroso, e, se sia lecito dire, nervoso. Rispettate i combattenti, non disturbateli; non meno che le loro ire, temete le loro svogliatezze; serbate loro alacritá, lasciateli vincere una volta; e ricompensateli poi, se vi paia, coll’ingratitudine. Non sará il primo esempio; ma intanto voi sarete stati liberati.—Sei giorni appresso, Buonaparte accerchiò Mantova [3 giugno]. Cosí collocato, die’ alcuni giorni, e gli bastarono, ad assicurarsi, a spalla, degli Stati minori italiani. Entrò a Modena [19], poi a Bologna, in Toscana [26]; gettò un presidio a Livorno, e firmate tregue con Napoli e col papa, tornò dinanzi a Mantova. Ivi egli era minacciato da un secondo e grande esercito austriaco, che scendea sotto Wurmser per Tirolo, dai due lati del lago di Garda. Al 29 furono assaliti i posti francesi. Al 31, quel giá sommo de’ capitani moderni abbandonò l’assedio, si volse tutto alla guerra campale; ed in sei dí, vincendo a Lonato [3 agosto] e a Castiglione [5], rigettò Wurmser nelle Alpi tirolesi. Ma rifattovisi questo e minacciando nuova discesa, di nuovo Buonaparte prese l’offensiva; e combattendo dal 3 al 5 settembre, risalí Tirolo fino a Trento: poi, non trovatovi Wurmser che scendea intanto per Val di Brenta, ve l’inseguí con magnifica risoluzione, a Bassano, a Legnano, e lo ridusse a buttarsi in Mantova [13]. Allora, libero di guerra campale, ricominciò e spinse l’assedio.—Ma minacciava intanto dal Friuli Alvinzi con un terzo esercito, la terza campagna austriaca dell’anno; bella costanza da svergognare le debolezze italiane. Le virtú degli avversari son le piú importanti a riconoscere, per prenderle e vincerle. Al 10 ottobre Napoli, al 5 novembre Parma firmavan lor paci con Francia. Modena, Bologna e Ferrara, occupate e sommosse da’ francesi, si dichiaravan libere, formavano l’efimera repubblica cispadana [16 ottobre]. Il medesimo dí, morto Vittorio Amedeo III, succedeva Carlo Emmanuele IV figliuolo di lui, nel regno occupato ed asservito; nel regno che, egli principe buono[138] e pio, tenne pochi anni poi, quasi una sventura, una penitenza, una croce. Il dí 1º novembre Alvinzi passò la Piave, ed in vari combattimenti respinse l’esercito francese sull’Adige, fece pericolar la fortuna di Buonaparte. Ma a un tratto, questi scende da Verona per la destra d’Adige, il passa, prende in fianco Alvinzi, lo sconfigge ad Arcoli [15, 16, 17 novembre], e torna quindi all’assedio di Mantova. Tal fu l’anno 1796, che rimarrá famoso sempre nella storia militare, per l’arte innalzata al sommo dalla giovanile e meravigliosa facoltá inventiva di Buonaparte. In Germania gli eserciti francesi avanzati oltre Reno, erano sforzati a indietreggiare dall’arciduca Carlo, e facevano una bella ritirata sotto Moreau; ed anche queste operazioni e questi capitani sono gloriosi.—L’anno 1797 s’aprí con una quarta discesa austriaca, una quarta difesa offensiva e nuove vittorie di Buonaparte. Alvinzi ridiscendea dall’alto Adige, Provera assaliva sul basso [12 gennaio]. Buonaparte corre al primo, e lo vince a Rivoli [14]; corre al secondo giá arrivato alla Favorita dinanzi a Mantova, e vince lui e Wurmser uscito dalla piazza, e prende il primo, e fa rientrar il secondo [16]; ondeché questi, ridotto agli ultimi, in breve capitolò [2 febbraio]. Ed ora, ad uno solito ed anche buon capitano sarebbe paruto tempo di riposar l’esercito; ma non a Buonaparte. Mossosi contra il papa, firmava [19 febbraio] la pace a Tolentino, facendosi cedere (oltre Avignone) Bologna, Ferrara, le Legazioni, trenta milioni. Poi, addí 10 marzo, moveva Joubert per il Tirolo, Massena per la Ponteba, se stesso al Tagliamento, per finir la cacciata degli austriaci dall’Italia, per passare d’Italia ad Austria, quell’Alpi tante volte passate a rovescio; un esercito francese doveva venirne a dar l’esempio. L’arciduca Carlo, il piú grande de’ capitani che abbiano combattuto Francia fino a Wellington, comandava quel rinnovato e forte esercito austriaco che era il quinto da un anno. Ma addí 16 Buonaparte vinse al Tagliamento, addí 19 all’Isonzo; varcate l’Alpi, si trovava addí 31 a Klagenfurth, riunito con Massena, presso a riunirsi con Joubert. Intanto, a sue spalle sollevavansi contro a lui Bergamo [12], Brescia [17], Salò [24], Crema [28]; tutte quelle popolazioni veneziane che la[139] vil repubblica non aveva sapute usare contro all’invasore in faccia, che ora ella gli sollevava o si sollevavano a spalle, opportunamente come poteva parer allora, piú inopportunamente che mai, come si vide in breve. Buonaparte sentí il pericolo, accresciuto dal non saper che gli eserciti francesi del Reno avesser incominciate lor mosse; temé aver tutta Austria dinanzi, tutta Italia addietro; propose negoziati [31]. Ma rifiutato, riavanzò arditamente, combattendo a Unzmark [3 aprile], e fino a Leoben [7]. Allora Austria, minacciata al cuore, domandò essa l’armistizio. Fecesi di cinque giorni. Finiva addí 13 al mattino; arrivarono in quel punto i plenipotenziari austriaci a trattar pace. Trattossi altri cinque dí; e firmaronsi i preliminari lí a Leoben, addí 17. Austria cedeva il Belgio e il Milanese da rivolgersi in repubblica; doveva compensarsi in Germania coi principati ecclesiastici da abolirsi, in Italia col territorio di Venezia fino all’Oglio; rimanendo Venezia da compensarsi colle Legazioni e Modena, cioè colla efimera repubblica cispadana: stranissimo riparto della schernita Italia. Ma il dí prima de’ preliminari [17], che era un lunedí di Pasqua, anniversario de’ vespri siciliani, sollevavasi Verona, facevansi vespri veronesi. Ridiscese quindi il gran vincitore e mal pacificatore dall’Austria in Italia; mandò sue minacce, suoi ordini, sua vendetta a Venezia, ed egli, con stupenda arte di perfidia, si scostò dall’esecuzione, fu ad aspettarla a Milano. Addí 12 maggio, in gran Consiglio, la vile aristocrazia veneziana abolí se stessa, restituí, diceva, la libertá alla nazione, cioè a una repubblica democratica, cioè a una municipalitá alla francese. Questa chiamò gli stranieri addí 16. E, al medesimo dí, le medesime condizioni, i medesimi patti pattuivansi in Milano, tra i plenipotenziari veneti e Buonaparte! Talmente a cenni, a dito del vincitore fu consumata quella distruzione d’uno Stato di mille anni. Seguirono moti in Genova, per cui anche quella repubblica fu mutata da aristocratica a democratica francese, e prese nome di «ligure»; moti nella Valtellina contro a’ grigioni, per cui Buonaparte, fatto arbitro, tolse quella provincia a’ grigioni e diedela alla repubblica cisalpina, che stavasi, come si disse allora, organizzando. E seguirono negoziati, dapprima di[140] pace generale in vari luoghi, e poi, rotti quelli, di pace particolare tra Francia ed Austria presso a Campoformio; e Buonaparte in persona li condusse, vi tiranneggiò Austria, Francia, Italia a modo suo. Rigettato da Cobentzel il suo ultimatum, ruppe addí 16 ottobre; e addí 17 fu accettato quello, e fattane pace definitiva. Francia (giá accresciuta di Savoia, Nizza, Avignone) rimase accresciuta del Belgio e della riva sinistra del Reno; e questi e gli altri ordinamenti germanici rimandati legalizzare ed ultimare a un congresso futuro a Rastadt. Venezia e la efimera repubblica cispadana sagrificate del tutto; Austria compensata in Italia con Venezia e tutto suo Stato (salvo l’isole) fino all’Adige. Una repubblica cisalpina (brutto nome che sottintendeva «Francia») costituita a Milano, e formata di Lombardia, Modena e le Legazioni.—Napoleone fu incontrastabilmente il piú gran capitano di questo e molti, e forse tutti i secoli; e l’anno non corso intiero, dall’11 aprile 1796 al 7 aprile 1797, basterebbe a dargli tal vanto. Ma Napoleone fu, senza dubbio, mediocre politico ad ordinare Stati internamente, pessimo ad ordinarli insieme, a rifar quella carta d’Europa che egli tanto pur meditò e rimutò. Negli ordinamenti interni, non badava a libertá, negli esterni, non a nazionalitá; né in quelli né in questi, ai desidèri, ai voleri, al potere dell’opinione universale. Nei tanti riordinamenti che fece d’Europa, non badò mai a limiti, a schiatte, a lingue, a natura; non ebbe mai l’idea, sola effettuabile durevolmente, di costituir nazioni. Qui non pensò a costituir l’italiana che era pur sua, o del padre e della madre sua: egli non vi lasciò solamente, vi accrebbe fin d’allora la potenza austriaca; egli ve la stabilí in modo da far l’Italia settentrionale campo inevitabile di nuove lotte tra Francia ed Austria, campo di servitú alla prima di queste per pochi anni, alla seconda Dio sa per quanti; egli fu il primo inventore degli ordinamenti del 1814 e 1815. Vero è che vi fu aiutato dall’incredibile stoltezza di quasi tutta Italia, della rimbambita Venezia principalmente, e di quelle popolazioni sollevatesi appunto appunto per autorizzar chi le voleva sacrificare.
33. Segue fino alla pace d’Amiens [1797-1802].—La condizione precaria fatta da quella mala pace all’Italia era questa: Austria dunque fino all’Adige; la novizia repubblica cisalpina, composta di antichi sudditi austriaci, modenesi, papalini, divisa in parte antica e che or diremmo legittimista assoluta, e parte democratica pur assoluta, niuna di mezzo; esercito novissimo lentamente sorgente, e vituperato di quel detto di Buonaparte che non avrebbe resistito ad un reggimento piemontese; e quindi con tal pretesto e ragione, un esercito d’occupazione francese, e generali e commissari dittatori, cioè insomma dipendenza straniera assoluta. La monarchia piemontese rimaneva ridotta e stretta tra le due repubbliche di Francia vera e Francia cisalpina, ed occupata essa pure, attraversata da francesi. Parma sopravviveva sotto lo scudo di Spagna, Toscana sotto quello d’Austria. Roma travagliata tra suo vecchio governo e la vicinanza della nuova ed invadente democrazia cisalpina, Roma pareva all’ultima agonia; ed eravi per allora, e sarebbe stata per sempre, se non vi fosse il poter temporale appoggiato allo spirituale. E finalmente la regina Carolina ed Acton fremevano da Napoli contro alle novitá, cui non avean saputo resistere nel farsi, cui fatte volevan disfare. Insomma, o per vecchiezza mal sostenuta, o per nuova e cattiva costruzione, tutti gli edifizi degli Stati italiani minacciavan rovina.—La prima fu quella di Roma. Scoppiovvi una sommossa di repubblicani [28 dicembre 1797], cosí dappoco che non resistettero ai dragoni del papa. Rifuggirono al palazzo di Francia, dov’era ambasciatore Giuseppe Buonaparte fratello di Napoleone, e a lui addetto un giovane generale Duphot. Questi fu ucciso nel tumulto. Fecesene scandalo, grida, violazione iuris gentium, e via via. Arrivò Berthier, generale in capo de’ franco-cisalpini, al 10 febbraio 1798, entrò, fu menato in trionfo a Campidoglio; e lí sotto, a Campo Vaccino, dinanzi ad un notaio, fu proclamata la repubblica romana. Non sarebbe pregio d’opera anche piú distesa riferire le costituzioni, o peggio i subbugli, le parti, cioè i pettegolezzi di questa e delle seguenti repubblichette efimere. Piú seria, piú storica la resistenza del vecchio ed or dignitoso[142] e coraggioso pontefice; il quale ricusò ogni rinuncia, e fu subito portato via a Toscana, ed indi a Valenza in Francia, dove morí [29 agosto 1799].—Intanto cadeva casa Savoia. La repubblica ligure infrancesata dichiarava la guerra a Carlo Emmanuele. Intromettevasi Francia, ed occupava la cittadella di Torino. E finalmente, a un medesimo di a Parigi e a Torino, dichiarava la guerra (tirannica derisione) al re giá spogliato d’ogni mezzo di resistenza; e questi abdicava [9 dicembre] virtuosamente protestando, ed era poi portato via a Toscana, e lá imbarcato per Sardegna. E cosí, dopo quattro anni di difesa militare, e due di difesa diplomatica (sostenuta principalmente dal Priocca ministro degli affari esteri e dal Balbo ambasciatore a Parigi) cadeva anch’essa non senza dignitá casa Savoia. Questa e il papa soli fra’ principi italiani ebbero, non avendo saputo resistere, l’onore almeno di aver saputo soccombere. E del Piemonte pure fu tentato fare una repubblica; ma non fu conceduto dai francesi, che lo serbarono sotto un governo, come si diceva, provvisorio.—Napoli poi cadde poco appresso, ma men bene di gran lunga. Carolina ed Acton ministro, e Mack generale tedesco assoldato da essi, e Nelson ammiraglio inglese trionfante della sua recente vittoria navale ad Abukir, immaginarono decidere, romper essi dal loro angolo d’Italia quella guerra, che si riannuvolava giá da tutta Europa. Apparecchiato un grande esercito, i napoletani invasero la nuova repubblica romana, entrarono in Roma [29 novembre], abbandonata dal piccolo corpo francese di Championnet. Ma battuti i napoletani fin dal primo incontro ad Otricoli [9 dicembre], lasciaron Roma; e rientrovvi Championnet, e li inseguí ai limiti del Regno ed oltre. Ferdinando Borbone, spaventato, salpò con la moglie e la corte sulle navi di Nelson per Sicilia [31 dicembre].—Al nuovo anno 1799, si avanzò Championnet contro a Capua [3 gennaio], e firmò un armistizio [11] con Mack; ma sollevossi Napoli contro a questo ed al governo del re, e la cittá rimase in mano a’ lazzaroni, sotto il principe di Moliterno, che finí quella confusione chiamando i francesi [23 gennaio]. Ed ivi pure fu organizzata una repubblichetta alla francese, la quale[143] (perché non erano ancora di moda le caricature del medio evo, ma sì quelle greche e romane) fu detta «partenopea».—Scoppiava poco appresso la guerra della seconda coalizione europea; da una parte, Inghilterra che non avea cessato mai, Austria che ricominciava diciotto mesi dopo la pace mal fatta e peggio eseguita di Campoformio, e Russia che entrava or per la prima volta in guerra effettiva; dall’altra, Francia e le sei repubbliche satelliti sue, olandese, elvetica testé rivoluzionata, democratizzata, centralizzata e ribattezzata, ligure, cisalpina, romana e partenopea. Jourdan passando il Reno in Germania [1º marzo], Massena passandolo in Elvezia [6], e l’arciduca Carlo passando il Leck [3], aprirono la campagna. La quale fu condotta colá infelicemente per Francia, ma pure serbando all’ultimo le due linee del Reno e della Limmath. In Italia poi Scherer e l’esercito francese incominciarono essi passando l’Adige [26 marzo]; ma battuti nei dí seguenti da Kray, si ritrassero [7 aprile] sul Mincio, e quindi precipitosamente sull’Oglio, sull’Adda. Scherer avvilito lasciò il comando a Moreau, giá generale in capo illustratosi in Germania, e qui semplice general di divisione. Intanto arrivava l’esercito russo sotto Suwarow, capitano molto illustratosi in Turchia e troppo in Polonia. E perché a Championnet, richiamato dall’esercito di Napoli nell’Italia superiore, era succeduto Macdonald buon capitano esso pure, fu bella guerra anche questa. Moreau battuto a Cassano sull’Adda il dí appresso a quello in che prese il comando [28 aprile], si ritrasse lentamente a Milano, a Torino; e dato tempo cosí alla fuga scompigliata de’ repubblicani cisalpini e piemontesi, passò il Po, lascionne tutta la riva sinistra, ridisceselo sulla destra, e si collocò al confluente del Tanaro tra Alessandria e Valenza. Suwarow prese Torino, ma esso pure ridiscese il Po a manca, e, passatolo, si collocò a Tortona in faccia a Moreau. Questi gli sguizzò di mano, e posesi a Novi, tendendo la destra a Macdonald che arrivava da Napoli, Roma, Toscana abbandonate. Verso la metá di giugno eran presso a riunirsi i due. Ma fosse fretta di Macdonald o indugio di Moreau, quegli si trovò impegnato solo contro a Suwarow bellamente cacciatosi in mezzo.[144] Alla Trebbia combatteronsi tre giornate [17, 18, 19]. E battutovi Macdonald, si riuní allora a Moreau per l’Appennino; sul quale fu cosí cacciato tutto l’esercito francese, rimanendo il resto d’ Italia in mano agli austro-russi. E quindi si vede, come da altri esempi numerosi antichi, nuovi e novissimi da Annibale fino a noi, che ivi pure tra il Po, la Trebbia e l’Appennino è un altro campo apprestato dalla natura, fortificato poi dall’arte variamente, alle guerre italiane, un campo che è primo o secondo in importanza a quello di Mincio ed Adige, secondoché le guerre ci vengono di Francia o di Germania; campo poi difensivo principale, forse unico, al Piemonte contro l’Austria. Vergogna a noi, a noi piemontesi dico, di non averlo saputo adoprare nell’ultima nostra prova. Avrebbe bastato a ciò seguir le patrie tradizioni, e principalmente gli ultimi esempi di Suwarow e Moreau.—Seguirono restaurazioni degli antichi governi non meno efimere, che le repubblichette testé cadute. A Napoli tornarono re, regina e il resto, incrudeliti a vendetta dal recente avvilimento e dal subitano e immeritato trionfo. Ivi Nelson sporcò la propria gloria e la bandiera inglese, imprestandola ai supplizi. In Roma, in Firenze, in Torino eran proclamati papa, granduca e re, ma assenti, e governarono intanto gli alleati poco diversi da nemici, piú odiosi. Come gl’italiani repubblicani poc’anzi, cosí ora i regii poterono imparare, che sieno le difese, le protezioni, gli ordinamenti stranieri. Austria aveva allora tutta Italia in sue mani; e mostrò l’intenzione di serbarne molto o tutto; e perdette l’opinione de’ propri partigiani. In Piemonte principalmente, crebbe allora l’antico odio ad essa. Che piú? Per questa aviditá, Austria perdé la guerra stessa; per assicurarsi del paese ridusse la guerra campale ad assedi; furon prese Alessandria [22 luglio], Mantova [30]. Allora coll’esercito riunito, Suwarow s’avanzò all’Appennino, e vinse in gran battaglia a Novi l’esercito francese capitanato da Joubert, e, lui ucciso, di nuovo da Moreau [15 agosto]. Quindi l’esercito francese si ridusse in parte dentro e intorno a Genova, e in parte sul Varo a difendere Provenza. E giá, passati in Isvizzera Suwarow e l’esercito russo [21 settembre], Melas coll’esercito[145] austriaco tentava Genova.—Ma mutavasi allora di nuovo a un tratto e del tutto la fortuna di Francia per l’arrivo di Napoleone Buonaparte dall’Egitto, che egli avea conquistato da due anni, e che lasciava ora senza ordini, di proprio moto, per venirsi porre a capo della mal condotta e da lui disprezzata repubblica. Addì 9 ottobre, approdava a Fréjus; addí 9 novembre [18 brumaire], distruggeva il Direttorio, e metteva invece un governo di tre consoli provvisori, se stesso, Sièyes e Ducos. Elaborata quindi una nuova costituzione con un primo consolo, che naturalmente fu egli, e due minori, Cambacérès e Le Brun; entrarono in carica il dí di Natale 1799; mille anni, dí per dí, dall’assunzione di Carlomagno all’imperio.—Quindi subito, e piú poi ne’ primi mesi del 1800, seguí sotto a Napoleone quel ricalcare i propri passi la rivoluzione francese, quella, come si diceva allora, controrivoluzione, tanto temuta da tutti i rivoluzionari, tanto immanchevolmente destinata a tutti, quel mirabile restaurarsi e riordinarsi dell’amministrazione, della giustizia, delle finanze, dell’esercito di Francia, che ci fu recentemente cosí ben narrato dal Thiers; ben narrato, dico, perché nemmen egli, francese e napoleonico, ma liberale, non tace né vela ciò che vi mancò, la libertá. Lo stupore d’Europa a sì grandi mutazioni, gl’indugi degli austriaci che per otto mesi dopo la battaglia di Novi non fecer quasi nulla né in Italia né fuori, dieder agio a Napoleone ad apparecchiar la magnifica campagna del 1800. Pose Moreau ed un forte esercito in Elvezia ed Alsazia sul Reno, con ordine di passarlo; Massena e le reliquie degli eserciti d’Italia a difesa di Genova e d’Appennino; e un terzo esercito di riserva sotto Berthier nominativamente a Digione, di fatto qua e lá, dove venivan raccogliendosi le divisioni, le brigate via via; cosicché, tra il grido sparsone e il non trovarsene quasi traccia a Digione, furono ingannate le spie nemiche, credettero finzione e vanto la verità bandita. Gli austriaci apriron la campagna. Melas assalì Massena addí 5 aprile, e fortissimo contra debole, lo rinchiuse in Genova e lo separò da Suchet che si ritrasse quindi sul Varo, e vi fece una lunga e bella difesa, mentre Massena fece la sua bellissima di Genova. Quindi[146] entrò in campagna Moreau [25], passò il Reno su quattro punti da Strasburgo a Sciaffusa; e combattendo e vincendo a Stockach, a Moesskirk, giungeva al Danubio, ad Ulma, dove riduceva l’esercito austriaco di Kray. Posava quindi, staccata giá una forte divisione sua al San Gottardo, per iscendere in Italia in aiuto a Napoleone. Questi poi erasi mosso terzo [5 maggio] da Parigi; e attraversata Digione dove erano appena alcuni depositi dell’esercito di riserva, n’avea raggiunto il grosso sulle sponde, anzi al sommo capo del lago di Ginevra. Addí 14, aveva spinto Lannes e sue prime divisioni a passar il Gran San Bernardo; poi l’altre ne’ dí seguenti fino al 20, che passò egli. Lannes scendendo per Val di Dora, s’era abbattuto contro al forte di Bard, che la chiude, e passato sulle balze a sinistra, come poté, era pur progredito. Cosí fece a stento il resto dell’esercito, Napoleone. Addí 22, Lannes sboccò da’ monti, e prese Ivrea; addí 28, dai colli, e prese Chivasso sul Po. E raccolto lá alla pianura oramai tutto l’esercito, Napoleone minacciò a destra Torino, ma piombò a stanca sul Ticino [31], e passatolo, su Pavia e Milano [10 giugno]. Entrò egli in questa il dí appresso; e pensi ognuno le meraviglie, le gioie dei repubblicani, dei cresciuti nemici d’Austria, degli amici de’ francesi e della libertá, pur cresciuti all’ordinarsi apparente di essa in Francia. Né fermossi guari Napoleone costí. Partendo di Parigi aveva accennato col dito in sulla carta la pianura tra Alessandria e Tortona, come quella ove Melas preso a spalle raccoglierebbe probabilmente l’esercito austriaco, per rompersi una via alla ritratta. E Melas, sorpreso a Nizza mentre guerreggiava tranquillo contro Suchet, obbediva ora al dito fatidico correndo egli e facendo correre sue divisioni disperse al punto assegnato. Massena intanto era sforzato dal difetto assoluto di viveri in Genova, addí 4; e, fatta un’onorevole ed utile capitolazione, sbarcava quindi a Savona dove dava la mano a Suchet giá riavanzato. E Napoleone, lasciata Milano addí 8, raggiungeva l’esercito suo che giá aveva passato il Po a Pavia. Addí 9, incontravansi i due primi corpi nemici a Stradella e Montebello; e vinceva il francese sotto Lannes, che n’ebbe poi il nome.[147] Quindi seguendo e convergendo a destra, tutto l’esercito francese trovavasi in Voghera e Tortona, contro all’austriaco raccoglientesi ad Alessandria. Trovavansi cosí i due eserciti in una di quelle posizioni dove forza è si decidano i destini delle nazioni; l’esercito francese aveva l’austriaco tra sé e Francia, l’austriaco aveva il francese tra sé ed Austria; ma con questa gran differenza, che il francese cra venuto costí a posta e credea tagliare, l’austriaco sorpreso teneasi per tagliato; ed ognun sa, che anche in guerra l’opinione fa la forza. Tre dí passarono in formarsi, assicurarsi l’uno e l’altro. Addí 13, Napoleone, passata la Scrivia, e spiegatosi ne’ piani di Marengo e non trovatovi il nemico, temettelo scampato. Ma all’aggiornare del 14, sboccò questo dal ponte della Bormida, e si spiegò nei medesimi piani. E lí, da mattina a sera si combatté quella lunga, varia, intensa battaglia, vinta dagli austriaci quasi tutto il giorno, rivinta da’ francesi nell’ultime ore per lor mirabile costanza, per quella principalmente di Desaix che vi morí. Qui sorge piú che mai il rincrescimento di non aver agio a descrivere, ammirare, lodare. Insomma, Melas e gli austriaci furono fermati, rotti, disfatti, ricacciati, riaffollati in Alessandria; e al domane [15] Melas firmava una capitolazione, per cui gli fu conceduto ritrarsi dietro al Mincio ed al Po; ed egli concedeva Piemonte, Lombardia, Liguria, Parma, Modena, le Legazioni, Toscana; e cosí la restaurazione della repubblica cisalpina. Napoleone ripassò trionfando a Milano, a Torino; ritornò trionfando a Parigi. Allora Moreau, concitato da tanto esempio, assalí pur egli in Germania i nemici, e li vinse e spinse fin dietro l’Inn, e firmò pur esso un armistizio [15 luglio]. Poche nazioni, pochi uomini ebbero mai un’epoca di gloria e fortuna crescenti, come questa che incominciò qui a Francia, a Napoleone; e pochi uomini ne usarono bene, come egli allora. Continuò, accelerò, svolse riordinamenti interni ed esterni; ripropose paci, e rigettato riuní nuovi eserciti a nuovi trionfi. Addí 28 novembre, fu rotto l’armistizio. Addí 3 dicembre, Moreau vinse una gran battaglia ad Hohenlinden, e passò quindi l’Inn e la Salza e firmò poi un nuovo armistizio a Steyer [25 dicembre]. Ed intanto un secondo esercito[148] francese dalla Svizzera passava la Spluga [5 dicembre]. Ed il terzo in Italia sotto Brunc passava il Mincio [25 dicembre] e l’Adige [1º gennaio 1801], e firmava pur esso il suo armistizio a Treviso [16 gennaio]. Finalmente [9 febbraio 1801] firmavasi a Lunéville la pace tra Francia ed Austria, simile a quella di Campoformio: Austria dietro l’Adige; Cisalpina formata, come giá, del Milanese, Modena e le Legazioni; Piemonte e Toscana abbandonate alle ulteriori disposizioni di Francia. E seguirono quindi, rapide, e quasi appendici di questa, altre paci via via. Per un trattato fatto pochi dí appresso con Ispagna [21 marzo] Napoleone facevasi ceder Parma e Piacenza, e innalzava quella casa borbonica a un nuovo regno d’Etruria. Pochi altri dí appresso [28 marzo], Napoli faceva pace, e cedeva Porto Longone, Elba, i Presidi e Piombino. E finalmente, addí 15 luglio, firmavasi il concordato tra Francia e Pio VII, nuovo papa eletto ultimamente [14 marzo 1800] a Venezia, mirabilmente eletto, come uomo che s’era giá mostrato intendente de’ tempi, da uomini che cosí mostrarono intenderli. Poi, adunatasi a Lione una Consulta di cisalpini, mutava sotto la dettatura dell’onnipotente vincitore e pacificatore la costituzione della repubblica cisalpina, e gliene deferiva la presidenza [26 gennaio 1802]. E qui un grande scrittor moderno accenna a non so qual gioia e qual concorso dell’opinione italiana. Ma noi vecchi n’abbiam ancor qualche memoria; e il fatto sta che, gioia o no, questa Consulta fu poco piú che obbedienza al cenno straniero, e cerimonie. Seguirono altre ed altre paci; ultimate, confermate tutte da quella tra Francia ed Inghilterra firmata ad Amiens [27 marzo 1802]. La cristianitá era in pace; ma divisa essa tra due potenze prepotenti una in mare, l’altra in terra; divisa l’Italia tra Francia prepotente e crescentevi, ed Austria ridotta a soffrire, era chiaro a tutti che non potea durare né questa ripartizione particolare, né quella generale.
34.—Napoleone primo consolo e presidente della repubblica italiana, poi imperatore e re d’Italia [1802-1814].—Nei dodici anni di che ci resta a dire, non solamente non furono grandi fatti nazionali, ma nemmeno grandi fatti stranieri in Italia. Le guerre qui rinnovate[149] non furono piú, come poc’anzi, principali, ma secondarie in Europa; e le paci furono obbedienze di poco men che tutti allo straniero. Tuttavia, fra i tempi d’obbedienza, niuno fu lieto, operoso, forse utile, quasi grande e glorioso come questo. Men vergogna era servire con mezza Europa ad un uomo operosissimo, grandissimo, e che si potea dir di nascita, e dovea dirsi indubitabilmente di sangue, di nome, italiano; e servirlo operosamente, in fatti grandi, moltiplici, incessanti, crescenti, e continuamente mutanti, i quali non si potea prevedere a che avesser a riuscire, e si poteva sperare riuscissero a qualche gran riunione e liberazione d’Italia; men vergogna dico, che, come in altri tempi, servir quasi soli e languidi in mezzo alle indipendenze e libertá ed operosità universali.—Non faccio scuse per coloro che cosí servirono, spiego che cosí servirono allora. Non v’era indipendenza, è vero, ma non ne furono mai speranze cosí vicine. Non v’era libertá politica, ma n’erano almeno le forme in un gran centro italiano; non libertá civile ben guarentita, ma legale almeno; e poi, v’era quella eguaglianza che a molti, bene o male, fa compenso alle mancanze di libertá. Non libertá di scrivere, certamente; ma non gelosie, non paure d’ogni sorta di coltura, non disprezzo degli uomini colti, non quella separazione tra essi e gli uomini pratici, che è il maggior de’ disprezzi, e quasi smentita e scherno delle vantate protezioni. Chiuso poco dopo il mare, non vi fu operosità commerciale; ma v’eran quelle delle industrie, e dell’agricoltura, e della milizia: dico quell’operosità di guerra, che è senza dubbio calamità all’universale, ma felicità suprema forse a molti di coloro che l’esercitano, perché è supremo esercizio dell’umane facoltà. E allora gli italiani, primi i piemontesi, poi i lombardi e romagnoli, e via via toscani, romani, napoletani, corsero a quell’esercizio, e vi furon affratellati a quei militari, avanzati e lodati in quegli eserciti vincitori d’Europa; e quegli italiani sentivano di far allora ciò che non avean fatto da secoli i maggiori, ciò che speravano si facesse poi dai nepoti; quegli italiani credevano incamminar i posteri alla rinnovata virtù italiana. Insomma, era servaggio senza dubbio, ma partecipante alla concitazione,[150] all’alacrità, all’orgoglio dei signori; non quello oppressivo compressivo, depressivo di tanti tempi anteriori e posteriori. E cosí, da quegli anni, dal principio di questo secolo, incominciò a ripronunziarsi con piú onore ed amore il nome d’Italia; da quegli anni incominciò a mirarsi ad essa tutta insieme, e incominciarono a cadere quelle invidiuzze od invidiacce municipali o provinciali che avean lussureggiato da tanti secoli, e pur testé, nelle repubblichette efimere ed utopiste del medio evo e della fine del secolo decimottavo, e che lussureggiarono piú tardi nuovamente. Sottentrò, è vero, quello che i fatti dimostrarono ripetutamente poi sogno del regno unico italiano; ma se, caduto il sogno, saprà serbarsi la realità dello spirito nazionale, se la fine del secolo nostro non sarà del tutto indegna del principio, forse che questo diventerà èra a migliori destini d’Italia. Ma noi dobbiamo affrettarci al termine del nostro assunto.—Il resto dell’anno 1802 vide una nuova costituzione della repubblica ligure [26 giugno], cosí portata a segno dell’ultime, francese ed italiana; piccolo affare conseguente agli altri. Ma seguí [11 settembre] la riunione a Francia di quel Piemonte, la cui condizione erasi lasciata dubbia fin allora; e incominciò cosí quell’estendersi innaturale del territorio francese in Italia, che mostra (oserò ridirlo?) la incapacità di Napoleone nella politica vera, grande, fondatrice. Ed io so che mi scosto qui non solamente dagli scritti apologetici di lui Napoleone, ma da uno scrittore recente, da me come da tutti molto ammirato; ma egli pure sarebbe certo fin d’ora, e rimarrebbe poi forse piú lungamente ammirato, se, tenero com’egli è della nazionalità francese, fosse piú intendente dell’altre; se cercasse gli accordi di quella con queste, se non avesse voluto rimanere cosí stazionario (anch’egli) ai tempi del suo eroe; se avesse voluto progredire a’ presenti che tendono a quell’accordo di tutte le nazionalità cristiane. Ad ogni modo, seguí la mediazione di Napoleone in Isvizzera e la rioccupazione di lei; e tra per questi estendimenti della potenza continentale di Napoleone, e quello marittimo di Malta che Inghilterra volle ritenere a compenso, e il volersi ciascuno estender solo e non patir che s’estendesse l’altro, si ruppe la[151] guerra nuovamente tra Francia ed Inghilterra [maggio 1803]. Seguirono, la congiura de’ legittimisti francesi, George, Polignac e compagnia; la presa sul territorio germanico e la morte del duca d’Enghien, il piú vile degli atti di Napoleone [21 marzo 1804]; poi l’istituzione e proclamazione dell’imperio francese [18, 20 maggio]; e l’istituzione e proclamazione dell’imperio ereditario austriaco [4 agosto]; il viaggio di papa Pio VII a Parigi, dove consacrò il nuovo imperatore [2 dicembre], e incominciò forse a guastarsi con lui; e il regno d’Italia ricevuto, cioè preso, dal nuovo imperatore [18 marzo 1805], e poi il viaggio di lui qui, l’incoronazione a Milano [26 maggio], e le vane parole «Guai a chi la tocca!» pronunciate nel prender la corona di ferro; e Genova riunita innaturalmente, non al nuovo regno d’Italia, ma all’imperio di Francia [4 giugno]; e cosi Parma [21 luglio]; e Lucca fatta principato per una sorella dell’imperatore, giá principessa di Piombino [23 giugno].—Austria, Russia non vollero tollerar piú; fecero la terza coalizione; strinsersi con Inghilterra, la liberarono dalla discesa a lei minacciata da due anni nella Manica. Napoleone levò a un tratto i campi ove avea ragunate, esercitate, ordinate piú meravigliosamente che mai sue vecchie divisioni [27 agosto]; e facendole attraversar Francia di corsa, le portò in Germania, dove incominciarono a chiamarsi la «grande armata», e grande fu poi veramente ed in numero ed in fatti per nove anni. Intanto Austria ruppe la guerra, passò l’Inn [8 settembre], invase Baviera. Credeva, incominciando essa, assicurarsi l’offensiva; ma questa è sempre de’ piú forti e piú abili; e Napoleone solea lasciar incominciare il nemico per vederlo spiegarsi, e prenderlo sul tempo poi, o, come diceva egli, «in flagrante». Cosí fece. Partí di Parigi [24], passò il Reno [1º ottobre], tagliò, ruppe corpi austriaci qua e lá, li accerchiò da manca, e li fece capitolare ad Ulma [19 ottobre]; e attraversando Baviera entrò a Vienna [13 novembre]. Allo stesso tempo l’esercito francese, e giá in parte italiano, d’Italia, ragunato sotto a Massena, vinceva l’austriaco sotto l’arciduca Carlo a Caldiero [30 ottobre]; e spintolo dinanzi a sé, passava il Tagliamento, al medesimo[152] dí che il grande esercito entrava a Vienna; e combattendo e vincendo univasi a questo addí 24 novembre in Austria. Ma un grande esercito russo ed Alessandro imperatore s’erano pure uniti al resto dell’esercito austriaco, ed a Francesco II. Ed uscito di Vienna Napoleone, s’incontrarono, si combatterono ad Austerlitz in Moravia i tre imperatori in gran giornata, al dí anniversario dell’incoronazione di Napoleone [2 dicembre 1805]. Vinse questi, il gran capitano, naturalmente; e seguí tra pochi dí un armistizio, e tra pochi altri la pace firmata a Presburgo [26 dicembre]. Per questa rimasero cacciati gli austriaci oltre all’Isonzo, e riunita Venezia al regno d’Italia; e rimasero acquistate a Napoleone, ma non riunite a niuno Stato, tenute quasi a riserva per li suoi disegni futuri, le antiche province veneziane in Illirio. Quali erano questi disegni? Certo orientali, contro all’imperio turco, al quale ei voleva cosí farsi limitrofo, per partecipare in ogni caso a sue spoglie. Ma per li particolari ei se ne rimetteva al tempo, alle occasioni e loro ispirazioni. Thiers e Mignet ci rivelarono ultimamente due disegni concepiti da due parti contrarie: proposto l’uno da un italiano e dal principe Czartorinski ad Alessandro prima della guerra, l’altro da Talleyrand a Napoleone in mezzo ad essa, combacianti i due nella idea di spinger e ingrandir Austria sul Danubio per liberarsene ad Occidente. Le preoccupazioni, gl’interessi momentanei, ciò che il volgo dei politici chiama sola politica, spinsero a tutt’altro Napoleone vincitore allora, Alessandro vincitore di poi. I tempi avvenire possono soli far chiaro quale fosse men sognatrice, quale definitamente piú duratura, o la politica solamente invaditrice, invaditrice per invadere, senza discernimento, di Napoleone ed Alessandro, o la fondatrice di Czartorinski e Talleyrand. Solea dir questi «esser merito suo prevedere un po’ piú presto ciò che tutti dovean veder poi». Ad ogni modo Napoli avea fatto poc’anzi [21 settembre] con Francia un trattato di neutralitá, e Saint-Cyr col corpo che occupava Otranto da parecchi anni s’era quindi ritratto e congiunto coll’armata d’Italia. Ma Napoli avea due mesi appresso [20 novembre] ricevuti inglesi e russi, s’era volta ad essi. Era un’altra di quelle[153] stoltezze de’ deboli che riescon fortune a’ potenti ed usurpatori. Napoleone vincitore mandò ad eseguire il facile castigo un esercito, che entrò nel Regno [8 febbraio], in Napoli [15]; e casa Borbone fuggí di nuovo a Sicilia. Giuseppe Buonaparte fratello di Napoleone fu primo re de’ Napoleonidi, fu proclamato re di Napoli e Sicilia [30 marzo]; e regnò nella prima, continuando casa Borbone nella seconda. Gaeta si difese bene, non s’arrese se non al 18 luglio. Meglio ancora Calabria, che non fu ridotta tutta se non piú tardi [al principio del 1808], e nemmeno allora non obbedí tranquilla. Oh se i principi italiani avessero saputo valersi della devozione e del coraggio nativo de’ lor sudditi! riunirlo, disciplinarlo, avvezzarlo! Seguí [5 giugno] l’instituzione di un secondo re napoleonide, Luigi in Olanda. E seguí un grandissimo fatto, appena avvertito allora. Addí 6 agosto di quell’anno 1806, Francesco II, ultimo successore degli imperatori de’ romani, rinunciò a quel titolo, vano senza dubbio da gran tempo, ma impaccio pure e vergogna nostra finché l’udimmo portare da tanti stranieri.—Seguirono poi la guerra tra Prussia e Napoleone, minacciata giá l’anno addietro dalla prima, dismessa poi dopo la vittoria d’Austerlitz, rotta ora dal vincitore, vendicativo e guardingo, e precipitato ad ogni modo d’una in altra vittoria, d’una in altra conquista. Seguirono le battaglie di Jena [14 ottobre], d’Eylau, di Friedland, [8 febbraio, 14 giugno 1807], e la pace di Tilsit [7 e 9 luglio].—Dopo la quale s’avventò, s’inebbriò peggio che mai il conquistatore nella politica stoltamente invaditrice. Egli imperiava in Francia, Italia e Germania, incontrastabilmente; non gli bastarono. Volle Spagna, e almen si capisce, era un gran regno di piú; ma volle Roma, e non si capisce, essendo cosí poca cosa materialmente rispetto all’imperio che egli aveva, ma cosí grande rispetto al pericolo, alla perdita d’opinione a cui andava incontro.
Il fatto sta ch’ei non faceva caso di questa opinione; non di Spagna, né di Roma che credeva avvilite, impotenti a resistere. Ma, come volle Iddio, Napoleone s’ingannò: Dio vuol sovente che s’ingannino i prepotenti. Incominciò a metter truppe[154] francesi in Ispagna sott’ombra di conquistar Portogallo; e conquistatolo, entrò in una serie di negoziati e perfidie e violenze, per cui tutta la casa di Borbone rimase spoglia degli antichi regni di Spagna e del nuovo d’Etruria. Fece occupar Toscana [12 dicembre]. Poi in breve, inasprito giá contro al papa per molte contese, e principalmente perché questi ricusava entrare nella lega continentale contro ad Inghilterra, fece pur occupar gli Stati di lui, e Roma stessa [1º febbraio 1808]. Poi riuní le Marche al regno d’Italia [2 aprile], e Parma, Piacenza e Toscana a Francia [24 maggio]; fece passar Giuseppe re di Napoli a re di Spagna (come mutava i prefetti da un dipartimento all’altro); e diede Napoli a Murat suo cognato, prode generale di cavalleria [15 luglio].—Tuttociò ridestava le costanti ire d’Austria; e la resistenza incontrata dagli eserciti francesi, da Giuseppe, e da Napoleone stesso in Ispagna, ridestarono le speranze di lei. Ricominciò la guerra. Era la quarta fatta, e sempre infelicemente da quella potenza contra Napoleone generale, primo consolo e imperatore. Vergogna militare, ma gloria politica di quel governo cosí sovente sconfitto, cosí perdurante sempre. In aprile 1809, gli eserciti austriaci invasero a un tratto Baviera in mezzo, il nuovo granducato di Varsavia a settentrione, Italia a mezzodí dall’Isonzo. Napoleone accorse da Spagna a Parigi, al Reno, a Germania. E su quel campo a lui giá noto, con operazioni piú grandi ma simili (tanto quel sommo inventor di guerre sapeva obbedire al costante imperio del terreno!) ruppe, sbaragliò, vinse l’esercito nemico dell’arciduca Carlo in vari combattimenti e in uno grande ad Eckmüll [22 aprile]; e passò l’Inn [26], e prese Vienna [13 maggio]. E intanto l’armata d’Italia, piú che mai grossa d’italiani misti con francesi, e capitanata questa volta da Eugenio Beauharnais figlio adottivo di Napoleone, viceré e dichiarato erede del regno d’Italia, indietreggiava dapprima dall’Isonzo fin presso all’Adige; ma si fermava a Caldiero, ed ivi, dove avea vinto poc’anni innanzi, rivinse ora [29 aprile]. Quindi riavanzando avea passato, combattendo, Brenta, Piave, Tagliamento, Isonzo; presa Trieste [17 maggio], passate l’Alpi, dato mano al grande esercito francese,[155] e poi vinta da sé una bella e gran battaglia a Raab [14 giugno]. Quindi si vede, quanto sia pur vero che vi fosser consolazioni alla servitú di que’ tempi. E allora e poi non poche divisioni italiane, non pochi capitani nostri s’illustrarono nelle guerre di Spagna: ma questi combatteron per far compagna nella servitú una generosa nazione; e perciò non contiamo tali glorie come fortune.—Lí da Vienna poi Napoleone consumava quell’usurpazione di Roma, che fu la piú leggiera al profitto, la piú grave allo scandalo, e forse al danno, di quante avesse fatte. Un decreto imperiale [17 maggio] riuniva Roma e il resto dello Stato a Francia. E ai 10 giugno era proclamata a Roma quella stolta riunione da Miollis e da una Consulta governativa composta di francesi ed italiani. Al qual fatto giugnendo, domandò licenza di notare che ad uno di questi, educato da un padre d’incomparabil virtú e precision di principi, la colpa fu tanto piú grave che ei vi ripugnava, e cedeva; non iscusata ma scemata forse dall’etá sua di diciannov’anni, da lui messa a profitto ad ogni modo coll’imparar lá a resistere per l’avvenire. Imperciocché fu ammirabile la resistenza di quei preti disprezzati; fu la sola bella e grande nell’Italia di quegli anni. Una scomunica fu affissa il dí appresso in tutta Roma, a malgrado le truppe, il governo, la polizia che l’occupavano; e quindi si sparse in Francia e tutta Europa; e se non fece certamente l’effetto delle scomuniche del medio evo, scemò pur molto in Italia e Francia e Spagna gli aderenti a Napoleone, fu il sassolino gettato al piè dell’idolo universale. E fu portato poi via il papa [6 luglio 1809] da un general di gendarmi a Toscana, e di lá fatto errare a Francia, a Savona, a Fontainebleau; mentre succedevansi in Roma co’ poteri di lui i vicari pontefici, e portato via l’uno, scoprivasene uno nuovo; e portavansi via cardinali e prelati, niuno cedente, finché se ne stancò la polizia francese; che non credo sia stato dato mai un esempio cosí unanime e costante di quel coraggio civile o disarmato, che piú d’ogni altro forse tira a sé l’opinione degli uomini, e la toglie agli opprimenti.—Ma, come succede, non se n’avvedeva l’oppressore principale tra’ successi crescenti. Passato il Danubio,[156] vinse a Wagram [5, 6, 7 luglio], e dettò poi una nuova pace a Schoenbrunn [14 ottobre]; per cui oltre a nuovi acquisti in Germania, ei fece quelli d’una parte di Gallizia o Polonia austriaca, ed una nuova d’Illirio. S’egli avesse presa invece Gallizia intiera, e riunitala al granducato di Varsavia, e fattone un bel regno di Polonia, egli l’avrebbe avuto a potentissimo aiuto due anni appresso. Ma il fatto sta, e si conferma ad ogni tratto, che egli non concepì mai la piú bella dell’ambizioni e delle politiche, quella di liberare e fondar nazioni. Due n’ebbe nella potente destra, e non ne fece nulla; e quando poi spoglio di tutto ei ruminò dolorosamente a Sant’ Elena le glorie e gli errori di sua potenza caduta, tentando spiegazioni e scuse, ei non seppe trovarne altra qui, se non quella troppo sovente recata da chi non vuole dare, non esser ancor tempo di dare. Il fatto sta che scemava giá il grand’uomo, s’impiccolivano piú che mai le ambizioni di lui. Ebbe quelle due piccole e da uomo nuovo, di nobilitarsi con un matrimonio e di lasciar al proprio sangue fortuna fatta. Repudiò la donna strumento giá di suo primo innalzamento, la compagna di sue glorie giovanili e maggiori; quella che, non per vani influssi, ma colla dolce compagnia, aveva dato forse il temperamento giusto e necessario al suo animo eccedente, ed era stata cosí cooperatrice di tutte le sue fortune. Sposò invece Maria Luisa d’Austria [2 aprile 1810]; n’ebbe un figliuolo che intitolò re di Roma [20 marzo 1811]. E, precipitando nella politica sfrenata e delle riunioni innaturali, riunì Olanda, riunì Germania settentrionale a Francia. Dall’Elba al Tevere, da Amburgo a Roma chiamaronsi «francesi» tre schiatte, tre lingue, tre nazioni diverse; e ne rimasero confuse, scemate, quasi distrutte le tre nazionalitá, due vinte, una quantunque vincitrice. E giá meditava ed apparecchiava un’altra riunione, degli spagnuoli fino all’Ebro. Ma gli spagnuoli ebbero allora la gloria di resistere soli sul continente a tutto ciò; gl’inglesi, di aiutarveli, essi che non correan pericolo dalla loro isola; Wellington, d’esser capo militare a tale unica e bella resistenza. E i perduranti ebbero poi l’aiuto che non manca mai, le occasioni; ebbero quello che men di[157] rado manca, l’esagerarsi nella prepotenza, lo stoltizzare del prepotente.
35. Continua.—Tra il 1811 e il 1812, stoltizzò Napoleone non solamente nello scopo, ma ne’ mezzi stessi oramai di sua politica. Egli aveva fino allora corteggiato Alessandro; ed ora ei sacrificò quell’alleanza e quell’amicizia alla stoltezza del suo sistema continentale contro ad Inghilterra, volle sforzarvi Alessandro che si ribellò alla prepotenza, e ne seguí la guerra. Ed egli avea corteggiati i polacchi; ed ora ei li sacrificò, non li restaurò per riguardi ad Austria, posseditrice d’una lor provincia. Poi, aggiugnendo errori ad errori, fece [24 febbraio, 14 marzo] due trattati d’alleanza con Prussia ed Austria, prendendo un trentamila uomini soli a ciascuna, e cosí lasciandosele a spalle quasi intiere e mal affette, anzi frementi. Era colmo di disprezzo delle passioni, degli interessi, delle opinioni altrui: ma fu insieme colmo d’inganno. Ei disse e credette far un’irruzione dell’Europa occidentale contro all’orientale, della civiltá contro alla barbarie; ma la civiltá, l’indipendenza stavano allora per Russia; e cosí questa vinse. Napoleone (trattenuto oltre all’intento a Parigi da un primo di quegli accidenti del cielo che mostrano piú chiaramente il dito di Dio, dal timor di una carestia) passò il Niemen [23 giugno]; entrò a Vilna [28], a Vitepsk [28 luglio], a Smolensko [17 agosto], dopo combattimenti e battaglie via via crescenti quanto piú avanzava. E cosí combatté la maggiore alla Moscowa [7 settembre]; e la vinse, ed entrò a Mosca [14].—Ma lá, presso all’Asia, fu il termine di sua fortuna. Né soli noi, pochi sorviventi di quella generazione, ma le generazioni nuove sanno e sapran gran tempo fin da fanciulli, tutti i fatti di quella quasi epopea de’ giganti moderni: l’incendio di Mosca, gl’indugi di Napoleone, sue speranze di aver pace; sua partenza [19 ottobre], la ritirata di quelle turbe d’eroi intimoriti, l’inverno precoce, il cielo nemico, i campi nevosi, le vie perdute all’innanzi, segnate addietro da’ morti e morenti; i cosacchi, le orde asiatiche spingenti e taglianti l’allungata fila; l’eroismo di Ney e tanti altri; Napoleone impavido, e che chiamava demoralizzati coloro che per lui soffrendo, non[158] soffrivano come lui. Al settimo dí della ritirata, quando erano intiere per anco le divisioni, fu la battaglia piú ordinata che ancor vi si facesse, quella di Maloiaroslavetz [24 ottobre]. E fu vinta, tanto almeno da prolungar la ritirata, dall’armata d’Italia capitanata dal viceré. Ai 28 novembre i resti passarono la Beresina, combattendo ancora, disperdendosi poi. Napoleone fuggí l’irremediabile calamitá, e fu a Parigi [18 dicembre]. Gioacchino Murat re di Napoli indugiò qualche tempo a raccozzar i rimasugli; ma un decimo forse dei cinquecento e piú mila uomini che avean passato il Niemen. Perironvi, proporzionatamente piú che degli altri, i meridionali, i fratelli nostri; tu vi perivi quasi fanciullo ancora, ed osservato pur per valore da quei vecchi guerrieri, o Ferdinando mio, cresciuto all’arti, alle lettere, ad ogni bellezza, ad ogni amore, a quel d’Italia, per cui non moristi; per cui, del tuo nome, di tua virtú, di tua gioventú, di tua bellezza moriva un altro poi, anche piú mio.—Ed anch’egli, Gioacchino, lasciò poco appresso quella trista e quasi inutile ritirata; e rimase il comando al viceré d’Italia, il quale ordinolla come poté, e condussela per tutto l’inverno tra il 1813 e il 1814 fino all’Elba. Prussia intanto s’era sollevata, venuto il tempo, contro all’oppressore di lei, statole piú grave che a nessun altro. Austria, sempre piú indugiante, s’era solamente ritratta dall’odiato alleato, ed armava e minacciava: e cosí Germania tutta, a fianco, a spalle dell’esercito francese. Questo fu il bel tempo di Germania, quand’ella seppe valersi dell’occasione per rivendicarsi in indipendenza; quando seppero unirsi a ciò principi e popoli; quando i principi seppero promettere concessioni, e i popoli fidarsi a quelle promesse, che non è vero sieno state, ed anche meno sien per essere, inadempiute tutte. Gli spagnuoli pure avean ciò saputo, e v’aveano avuto tanto piú merito, che era assente e mediocre il principe loro. Gl’italiani soli nol seppero; e perciò i figli loro rimangon l’ultima fra le nazioni della cristianitá europea; ché in quegli anni di cui narriamo furono poste le fondamenta di quell’edifizio europeo restaurato che ancor dura.—Ai 15 aprile 1813, Napoleone ripartí di Parigi per riprendere il[159] comando della grande armata; e pari militarmente o superiore a se stesso, vinse al 1º maggio russi e prussiani in gran battaglia a Lutzen; addí 20 e 21 a Bautzen. Fecesi tregua, trattossi pace, non fu possibile niun accordo; si ricominciò la guerra, unita ora Austria alla crescente alleanza contra Francia. Addí 27 agosto, russi, prussiani ed austriaci assalgono Napoleone in Dresda, e sono vinti, respinti; e vi muor Moreau, mal venuto dall’esilio d’America a porsi tra le file dei nemici di suo paese. Ma vinto e preso pochi dí appresso Vandamme con un grosso corpo francese in Boemia, e riaffollandosi gli eserciti alleati contro a Napoleone, ei poté sí tenerli a bada alcun tempo; ma soverchiato finalmente dal numero, fu sforzato a ritrarsi. E concentrato l’esercito a Lipsia, fu vinto ivi in una battaglia di tre dí [16, 17, 18 ottobre]. Questo fu il fine, questa la piú bella battaglia della grande armata. Alcuni di que’ panegiristi che cercando vanti falsi trascuran i veri, e guastan cosí fin le glorie degli eroi, vantano la grand’armata quasi non vinta mai; se non dalle stagioni, dal vento o che so io. Fu vinta essa, ma non dal vento, fu vinta dal numero de’ nemici, dagli abbandoni degli alleati, dalla spossatezza propria; fu vinta, magnificamente perdurando, che è la piú grande delle glorie militari, politiche, umane. Ed io intendo rivendicare parte di quella gloria per li nostri italiani che lá perirono, numerosi, prodi, fedeli, degni di lor maestri di guerra. Sventuratamente, i superstiti credettero essere stati sacrificati da questi, dietro a un ponte rotto nel ritirarsi; e se n’accese lor ira, ed io scrittore li udii pochi dí appresso a Magonza. E questo ed altri disprezzi che credettero aver sofferti da Napoleone o dal viceré, furono causa dello scostarsi gli animi di molti principali dell’armata d’Italia da que’ due principi, e dell’abbandonar l’ultimo pochi mesi appresso mal generosamente, mal utilmente. L’Italia di quei tempi non seppe né respingere i Napoleonidi come gli spagnuoli, né scuoterli a tempo come i tedeschi, né serbarli quando sarebber diventati italiani. E cosí, dubitando, chiacchierando, tumultuando e non operando all’occasione, ella perdette questa che fu pure delle piú belle. Se gl’italiani avesser saputo non guardar[160] addietro ma all’innanzi, non a vendetta ma a perdonare, dimenticare, ed alle occasioni riunirsi a coloro che le tengono in mano, gran tempo è che sarebbero indipendenti. Quando il sapranno?—Ad ogni modo, dopo la gloriosa ma finale sconfitta di Lipsia, si ritirarono i francesi poco men disordinati che in Russia, attraverso Germania sollevata, e vinsero un’ultima volta ad Hanau [30 ottobre] i bavaresi che tagliavano il passo. Passati, si raccolsero dietro al Reno, e Napoleone tornò a Parigi. Intanto, era tornato il viceré al regno d’Italia fin da dopo Lutzen, Gioacchino a Napoli dopo Lipsia. E il primo avea raccolto un esercito di francesi e italiani, e portatolo oltre ai limiti del regno nelle province illiriche, fin sulla Sava e la Drava [agosto]. Ma ivi pure era un forte esercito nemico; ne erano da tutte parti. E cosí, il franco-italico ebbe a ritrarsi ricalcando addietro lentamente quella via, corsa avanzando tante volte da pochi anni; dalle Alpi all’Isonzo, al Tagliamento, alla Piave [11-31 ottobre], e finalmente all’Adige e Verona [9 novembre]. E lí si fermava, ed indi riusciva a vincere una volta ancora a Caldiero [15]; e lí intorno perdurava poi e guerreggiava tutto quell’inverno. Non cosí Gioacchino; il quale, giunto a Napoli [5 novembre], trattò con gli alleati nemici di Napoleone, e ragunando un esercito napoletano, occupava Roma, Toscana, Ancona, Bologna, lasciate da’ francesi; mentre una squadra inglese veleggiava minacciando e tentando sbarchi sulle coste di Toscana [dicembre]. E parlava Gioacchino d’indipendenza italiana; e di essa pure gli inglesi. Ma gl’italiani non badavano al primo; ché la generosa parola, per farsi ascoltare e trarsi addietro gli animi e le braccia, vuol esser bandita generosamente da uomini generosi; né era tale certamente Gioacchino in quel momento, che tradiva Napoleone suo creatore. E quanto agli inglesi, essi, per vero dire, fin dal giugno dell’anno addietro, avean fatto dare una costituzione rappresentativa simile alla loro in Sicilia da re Ferdinando; cosicché Carolina, nemica di tali novitá, se n’era fuggita per Costantinopoli ad Austria, e re Ferdinando avea lasciato il governo a suo figliuolo. Ma, fosse colpa degli inglesi dispregiatori talora ed offensori de’ popoli[161] che beneficano, o degli italiani pregiudicati contro di essi per le continue calunnie mosse loro da Napoleone e da’ francesi di que’ tempi, o che in somma non fosse entrato bene ancora il gran pensiero negli animi italiani, il fatto sta che non si mossero questi nemmeno a quel grido d’indipendenza. I tempi, anche vicini, sono talora diversissimi tra sé. Corsi pochi anni, quel grido sollevò l’Italia intiera: corsi pochi altri, ella, forse pur intiera, combatterà.—Finalmente, addí 20 dicembre 813, gli alleati passarono il Reno, entrarono in Francia; guardinghi e quasi tementi, principi e generali; ebbre di trionfo e vendetta (ma almen vendetta dopo la liberazione) le popolazioni straniere; massime le germaniche affollate in quegli eserciti. I francesi, spossati da ventidue anni di guerra, non difesero la loro indipendenza sotto al signore, come avean fatto nuovi e liberi. Napoleone partí a’ 25 gennaio 1814 da Parigi; combatté e vinse ogni dí per due mesi con cuore, con mente indomita, con arte degna del giovane generale del 1796. A Brienne, a Champaubert, a Montmirail, a Vauchamp furono giornate famose. Ma scemavano via via sue file, stringevasi suo campo di guerra intorno a Parigi; e si rinnovavano, all’incontro, s’accavallavano gli eserciti stranieri, e lo stringevano. Al fin di marzo ideò portarsi a spalle degli alleati, correr Francia orientale, raccogliervi le guarnigioni lasciate colá, e l’armata d’Italia. Ma fu preso egli sul tempo: gli alleati precipitarono su Parigi, e addí 30 vinsero sotto alle mura facilmente re Giuseppe e Marmont, e addí 31 entrarono. E cosí cadde quell’uomo, di cui niuno potrá mai nascer piú grande per facoltá naturali, militari ed anche politiche; cadde, per l’error solo di non aver fondata sua potenza, addentro, sulla libertá, di fuori, sulla indipendenza delle nazioni; cioè, dentro e fuori, sull’amore interessato dei popoli. Vantossi egli, vantarono gli adulatori di sua sventura, che egli pure fosse caduto per quel caso imprevedibile di fortuna, quell’inverno precoce, quel vento settentrionale di Russia. Ma il cader per un caso, per un vento, mostrerebbe tanto piú che erano poco profonde le fondamenta di sua potenza. E poi, non è vero nemmen questo. Anche Napoleone cadde dopo una[162] perduranza militarmente magnifica. Ma la perduranza, che serve sempre alle nazioni perché elle si rinnovellano, non serve sempre a un esercito che non si può rinnovellare, e non serve mai a un uomo che non sappia aver seco una nazione. Inutile sarebbe poi moltiplicar qui particolari e date, piú o men vergognose a quella nazione vicina nostra. La severitá è piú ingrata allo scrittore che a’ leggitori; né a ciò è obbligato se non per la patria. Del resto, tutte le nazioni s’assomigliano quando s’avviliscono; e s’avviliscon tutte, quando (colpevoli od anche incolpevoli) elle son cadute in braccio a’ stranieri. Il senato, conservatore dell’imperio, lo distrusse [2 aprile]. Napoleone abdicò [11], fu portato via. Rientrarono i Borboni, Luigi XVIII.—E intanto, in Italia, il viceré avea continuata sua bella difesa: Gioacchino suo brutto avanzarsi. Il primo, combattendo e talor vincendo contra piú forti, s’era ritratto non piú che da Adige ad Adda e Taro, in due mesi. Il secondo, dichiaratosi contra il viceré, s’avanzava a Piacenza. Un corpo inglese era sbarcato a Livorno [6 aprile]. Finalmente giunte le nuove di Parigi, firmavasi un armistizio [16 aprile], per cui le truppe francesi s’incamminarono a lasciar Italia. Rimaneva il governo italiano, il senato a Milano. Addí 20 deliberava; e molti volean re Eugenio Beauharnais. Una sommossa di quegli uomini che non badano a perder la patria per isfogar un’ira, una vendetta o una invidia, empiè le vie, spaventò il senato, uccise Prina ministro delle finanze. Dio perdoni a tanta (per non dir altro) stoltezza! Certo, niuna fu maggiore mai. Dicono che il viceré non era amato, per alcune parole dette contro agli italiani; forse quelle parole furono scusate in quel dí. D’allora in poi fu finito il regno d’Italia, lasciato all’occupante. Gli austriaci entrarono a Milano [28]. Murat rientrò a Napoli [2 maggio]. Vittorio Emmanuele re di Sardegna (succeduto per la rinuncia di Carlo Emmanuele IV, 22 giugno 1802) sbarcò in Genova [12 maggio], entrò in Torino [20]. Pio VII a Roma [24]. E addí 30 fu firmato il trattato di Parigi, per cui, restituito il regno di Francia negli antichi limiti, fu restituita casa Savoia ne’ suoi Stati continentali, salvo una porzione di Savoia lasciata allora a Francia;[163] Parma e Piacenza date a Maria Luisa imperatrice e al re di Roma suo figliuolo; Modena, a Francesco arciduca d’Austria, erede di Ercole Rinaldo ultimo duca Estense, morto duca del Brisgau [-1803]; restituita Toscana a Ferdinando III; restituiti gli Stati pontifici al papa; lasciati Murat in Napoli, Ferdinando IV in Sicilia; lasciata restaurarsi, ma temporariamente, la repubblica di Genova; occupate da Austria e l’antica sua provincia di Lombardia, e Venezia giá datale in compenso di quella stessa, or del Belgio; data l’isola d’Elba in sovranitá e quasi in ischerno a Napoleone. I trattati, gli eventi del 1815 mutarono poi tutto ciò in parte, ampliarono casa Savoia di quasi tutti i paesi oltre Alpi lasciati giá a Francia, e del magnifico acquisto di Genova; passarono l’ereditá futura di Parma e Piacenza al duca di Lucca, e quella di Lucca a Toscana giá ingrandita dell’Elba; restaurarono in Napoli Ferdinando IV, e confermarono ad Austria il regno lombardo-veneto. Ma giá questi fatti appartengono a un periodo di tempo, il quale appunto non fu piú di due preponderanze combattute, ma di una sola piú largamente, piú unitamente stabilita che mai; un periodo che incominciò dunque peggiore del precedente, ma che non sappiamo come né quando finirá. Ed ai tempi non adempiuti, non si può dar nome, né luogo forse, nelle storie generali.
36. Le colture di quest’ultimo periodo [1700-1814].—Ora, passando da tante e tali rivoluzioni di popoli e d’imperii alle vicende delle lettere, delle scienze e delle arti, scema un’ultima volta il nostro discorso. Perciocché vano è l’illuderci di noi scrittori, che ci vantiamo troppo sovente di diriger noi i secoli e loro eventi, che siamo in realtá molto piú sovente diretti da essi. Certo che ne’ tempi tranquilli, cioè quando posan le guerre e la politica, importanti possono essere gli eventi letterari, possono allora servire ad apparecchiare i politici e militari. Ma questo, per veritá, è quanto dire che importano gli eventi letterari, quando non ne sono altri piú importanti; è dire che dobbiamo servire a quelli con modestia personale, colla coscienza di non essere se non apparecchiatori, coll’intento fermo di servire all’apparecchio.[164] E qui poi di nuovo abbiamo a dir insufficiente l’opera degli scrittori settecentisti, posciaché non apparecchiarono se non ciò che vedemmo di politica e guerra italiane. Ma qui pure abbiamo ad ogni modo a lodare e forse a invidiare l’opera di quegli ultimi avi e padri nostri.—Risorsero nel secolo decimottavo tutte le colture italiane indubitabilmente. E due cause, due motori ne appariscono: l’indipendenza accresciuta addentro, e l’impulso venutoci dal resto d’Europa, della cristianitá; o piuttosto le due cause si congiunsero in ciò, che la caduta della signoria spagnuola fin da’ primi anni del secolo ci diede occasioni di ricever gli impulsi della politica e della coltura universali. Tale è, per dono di Dio, la costituzione della cristianitá, che avendo essa (anche la parte errante di lei) un solo Dio, un solo vangelo, una sola virtù, ella non può avere se non una sola coltura, o, se si voglia, parecchie colture somigliantissime; e che, chi si sforza di tenerle disgiunte, o, peggio, nemiche, farebbe opera empia se non la facesse vanissima; e che, a malgrado di costoro, le colture nazionali diventano di secolo in secolo men diverse, piú simili, piú identiche, piú una. Così fu fin da’ primi secoli della cristianitá: meravigliosa è l’unitá della coltura de’ padri greci e latini; meravigliosa quella degli stessi secoli barbari e scolastici. La coltura italiana, innalzandosi di gran lunga sopra l’altre, rimase in ciò per quattro secoli diversa dall’altre senza dubbio; ma questa quasi esclusivitá fu propria dell’etá del risorgimento e non si può riprodurre. Giá vedemmo che nel secolo decimosesto e nel decimosettimo la coltura italiana si comunicò, si diffuse nelle tre colture, spagnuola, francese, inglese: e fin dal principio del secolo decimottavo incominciarono tutte queste a rifluire sull’Italia. Ed influì poi, benché piú tardi e meno, la coltura tedesca, non sorta essa se non molto indirettamente e parzialmente dall’italiana, non sorta se non alla metá di questo secolo decimottavo, con Lessing, Moeser, Winckelman, Eulero, Kant, Wieland, Goethe, Schiller. L’unitá della coltura cristiana si mantenne dunque, si manterrebbe anche senza la stampa; ma, sorto, come pur volle Iddio, questo potentissimo, questo umanamente invincibile mezzo di unitá, ella s’unificò e s’unifica sempre[165] piú, quanto piú venne e viene allargandosi e moltiplicandosi questo mezzo. Ancora, venne e viene aggiungendosene un altro: la facilitá, la moltiplicitá de’ viaggi tra l’una e l’altra nazione cristiana, dell’orbe intiero. Stampa e viaggi crebbero notevolissimamente nel secolo scorso; stampa e viaggi crescono incomparabilmente a’ nostri dí. Quanto poi all’Italia del secolo decimottavo, si vede da tutte le memorie, che dal principio di esso e lungo esso s’accrebbe via via l’andare e venire di stranieri colti in Italia, e massime di colti italiani al di fuori; e che lo splendore delle colture nostre crebbe via via nella medesima proporzione. E quindi non ci sará giá possibile notare separatamente tutti i nostri uomini di lettere o di scienze che vissero piú o meno fuor d’Italia; perciocché sarebbe poco men che notare tutti quelli che avremo a nominare.—E prima, della poesia fu detto da alcuni storici letterari che ella risorse fin dal cader del secolo decimosettimo, per opera dell’accademia degli Arcadi allora istituita [1690]. Ma, come a molti, cosí a me paiono gli Arcadi aver fatto poco piú che mutare una vanitá, un’affettazione in un’altra, il seicentismo in un settecentismo poco migliore, i concetti in quelle sdolcinature pastorali che empierono tutto quanto questo secolo. Ma fu gloria di questo, che tra quel pessimo gusto e quella calca sorsero pur molti poeti diversissimi, occupatisi in quasi tutti i grandi generi della poesia, e molto opportunamente in quelli sopra tutti che mancavano per anche alla nostra. Perciocché ei bisogna pur dirlo; quell’«indulgere genio», quell’abbandonarsi alle volgari ispirazioni, quel venir facendo e rifacendo letteratura facile, che è vantato da taluni, seguito da tanti, massime in poesia, non riesce oramai né utile alla patria, né glorioso allo scrittore, nemmeno in poesia; e noi veggiamo all’incontro tutti i buoni e gloriosi del secolo scorso e del presente aver piú o meno fatto come Alfieri; cioè essersi messi di proposito, con fatica ed insistenza, a supplire a una mancanza, a riempire un vuoto delle lettere patrie. Ad ogni modo, fiorirono dalla fine del Seicento al 1814 Apostolo Zeno [1669-1750], Niccolò Forteguerri [1674-1738], Scipione Maffei [1675-1755], Metastasio [1698-1782], Alfonso da Varano [1705-1788], Goldoni[166] [1707-1793], Gaspare Gozzi [1713-1786], Parini [1729-1799], Cesarotti [1730-1808], Alfieri [1749-1803], Ippolito Pindemonte [1753-1828], Monti [1754-1828], Foscolo [1778-1827]; una serie magnifica per qualunque secolo, e poco minore, se è, a quella dei poeti del Cinquecento; una serie che ci mostra emulata allora l’eleganza de’ poemi cavallereschi e didascalici del Cinquecento, quasi inventati e insieme portati al sommo i generi dell’opera in musica, della commedia, della tragedia e del poema satirico, e tentato il romanzo, e rinnovate le varietá, la forza, la virilitá, la grandezza de’ soggetti e dello stile in tutta la poesia italiana. Del resto, fra tutti questi, due principalmente mi sembrano doversi tener cari nelle memorie italiane, Parini ed Alfieri; siccome quelli, il cui merito non fu solamente poetico o letterario, ma morale e politico, e che rimangono del piccol numero de’ nostri poeti morali e virili.—Non solamente il Parini si tenne discosto dalle scurrilitá e dalle trivialitá che deturparono tanti celiatori italiani (fra gli altri il Casti e il Passeroni contemporanei di lui), discosto da que’ soggetti filosofici e peggio sacri, dove le celie anche decenti sono inconvenevoli; ma ei seppe opportunamente rivolgere le sue ad utilitá, anzi ad uno de’ soggetti ov’elle convengono piú, a corregger i vizi aristocratici, i vizi di quelle classi, le quali, ribellandosi all’altre correzioni, sono piú tenere a questa. Il Parini non fu certamente solo correttore di quel vizio, ridicolo al nome stesso, di cicisbeismo, che regnò ne’ due secoli decimosettimo e decimottavo; ma ei fu certo uno de’ primi e de’ piú efficaci; aiutò l’opera de’ fatti e del secolo, che è quanto può sperare qualunque scrittore; e l’aiutò, perché non volle essere né degli adulatori né dei copritori, non temette essere degli svelatori ed assalitori de’ vizi patrii. Sono di quelli, anch’oggi, che si scandalizzano a queste rivelazioni, e si fanno autoritá di quel detto di Napoleone, che «bisogna far il bucato in famiglia». Ma Napoleone disse questo del dividersi, nel pericolo, dinanzi agli stranieri; ed io sono, e fui, d’accordo con lui. Né egli, o nessuno de’ suoi francesi, ebbe mai di questi scrupoli, di questi riguardi ai vizi nazionali. Anzi, non è gente che li conceda, che li cerchi, che li sveli[167] piú arditamente. Epperciò, dopo tante cadute, da sessant’anni in qua, quella nazione ebbe altrettanti risorgimenti; non cadde per lo meno mai in niuno di que’ due avvilimenti ultimi e indivisibili, dell’incapacitá militare e della dipendenza esterna. Certo che l’Italia non avrá mai Danti, Parini od Alfieri a centinaia e migliaia; ma quando le centinaia e migliaia de’ suoi scrittori seguiranno questi uomini suoi quasi soli severi, invece di tener dietro alla turba dei nostri grandi adulatori, scusatori o copritori, allora solamente e finalmente l’Italia avrá una opinione sana e virile che la conduca a virili fatti. Quanto all’Alfieri, io so che ad una adorazione di lui, forse soverchia, succede ora in alcuni una soverchia disistima; che dopo averlo posto sopra tutti i tragici antichi o stranieri, si pone ora sotto ai greci, francesi, spagnuoli, inglesi e tedeschi. Ad ogni modo, ei fu diverso da tutti questi in molte parti; e fu grande abbastanza per fare alla poesia, a tutte le lettere italiane il solenne benefizio di ricondurle (sia pur colla durezza od anche secchezza) a qualche severitá. Ed egli poi fece a noi piemontesi il beneficio particolare di farci entrar nelle grandezze delle lettere nazionali, d’incamminar il secolo aureo di queste nostre provinciali, le quali comprendono giá, fra non pochi altri, i nomi di Botta, di Pellico, di Gioberti e d’Azeglio.—Del resto, noi avremmo potuto allungar la lista qui sopra coi nomi di parecchi poeti minori, lirici e didascalici, Manfredi, Spolverini, Bondi, Pignotti, Frugoni, Savioli, Fantoni, Mazza, e del tuo, o ottima e veramente nobile Deodata. Ma le poesie liriche, anche buone, sono forse com’acqua al mare, in Italia; e se taluno s’offendesse di tale opinione, io addurrei l’esempio d’uno de’ maggiori lirici che noi abbiamo avuto mai, il quale si contentò pure di far cinque canzoni. Se la lirica può esser utile, certo sarebbe esercitandola, come il Fantoni ed alcuni altri de’ nomati, su soggetti attuali e patrii; e ciò pure fu un progresso. E fu un altro, a parer mio, che cosí pur si scrivesse in vari dialetti nostri; dal Galiani in napoletano, dal Calvi in piemontese, dal Porta e dal Grossi in milanese, dal Meli in siciliano. Voglion altri, lo so, che sia male scrivere ne’ dialetti, quasi se ne scemino i cultori[168] e i leggitori della lingua comune; ma io crederei che l’una cosa non guasti l’altra, che tutte le colture, tutte le glorie d’italiani, s’abbiano a dir buone ed italiane. Che piú? porrò fra queste, l’avere il Goldoni scritto una bella commedia, e il Galiani un bel trattato economico, in lingua francese. Siamo compiutamente liberali una volta; non solo verso noi o chi fa come noi, ma verso chi fa diversamente e bene, in qualunque modo. Non istimiamo da noi alieno nessuno, nulla d’italiano. Certo, che questo scrivere bene in una lingua straniera è facilitá, è lode non ottenuta da niuna nazione come dagli italiani; ed è gloria che incominciando prima di Dante e Petrarca, dura e forse s’accresce a’ nostri dí.
37. Continua.—Ed ora, passando a’ prosatori, noteremo del Baretti [1716-1789], che egli pure meriterebbe lode d’acerrimo morditore de’ vizi patrii, se, dopo averli perseguitati in patria molto bene, ei non si fosse lasciato trarre a coprirli e quasi giustificarli fuori, per il solito mal inteso amor di patria, per una mal repressa ira contro a uno, fosse pure impertinente, scrittore straniero. Noi porremo poi tutti insieme gli scrittori di storia, di politica, di economia, di filosofia e di critica; perché, avendo i piú scritto dell’una e dell’altra scienza, o di generi intermediari, essi si potrebbero difficilmente distinguere. E qui pure non sará ignobile la lista dei principali che fiorirono dalla fine del secolo decimosettimo al 1814: Vico [1668-1744], Muratori [1672-1750], Scipione Maffei [1675-1755] giá nominato fra’ poeti, Giannone [1676-1748], Foscarini [1695-1762], Mazzucchelli [1707-1768], Genovesi [1712-1769], Galiani [1728-1787], Tiraboschi [1731-1794], Denina [1731-1813], Lanzi [1732-1810], Pietro Verri [1728-1797], Cesare Beccaria [1738-1794], Mario Pagano [1748-1799], Napione [1748-1830], Filangieri [1752-1788], Gioia [1767-1829], Cicognara [1767-1834], Romagnosi [1771-1835]. Dei quali è notevole un fatto in generale: che tutti seguirono i progressi fatti fuori contemporaneamente dalla scienza; seguirono, dico, i veri e buoni, lasciando (non mi s’oppongano le eccezioni, le proposizioni particolari) i falsi e cattivi. Né di ciò sia dato merito ai governi, alle censure, quasi esse fossero che abbiano[169] impedite le esagerazioni. Perciocché non pochi degli scrittori qui nominati, e molti poi de’ minori vissero fuori d’Italia, ove essi avrebber potuto, al par degli stranieri, passare ogni limite di moderazione e bontá; ondeché, se non li passarono, o li passarono di rado, ei sembra doversi conchiudere, che la natura, o meglio forse l’antichitá, della civiltá italiana, portino seco quasi uno schermo contro a quelle esagerazioni, le quali sono proprie delle colture piú nuove, e piu specialmente del secondo periodo di esse, del periodo vago di novitá. L’Italia, che era fin d’allora al suo quinto secolo di coltura, amava ciò che amano i vecchi, la ragione; e non essa nemmeno nelle pretensioni eccessive, ma nella giusta moderazione di lei. E vegga quindi ognuno, se non sarebbe stato fin dal secolo scorso piú utile ed alla italiana ed all’universale e cristiana coltura, torre od allentare almeno que’ freni, che non erano dunque necessari a moderare gli scrittori nostri, e che, scemando poi lor libero andamento, scemarono senza dubbio lor facoltá, lor potenza. E il fatto sta, che se noi rimoviamo le pretensioni nazionali e massime le provinciali e municipali, due soli grandi troveremo tra’ nominati; Vico e Muratori.—Vico ebbe destino contrario al consueto; negletto dai contemporanei ed esaltato dai posteri, ci rimane uno di que’ rari esempi che confortano le speranze, per lo piú stolte, dei cosí detti «ingegni incompresi». Vico fu incontrastabilmente un grande ingegno: fu, tra’ moderni, terzo dopo Macchiavello e Bossuet a cercar quelle leggi secondo le quali si rivolgono e s’avanzano le nazioni, a studiar quella, come che si chiami, ragione o filosofia o semplicemente scienza della storia universale. Ma Vico s’ingannò oltre ai due predecessori in fatto di storia antica, credendo trovar in essa piú simboli, piú arcani, piú profonditá che non vi sono. I fatti antichi furono piú semplici che non credette quel quasi seicentista della storia, e che non credono molti peggio di lui. E poi, non istudiando abbastanza la storia del mondo moderno e cristiano, ei non concepí l’essenzial differenza che è tra il mondo antico e questo nostro; incamminato quello nella via dell’errore e destinato quindi a progredire in essa, cioè, in somma, a peggiorare, a corrompersi[170] anche in mezzo alla civiltá ed alle colture; partito il nostro dalla veritá ed incamminato quindi in una via di virtú e di progressi indefiniti. E quindi Vico inventò, o piuttosto prese dagli antichi quella supposta idea de’ periodi d’accrescimento, colmo e decadenza delle nazioni, legge che non esiste in fatto né in ragione nel mondo cristiano. Né ebbe Vico quella bella, ma essa pure non giusta idea del progresso incominciato col mondo e continuato d’allora in poi, la quale non sorse se non dopo la morte di lui, ed al cader del secolo decimottavo. E tanto meno ebbe quella sola giusta, non inventata ma solamente risuscitata dal secolo nostro, antica quanto i santi padri e gli apostoli e il Salvatore, anzi quanto i profeti che l’annunziarono; l’idea del mondo rinnovato, ravviato, fatto progressivo veramente e solamente da lui. Il tornare dall’ultima, anzi dalla penultima di queste idee, al divagar di Vico o degli antichi, è un tornar addietro nella scienza nostra indubitabilmente. Sappiamo venerare i grandi de’ secoli passati; ma imitiamoli nel non rinnegare i progressi veri del nostro.—Del Muratori poi crediamo che non si possa mai abbastanza né onorar la memoria, né proporre ai posteri l’esempio. Buono ed operoso ecclesiastico, e paroco, e bibliotecario, fece numerosi lavori di teologia, di morale e di critica: ma furono un nulla rimpetto a quelli di storia d’Italia. Egli solo fece piú per questa, che non per l’altre qualunque societá letteraria, qualunque congregazione di monaci studiosi. Adempiè a tutti e tre gli uffici che avanzano la storia d’una nazione; fu gran raccoglitore di monumenti nell’opera Rerum italicarum; fu gran rischiaratore dei punti storici difficili nelle Dissertazioni, distese in latino ad uso dei piú studiosi, abbreviate in italiano ad uso de’ piú volgari; e negli Annali fu scrittore del piú gran corpo che abbiamo di nostra storia, scrittore sempre coscienzioso, non mai esagerato in niuna opinione, non mai servile, sovente ardito e forte, e talora elegante ed anche grande. Quindi i lavori di lui diedero spinta, agio, possibilitá ed a pubblicazioni ulteriori di documenti, ed a storie speciali delle lettere, delle arti, de’ commerci, e ad altre particolari di province e cittá; e cosí ai lavori del Tiraboschi e del Lanzi giá detti, ed a quelli di Lupi, Fantuzzi, Marini,[171] Affò, Giulini, Rovelli, Carli, Savioli, Pignotti, Marin, Diedo, Filiasi, e non pochi altri. Ma tutti questi non arrivarono di gran lunga al Muratori; a pochi grandi toccò come a lui la infelice gloria d’aver seguaci numerosissimi, ma tutti minori. Fra i tanti vanti di che siam larghi a noi stessi, noi ci diam veramente pur questo d’aver una letteratura storica superiore a tutte l’altre moderne; ma lasciati i cinquecentisti, che sono grandi per cinquecentisti, la veritá è, che dal Muratori in poi, che nel secolo in cui ciascuna delle altre nazioni si procacciò non una, ma parecchie grandi storie patrie nazionali, niuna tale fu fatta d’Italia, da niuno scrittore italiano. Eppure questa opera d’una storia nazionale è forse, è certamente l’opera letteraria piú necessaria di tutte a qualunque nazione; quella, la cui mancanza si fa sentir piú ed in tutte le colture, e nella politica pratica di qualunque nazione; quella, che sola può dar color nazionale, aiuti, soggetti innumerevoli ed opportuni a tutte le composizioni letterarie ed artistiche; quella, che sola può dar esempi, consigli, opportunitá e forza agli uomini politici. Come si fa che ad essa non siasi rivolto ancora efficacemente l’ingegno pur cosí vario degli italiani? Certo per due difficoltá, una intrinseca, ed una estrinseca: prima la difficoltá intrinseca di questa storia cosí varia, cosí moltiplice, cosí piena di fatti diversi di luogo, e concorrenti nel tempo, che sará forse sempre impossibile renderne facile epperciò piacevole la lettura. Ma insomma, se non è superabile del tutto questa difficoltá intrinseca, ella è fino a tal punto certamente che si possa fare una storia se non piacevole, almeno utile; e il fatto sta che tra il secolo scorso e il presente, fino al 1814 (senza venir piú giù), due stranieri intrapresero di darci di que’ corpi di storia che non imprendemmo noi, il Lebret e il Sismondi; e l’intrapresero, perché non avevano quella difficoltá estrinseca, che fu per noi la maggiore senza paragone. Le censure comprimono tutte le parti della letteratura, ma nessuna come la storia di gran lunga; perché le altre parti si possono adattare a trattar dell’una invece dell’altra veritá, della veritá non compiuta; ma la storia senza veritá compiuta non è solamente incompiuta ma falsa, non è piú storia; e quando è ridotta[172] a tale, non si tratta piú da niun amator vero della veritá, da niun ingegno virtuoso e grande; e si tratta allora o dai nazionali mediocri per natura, o dagli stranieri quasi sempre mediocri per difetto o d’informazioni o d’intelligenza delle cose nostre. E qual danno sia stato questo poi per li popoli, e piú specialmente per li principi (forse piú particolarmente per quello che è principe politico insieme ed ecclesiastico), per tutti i governanti che hanno piú interesse che le cose patrie sien trattate dagli ingegni alti e per conseguenza moderati, io non ho luogo a discorrerne qui, e diventa, del resto, men necessario, ora che è cessato tal danno intieramente, in una parte almeno d’Italia. Troppo forse ho giá indugiato qui, ma spero non esser paruto scostarmi dall’assunto mio, né lodando nell’infimo dei lavori sulla storia d’Italia il piú gran cultore di essa, né chiamando sulle deficienze di essa l’attenzione de’ miei leggitori.—Del resto, molto sarebbe ad aggiungere, e su quel grande ma per gioventú ancora incompiuto ingegno del Filangieri; e sulla pochezza degli altri nostri scrittori politici di questo secolo, che fu pure altrove cosí ricco di essi; e sui nostri economisti numerosi, buoni in generale, e applicatori della scienza alle cose patrie; cosí i governi avessero seguiti alla pratica piú abbondantemente i loro cenni! E sarebbero a notar pure i nostri filologi, ellenisti ed orientalisti, e i nostri teologi: ma ci stringe il termine del nostro scritto.—E cosí stringeremo in poche parole ciò che ci resta a dire delle scienze naturali o materiali. Queste furono la gloria massima del secolo decimottavo, furon quelle che progredirono piú incontrastabilmente allora. E giá parecchie volte osservammo che elle son quelle che dipendon meno dalle buone condizioni politiche; tantoché nel Seicento stesso furono possibili in Italia un Galileo e i suoi seguaci. I quali si moltiplicarono e progredirono poi nel Settecento fino al 1814. Furonvi principali: Eustachio Manfredi nomato sopra fra i poeti [1674-1738], Morgagni [1682-1771], Francesco Maria Zanotti [1692-1777], Giovan Battista Beccaria [1716-1781], Spallanzani [1729-1799], Lagrangia [1736-1813], Galvani [1737-1798], Volta [1745-1826], Mascheroni [1750-1808], Mascagni [1752-1815], oltre una turba di minori. Fra’ quali tutti torreggiano,[173] come ognun sa, Lagrangia e Volta. Il primo, compaesano e contemporaneo d’Alfieri, introdusse il Piemonte alle glorie scientifiche italiane, non meno che Alfieri alle letterarie. Ma è da notare che l’uno e l’altro lasciarono la terra paterna, e la rinnegarono poi in tutto il resto di lor vita. E cosí piú o meno Denina, Baretti, Bodoni ed altri; tantoché niuna provincia italiana diede tanti migrati come questa; tanto che ei convien dire che, ferace d’ingegni, ella non fosse apparecchiata per anco al loro svolgimento. Ed era, del resto, naturale; quando si dirozza alle colture una terra nuova, vi abbondano quelle invidiuzze, que’ timorucci, quelle ostilitá di piccoli contro grandi che si trovano ritratte al vivo da Alfieri nella sua Vita. All’incontro di Lagrangia, Volta dimorò quasi costantemente in Lombardia sua patria, e visse onorato nell’universitá di Pavia. La quale e quella di Torino, ed altre dell’antiche italiane, fiorirono piú che mai nel secolo decimottavo, fino al 1814, e furono i migliori centri di tutte le colture italiane. E cosí è naturale, per vero dire: dove non sono centri di operositá politica, le colture non possono rifuggir meglio che a questi che son centri almeno dell’operositá d’insegnamento. Qualche viva operositá si vuole a tener vive le colture.
38. Continua.—Giá il notammo: uno de’ privilegi piú indubitabili degli uomini meridionali è la disposizione naturale alle arti belle, a quelle principalmente pel disegno. Grecia e Italia produssero, tra esse due, piú cose belle che non tutto il resto del mondo; e dopo esse è terza Spagna. Quindi noi, che crediamo possa e debba l’Italia prender molto e delle lettere e delle scienze straniere, pur notammo che in fatto d’arti ella non ha a prender quasi nulla; e che, quando prende, ella prende male, quasi contra natura. Ciò si conferma nella storia del nostro secolo decimottavo. Al principio di esso continuarono l’arti nostre a decader cosí, che appena vi si possono nominare un Solimene [1657-1747], un Crespi [1665-1747], Zuccarelli [1702-1788], Battoni [1708-1787], fra’ pittori; Collino [1724-1793], fra gli scultori; Benedetto Alfieri [1700-1767], Vanvitelli [1700-1773], Temanza [1705-1789] fra gli architetti.—Intanto incominciavano a sorgere in Inghilterra, e risorgevano in Francia e Germania, alcuni[174] artisti migliori, Reynolds, Hogard, Mengs, Angelica Kauffmann, Vien, e David finalmente; e continuavano i piú di questi a pur accorrere a Italia, a Roma. Allora per la prima volta i nostri imitarono gli stranieri, e sorsero cosí Landi [1756-1830], Appiani [1761-1817], Bassi [1776-1815], Benvenuti e Camuccini, ed alcuni altri pittori. Ma questi imitatori dei nostri imitatori, prendendo forse piú de’ loro vizi che di lor qualitá, mostrarono col fatto quanto poco buona sia tal via, quanto migliore sarebbe stato risalire direttamente agli antichi e larghi stili italiani. Tutto diverso, piú originale, piú italiano, piú grande fu senza dubbio Canova; e se anch’egli non andò libero d’ogni grettezza o secchezza allor corrente, se dopo lui s’aggrandí forse lo stile della scultura, e s’accostò a que’ monumenti del Partenone ateniese ch’ei non conobbe se non negli ultimi anni; io crederei che sia appunto al presente una soverchia preoccupazione di tale stile quasi unico, e che si tenga quindi da alcuni in troppo poco conto il Canova. Ad ogni modo, ei regnò solo nella scoltura, e sommo nelle arti italiane al tempo suo [1747-1822]. Nell’architettura, tra il fine dell’un secolo e il principio dell’altro non sorser guari, oltre al Cagnola [1762-1833], grandi artisti; e per la buona ragione che, tranne l’arco di trionfo di Milano, non furono fatti grandi monumenti; e ciò per l’altra buona ragione che l’Italia sconvolta non aveva agio né danari a ciò. L’architettura è, di tutte l’arti, anzi di tutte le colture, quella che ha piú bisogno di protezione pecuniaria.—Questo poi fu il secolo aureo della musica; fiorirono tra non pochi altri Porpora [1685-1767], Marcello [1686-1739], Tartini [1692-1770], Durante [1693-1755], Leo [1694-1744], Galuppi [1703-1785], Pergolese [1704-1737], Guglielmi [1727-1804], Sacchini [1735-1786], Paesiello [1741-1816], Zingarelli [1752-1837], Cimarosa [1754-1801], Paër [1771-1834]; famosi nomi, superati tuttavia da quelli posteriori di Rossini e Bellini; stupenda lista della piú piccola fra le grandezze nazionali. Ma cosí va il mondo: si producono gli uomini come le merci, in proporzione della richiesta, del bisogno, del mercato. Finché la richiesta fu di musica, e il piú bel giorno d’ogni città d’Italia era la prima[175] sera dell’opera, noi avemmo maestri; quando invece dell’opera, o piuttosto del cicalio e del beato ozio de’ palchi, noi ci compiaceremo di conversazioni socievoli, eleganti, avremo pur queste: ed ora che l’iniziata libertá italiana avrá bisogno d’uomini politici e guerrieri, ella li riavrá certamente. Il suolo d’Italia è incessantemente ferace sempre e dove non si tema la sua feconditá. A voi, giovani, l’augurio: noi fummo ciò che potemmo a’ tempi nostri. Il suol d’Italia fu e può tornar fecondo a tutto; quando si volesse, o sol che non si temesse, la sua feconditá.
39. Le sette etá di nostra storia.—La storia da noi percorsa rapidamente, e quasi «con lena affannata», è la piú lunga e la piú ricca di grandi e vari esempi, che sia di niuna nazione al mondo. Sono intorno a tremila anni di fatti narrabili. Divisili in sette grandi etá, noi vedemmo nella prima gli stanziamenti primari de’ tirreni, degli iberici e degli umbri, e la prima invasione de’ pelasgi; e sollevarsi poi in una bella guerra d’indipendenza que’ popoli antichi, gl’itali ed etruschi principalmente; e ricacciati al mare que’ primi intrusi, sorgerne il nome patrio d’Italia, e l’imperio degli etruschi, imperio potente, famoso a’ suoi tempi, e oscurato per noi solamente dall’estrema antichitá. E succedute primamente l’immigrazione lenta, quasi pacifica, ed incivilitrice degli elleni nel mezzodí, poi quella ultima tutto diversa de’ galli a settentrione; con questa terminammo la lunga e primitiva.—Quindi vedemmo incominciar la seconda col generoso accorrere alla riscossa contro ai galli della picciolissima Roma; la quale in ciò appunto si fece grande, ponendosi capo a quel sentimento di nazionalitá che è di tutti i tempi, antichi come nuovi, rozzi come civili. E non prima, ma allora si ci parve attribuir a Roma il pensiero di cacciar lo straniero dalla penisola, o di farvisi signora essa, che a que’ tempi era lo stesso. Ed ella compiè tal disegno in quattro secoli; e compiè intanto, insieme, quasi per aggiunta, quello di farsi signora del mondo d’allora, di tutte le nazioni all’intorno del Mediterraneo, e del Mediterraneo stesso, diventato lago italiano. Questa fu la magnifica ricompensa del suo spirito di nazionalitá; questa, dico,[176] se il nostro pensiero ci trattiene in terra, si leva a poco volo. Che se noi sappiamo abbandonarci a quelle considerazioni soprannaturali, le quali innalzano il pensiero quasi tra terra e cielo, noi veggiamo aver avuto que’ nostri padri una maggior ricompensa, un magnifico destino: quello d’apparecchiare il primo campo della cristianitá. Ma in ciò fare, Roma erasi fatta troppo grande per durar repubblica; anche a’ nostri dí, ed inventata la rappresentanza de’ lontani ne’ grandi Consigli nazionali, sarebbe forse impossibile il governo repubblicano a un cosí vasto imperio; ma impossibile era certamente a que’ tempi, quando la partecipazione ai governi, ai Consigli, la libertá politica, la libertá compiuta non s’estese mai oltre alle mura o al territorio d’una cittá; impossibile era che la cittá signora di tanto mondo non s’arricchisse sterminatamente e cosí non si corrompesse, non s’arricchisse inegualissimamente e cosí non si dividesse all’interno suo; ed impossibile poi che dividendosi, e parteggiandone, e combattendone, non vincesse alla lunga la parte dei piú contro ai pochi, e non sorgesse all’ultimo uno solo sopra a’ piú, un principe sul popolo, come quasi sempre succede. E allora si compiè la rivoluzione della repubblica in imperio.—Viene dunque la etá terza, o di questo imperio; e con poco diletto nella storia, poco utile negli insegnamenti, essendo essa d’una cosí sfacciata tirannia, d’una cosí sfacciata servitú, che non può rinnovarsi nella cristianitá; non pericoli, non accrescimenti all’infuori, non divisioni, non parti, non vita addentro, non operositá fuori né dentro, salvo che di lettere al principio, ma per poco; finché tutto fu ozio e vizi e corruzione, finché il popolo romano, che aveva vinte nazioni su nazioni incivilite, prodi e grandi, non fu piú pari a difendersi contro alle genti sparse e barbare che l’assalirono, l’invasero, lo distrussero. Una consolazione, una bellezza sola ma suprema sorge in tutta questa etá: il sorgere dapprima oscuro, poi a un tratto splendidissimo della cristianitá; la cristianitá sollevantesi tra le rovine dell’imperio, ed ivi aspettante i barbari.—S’empie quindi tutta di questi barbari la quarta etá. E di nuovo, nulla quasi di bello; salvo forse Teoderico gran re d’Italia e d’altre province[177] all’intorno, che parea dover essere gran fondatore d’una nuova nazione italiana, come furono le contemporanee francese, spagnuola ed inglese; che non fu se non d’un regno di pochi anni, grazie all’inquieto desiderio dell’imperio e del nome di Roma che s’apprese agli italiani, che fece chiamare i greci, cadere i goti, e sottentrare in un dieci anni i longobardi. Seguono dugent’anni di questi, incapaci di conquistare tutta Italia, incominciatori del dividersi di essa fino a noi, fino ad ogni avvenire prevedibile; incapaci di governar le province occupate, di serbarle, contro ai papi capipopolo di Roma, ed ai loro patrizi ed amici, i Carolingi di Francia. Poco rincrescimento rimane della caduta di que’ longobardi, che, mischiati poscia con noi nella sventura comune, lasciaron il sangue piú abbondante che sia forse in nostre schiatte.—Segue la quinta etá, di Carlomagno e dei suoi discendenti e successori, imperatori e re stranieri; imperatori, per lo stolto piacer presoci di gridare un imperator romano; re, per quelle invidie che ci fecero sempre parlare, piangere, adirarci contro agli stranieri, ma in fatto anteporli a’ nazionali; quelle invidie di sotto in su, e di sopra in giú che diedero l’Italia a quell’Ottone pur troppo grande, dal quale in poi, salvo le due brevi eccezioni d’Arduino e di Napoleone, sempre rimase tedesca la corona veramente ferrea d’Italia o di Lombardia. E naturalmente, questa fu la peggiore, l’infima, la piú corrotta delle nostre etá; corrotti principi e signori, uomini e donne, sacerdoti e vescovi e papi, tutto l’ordine feodale secolare, e quasi tutto l’ecclesiastico sottopostosi simoniacamente a quella feodalitá; sorgente sí il popolo, che deve quindi credersi men corrotto; sorgenti qua e lá alcuni monaci studiosi, zelanti, riformatori, riformati, e fra e sopra essi Ildebrando, Gregorio VII.—E quindi, da questo pontefice, non incolpevol forse, ma gran riformatore, gran santo, grand’uomo politico, gran rivendicator d’indipendenza ecclesiastica, grande aiutator d’indipendenza politica, e, senza saperlo, forse di libertá, noi incominciammo l’etá sesta, la maggiore delle nostre moderne, l’etá de’ nostri comuni, di quel nostro secondo primato che fu piú veramente di colture che di civiltá; e cosí facemmo[178] deliberatamente, risolutamente, a malgrado gli odii giá vivissimi, or morenti contro a quel grande; vivissimi al tempo che non si perdonava nemmeno a un papa d’aver mancato di rispetto alle potenze temporali, e massime all’imperiale; morenti, dacché s’apprezzano tutti i rivendicatori di tutte le libertá. E continua quindi questa etá nostra, forte, crescente, splendida, magnifica in tutto, in difesa d’indipendenza, in progressi di libertá, in progressi di tutte le colture, tutti i commerci, tutte le operositá, tutte forse le virtú pubbliche, salvo una; salvo quella vera, somma ed ultima liberalitá che consiste in vincer le invidie, dico anche l’invidie derivanti dalle condizioni speciali di ciascuna etá. Nell’etá precedente, de’ grandi, i grandi italiani s’eran invidiati tra sé, ed avean data la patria ai grandi stranieri; in questa, nell’etá dei comuni, delle cittá, del popolo, s’invidiarono cittá contro a cittá, cittadini contro a cittadini, piccoli contro a grandi, grandi contro a piccoli, piccoli rimasti soli tra sé; e cosí distratti da quella che è la piú inquieta e la piú perseverante, la piú meschina e la piú tiranna, la piú operosa e la meno operante delle passioni, non rimase tempo a que’ miseri, non mente libera al pensiero, non cuore al sentimento dell’indipendenza; non si compiè l’acquisto di questa quando s’ebber l’armi in mano a propugnarla, non si mirò ad essa nelle paci, non si riprese quella rivendicazione mai piú; s’attese a tutto, fuorché al piú necessario, fuorché a ciò che fa una nazione; e cosí poi, meritatamente, sì riperdette quella libertá interna a cui s’era sacrificata l’esterna: si riperdettero quelle tirannie aristocratiche, democratiche, a cui s’era sacrificata la vera, equilibrata e non invida libertá, si riperdette ogni buona operositá militare o politica; e s’apparecchiò la nazione a qualunque signoria o preponderanza straniera fosse per venire.—Venne Carlo VIII, da cui dunque incominciammo l’etá settima ed ultima, e che dura, delle preponderanze straniere; ma non istette. Venne Luigi XII, e non istette nemmeno. Ma venne insieme Ferdinando il cattolico, e stette in Napoli e Sicilia, e tramandolle a Carlo V imperatore; il quale, come tale, diede a se stesso il ducato di Milano, e cosí tenne Italia dal collo e dal piè, e[179] tramandolla a’ suoi discendenti di Spagna, coi Paesi bassi, con America, colle Flippine, colonia anch’essa da farne pro per la madre patria. Ma, immenso esempio, non fece pro di noi, piú che di quell’altre superfetazioni, la madre patria; languí anzi e decadde tra esse. Non fecene pro nemmen quella casa regia, che degenerò e cadde; non ne fu fatto pro se non da pochi viceré, governatori ed impiegati minori. E cosí tra tutto quel languire, languimmo noi pure, Italia quasi tutta, salvo talora Piemonte, per li centoquarant’anni del Seicento, in nullitá politiche, in corruzione di costumi, in cattivi gusti di lettere e d’arti, in ogni cosa, salvo che in filosofia materiale sollevata da Galileo, martire di essa. Finí poi quel marciume colla fine della marcia schiatta regia austro-spagnuola all’anno limitrofo tra i due secoli decimosettimo e decimottavo; e si sollevò questo per le guerre, che si fecero forti e grosse ne’ dodici anni della contesa della successione di Spagna; per li trattati di Utrecht, che fondarono un secondo regno italiano a casa Savoia ingrandita; e piú per quella guerra della successione di Polonia e quel trattato di Vienna, che liberaron da Austria e rifecero indipendente l’antico regno di Napoli e Sicilia, non lasciando allo straniero che Milano e poca Lombardia all’intorno. Ed allor tentò, allora incominciò a risorgere Italia; e si riformò, migliorò, progredí incontrastabilmente, benché non abbastanza pur troppo; non nell’essenza dei principati italiani, che rinnovaron tutto salvo se stessi; non nell’indipendenza, che rimase incompiuta. E cosí, mal apparecchiata all’impreveduta occasione dell’invasione francese (come giá a quella di Carlo VIII, di Carlo d’Angiò, di Federigo I e tante altre), si trovò la lenta Italia del 1792. E come disapparecchiata, lasciò i piemontesi combattere e succombere soli nel 1796, e si divise in parti di regii e repubblicani, di francesi ed austriaci per diciott’anni; lungo i quali caddero le ultime repubbliche del medio evo, caddero, si restaurarono, ricaddero e si restauraron di nuovo i principati; e si finí collo stabilimento raddoppiato, contiguo, piú sodo, piú forte che mai, almeno in apparenza, del regno lombardo-veneto, dal Ticino all’Adriatico. Né sia per nulla, poi, che[180] abbiamo cosí ristretto a poche pagine questo giá tanto, e forse troppo, breve sommario de’ fatti nostri. Sappiamo restringerli anche piú nella mente nostra, sappiamo veder d’uno sguardo le nostre sette etá, e discernere fra esse tre belle, grandi, gloriose e virtuose, quelle dei tirreni ed altri popoli primitivi, della repubblica romana e dei comuni; ed all’incontro, quattro brutte, dappoco, corrotte e miserande d’ogni maniera, quelle dell’imperio romano, de’ barbari, degli imperatori e re stranieri, e, quantunque meno, essa pure quella delle preponderanze straniere. È ella caso tal differenza? ovvero, ha ella cause moltiplici nelle diverse etá? ovvero, forse una sola costante e comune?—Io vorrei non dirlo; i leggitori saranno stanchi oramai di udirmi pronunciare in poche parole delle maggiori questioni nazionali; e piú stanchi forse di udirmele risolvere poco men che tutte in una sola conchiusione. Ma non è colpa di mia volontá; sará forse del mio intelletto, se, quanto piú vario o combino aspetti de’ fatti nostri, piú mi si riaffaccia quella conchiusione stessa. E riaccolte qui in un pensiero le diverse etá di nostra storia, io non so non vedere nelle tre grandi un medesimo fatto, nelle quattro dappoco un medesimo difetto: il fatto o il difetto della indipendenza rivendicata. E lascio trarre le conseguenze storiche od anche pratiche a ciascuno.—E trentadue anni noi vivemmo d’allora in poi, il tempo appunto che nelle storie si suol chiamar d’una generazione. E questo è indubitabilmente principio d’un quarto periodo di quella lunga etá delle preponderanze straniere. Ma appunto, una generazione non basta a nominare, a qualificare un secolo, un periodo di storia; nome e qualitá dipenderanno dalle due o tre generazioni che seguiranno, forse da una, forse da questa che vien su dopo noi. Ad ogni modo, una distinzione parmi potersi far giá in questi pochi anni, una quasi suddivisione di capitoli della storia futura: noi avemmo un tempo di errori universali, incontrastabili; ma mi par sorgere un tempo di ricominciati progressi. Da principio, i principi italiani restaurati, chi piú chi meno, restaurarono i governi antichi, quali ei li avean lasciati un quindici o sedici anni addietro: non[181] tenner conto né de’ fatti intermedi, né degli uomini, né degli interessi, né delle opinioni nuove; e fu errore incommensurabile, riconosciuto ora da tutti, salvo forse pochi sopraviventi a difendere ciò che fecero. E allora si sollevarono l’opinione, gl’interessi popolari nazionali, contro a’ principi. E fu naturale, fu giusto senza dubbio, ma fu infelicissimo, fu fatale questo alienarsi di principi e popoli italiani tra sé; e fu piú fatale quando scoppiò in congiure, che son sempre fatti immorali e pervertitori; fatalissimo quando in sollevazioni, che son fatti impotenti contro a governi forti, imprudenti contro a’ titubanti che fanno titubar tanto piú; impotentissimi e imprudentissimi in faccia a uno straniero piú interessato di gran lunga a comprimerle, che non gli stessi principi nazionali; posciaché questi, in somma, resterebber principi, e forse piú forti principi colle libertá cosí domandate, mentre i dominatori stranieri san bene di non poter rimanere dominatori nostri cosí. Questo, dico, fu un primo tempo d’errori vicendevoli di principi contro a popoli, di popoli contro a principi; tempo fatalissimo di divisioni, piú o meno simili alle consuete, vecchie, antiche ed antichissime.—Ma da alcuni anni (e s’io m’ingannassi ei sarebbe non solamente con sinceritá, ma a malgrado lo studio piú grave ond’io sia capace), da alcuni anni sembrano indubitabili due progressi: quello dei principi e governanti che vanno lentamente migliorando, secondo le opinioni de’ popoli, i loro governi; quello de’ governati che vanno lentamente smettendo le congiure e le sollevazioni contro ai principi. Noi progrediamo da una parte e dall’altra, non parmi dubbio; ma noi progrediamo da una parte e dall’altra molto, troppo lenti, non parmi dubbio nemmeno. Ciascuna delle due parti vede, dice questa lentezza dell’altra: io la dico di tutte e due; questa diversitá è tra me e l’una o l’altra parte. Ognuna vuole che incominci l’altra ad accelerare il buon moto. Ché non incomincia, come certo il può, ciascuna da sé? Sembra agli uni aver tempo libero a’ miglioramenti, agli allargamenti governativi, ad acquistarsi l’opinione universale; sembra agli altri aver tempo libero a fare e finire congiure e rivoluzioni. Ma rimarrá egli libero tal tempo?[182] Questa è la questione, e tutta la questione d’oggidí. Non pochi eventi sopravvenner giá nei trentadue anni corsi, che avrebbon potuto esser utili, che furono inutili a noi disgiunti e disapparecchiati. Altri ne sorgeranno indubitatamente prima che si compia questo operosissimo fra’ secoli cristiani. L’Europa è ordinata, è vero, ad occidente; ma è ella ad oriente? Non s’ordinerà ella pure lá in qualche modo? cadendo turchi, o sorgendo slavi, o sfasciandosi questo o quell’imperio? ché poco importa, insomma, se sappiamo apparecchiarci, cioè se sappiamo unirci.—E finalmente, se qui pure ci rivolgiamo dai fatti agli scritti, alle colture, di queste pure noi osserveremo due tempi molto diversi negli ultimi trentadue anni. Un primo di compressione, maggiore forse che non sia stata mai, per parte de’ governi; e quindi un tempo di nullità quasi universale negli scrittori, salvo pochi che scrissero allora con incomparabile, due con immortal mestizia. Ed un periodo secondo, in che dai nostri compatrioti fuor d’Italia ci vennero dapprima parole esagerate e furenti, ma a poco a poco parole forti di moderazione e sapienza; e in che poi i nostri principi incominciarono a tollerar piú o meno che cosí pur si tentasse scrivere dentro Italia.—Sappiamo riconoscere il bene anche troppo lento, se vogliamo accelerarlo; sappiamo benedirne chi ce ne dà, se vogliamo averne piú; sappiamo ringraziarne Dio, di cui non parmi invocar invano il nome qui; sappiamo, come italiani e come cristiani, pregar Lui che ha in mano gli animi italiani di unirli ad acquistare i destini ch’Ei ci apparecchia; e sappiamo, come giá i maggiori nostri di Legnano, risollevarci dopo la preghiera, ad operar per la patria fino alla morte, ciascuno secondo tutte le proprie facoltà. Che se fu in niun secolo mai, certo è evidente nel nostro, Dio suol proteggere coloro che operano cosí.
────────
APPENDICE
(anni 1814-1818)
40. Il periodo quarto dell’etá settima, o della preponderanza austriaca [1814-1848].—Io dissi giá le ragioni che mi facevano nel 1846 terminare questo ristretto all’anno 1814. Ora poi, passati questi anni in che avemmo tutti la parte nostra di opera e di dolori, ed accresciuto sì naturalmente il numero degli uomini «a me non ignoti né per benefizio né per ingiuria» (prefazione all’edizione terza, 1846), sarebbe piú ripugnante che mai alla mia coscienza storica giudicar di essi con questi modi brevi, epperciò assoluti, che non sono né convenienti verso amici od avversari, né giusti poi verso coloro, vivi o morti, di che non sia fatto ancora il giudizio in altre storie piú distese, piú entranti nei particolari di ciascuno. Né, quando io potessi vincere tal ripugnanza, mi sarebbe nemmeno materialmente possibile il tesser qui una narrazione seguita degli anni corsi dal 1814 in poi, finché non sarà preceduta qualche storia piú distesa di essi. Chiunque abbia mai messo mano a storie, contemporanee o no, ma non iscritte da altri, sa quanti documenti sparsi, quante letture diverse sieno indispensabili alla loro composizione. E (mi si faccia lecito accennare ad un particolare a me personale, il quale, del resto, può scusare il presente volume d’altri difetti lasciativi) la luce degli occhi mi si è scemata poc’anzi a segno, da farmi materialmente difficile lo scrivere, poco men che impossibile il leggere. E trovai impossibile finora il supplirvi sempre coll’aiuto d’altri, quantunque benevoli.
Servano questi cenni a farmi scusare da coloro che mi espressero il desiderio di veder prolungato di questi trentacinque[185] anni il presente volume; e vogliano essi contentarsi delle poche parole generali, con che estendendo i cenni preventivamente dati nel 1846, tento ora collegare la nostra storia passata con quella contemporanea e futura.
I trentaquattro anni dal 1814 al 1848 furono all’Italia evidentemente parte della sua etá settima delle preponderanze straniere, periodo quarto, o della preponderanza austriaca indisputata. Mentre l’Europa tutt’intiera progredí (lentamente, secondo è desiderio di quella parte generosa, che appunto allora incominciò a chiamarsi «liberale», ma rapidamente, magnificamente, se si consideri l’andamento normale delle grandi rivoluzioni umane), progredí, dico, nella restaurazione continentale dei governi rappresentativi, estesisi cosí da Francia a Spagna, a Prussia e quasi tutta Germania, ed a Grecia, l’Italia rimase restaurata tutto contrariamente sotto ai governi assoluti, sotto alla preponderanza dell’Austria, capo dell’assolutismo, capo francamente professatosi della resistenza alla rivoluzione liberale europea. I principi italiani restaurati tornarono tutti con affetti, con pregiudizi di fuorusciti, cioè del tempo in che erano usciti; si riadattarono quindi volentieri a quella preponderanza austriaca, che consentiva con essi, e prometteva difenderli. Tutti restaurarono le forme antiche, assolute; il buon re piemontese peggio che gli altri. Promossero pochi progressi, o, come le chiamammo poi, poche riforme; ne effettuarono anche piú poche da principio, per tutti que’ primi vent’anni, che furono, bisogna dirlo, de’ piú oscuri o piú sciocchi vivuti mai in Italia. Alcuni uomini non mediocri furono talor chiamati al governo; ma pochi e per poco tempo; i piú, i soliti, mediocrissimi. I popoli all’incontro, i governati che avevano fatto poco o nulla sotto a Napoleone, se non lasciarsi splendidamente governare da lui, e si sarebbero adattati a lasciarsi governare da altri, per poco che si fosse fatto con qualche splendore, od onore di liberalitá, si adontarono fin dal 1814, e via via piú ad ogni anno di essere i popoli d’Europa piú male, piú oscuramente, piú illiberalmente governati, senza nulla di quella libertá e quell’indipendenza che udivano lodarsi, vantarsi, estendersi altrove. Cosí[186] fu e sará sempre, cosí si adempiono i progressi umani decretati dalla suprema provvidenza; ciò che non si pensava o pareva appena difetto ai padri, diventa bisogno ai nepoti, e cosí appunto si desiderò, s’estese la libertá, si desidera e s’estenderá l’indipendenza tra le nazioni cristiane. Ed in Italia venivano crescendo sí tali desidèri, ma confusi tra sé, indeterminatissimi ne’ mezzi di effettuarli. Confondevansi libertá ed indipendenza nell’odio ad Austria, confondevansi le varie forme di libertá ne’ desidèri indeterminati ed ignoranti delle monarchie rappresentative all’inglese, o alla francese del 1814, o alla spagnuola del 1812, o delle repubbliche a modo moderno americano, o del medio evo italiano od antico greco-romano; era un caos di brame incomposte, come succede tra ineducati ed inesperti, che non hanno a decidersi né scienza né esperienza. Ed era poi un caos anche maggiore de’ mezzi immaginati. Di resistenze, o, peggio, conquiste legali, non ci era idea; di sollevamenti popolari, molta; ma piú principalmente di congiure, il modo piú ovvio e, pur troppo, tradizionale giá in Italia; se non che, congiurare a modo del Quattrocento o Cinquecento, quando gli Stati erano piccolissimi e mal fermi, non era possibile. S’inventò, o s’era giá poc’anzi inventato, un modo nuovo, adattato al secolo; un estendimento delle congiure, proporzionato all’estendimento degli Stati e della civiltá; le sètte o societá segrete. E la terra classica delle congiure rozze, diventò classica delle perfezionate. Vennerci di fuori, per vero dire, le prime sètte del Settecento (o forse piú antiche, se si creda alle loro genealogie), i franchi-muratori, gli illuminati, e non so che altre. Poi sotto a Napoleone ed alle sue molteplici polizie (parola nuova anche questa che bisogna ora introdurre) dicesi fossero o quelle od altre sètte nel suo esercito. Ma la potenza di tutte queste, se fu, non uscí guari dall’ombra, non produsse effetti grandi alla luce del dí. Produssene sí quella detta Ingendbund, nata e cresciuta in Prussia, negli anni di sua servitú a Napoleone, dal 1808 al 1812, trionfante dopo le sventure francesi del 1812, aiutante il sollevamento e l’indipendenza di Prussia e Germania intiera nel 1813 e 14; rimasta poi lá con[187] nomi e scopi mutati e minori. E sorse, con iscopo simile, benché piú ristretto, in quei medesimi anni la setta dei carbonari, fomentata, dicesi, contro ai Napoleonidi di Napoli da’ Borboni di Sicilia. Ma se è vero tal fatto, questi non tardarono a portar la pena della pericolosa invenzione; ché restaurati nel 1815, la setta amica diventò nemica loro e degli altri principi restaurati ed assoluti, amica della parte liberale, di cui erano quasi vanguardia, o bersaglieri, sregolati, ingovernabili, cui pretendevano anzi condurre. Io non ho luogo, né notizie, né genio a dire di lor forme, lor modi, loro divisioni e suddivisioni, e mutazioni e moltiplicazioni di nomi. Questo solo noterò qui, che ho notato altrove, ed è piú importante: che queste sètte o congiure nuove, non meno che le piú antiche, si mostrarono al fatto sempre il peggior modo che possa essere ad effettuare qualunque rivoluzione; il peggiore quanto a moralitá, perché non è possibile avanzarle senza quei segretumi, quelle falsitá, quelle insidie, e quei tradimenti che sono, insomma, l’essenza delle congiure; ed il peggiore quanto ad efficacia e buona riuscita, perché appunto quella immoralitá fa sí, che molti non vedendola vi si mettono, ma vedendola se ne ritraggono, e i pochi rimastivi perdono la fiducia, e si dividono, e chi fa una cosa, chi l’altra, nulla mai di unanime o, peggio, di grande. Ancora, in questi convegni segreti, continui, e di uomini cosí diversi, naturalmente si parla molto, piú che non s’opera, e si prende il vizio del parlar senza pro; si fanno progetti fondati non sulla pratica degli affari umani, che i settari non hanno, ma sulle teorie; non sulle possibilitá, ma sulle desiderabilitá all’infinito: ondeché appena incominciata l’esecuzione, salta fuori l’impossibilitá, e tronca tutto. Insomma le congiure, quantunque progredite a sètte, rimangono il mezzo di rivoluzioni piú contrario che possa immaginarsi a tutti i mezzi della progredita civiltá; il loro segretume, alla pubblicitá; la loro relativa pochezza, all’universalitá dell’opinione pubblica; i loro disegni teorici, a quella pratica di governo che si diffonde a poco a poco nelle stesse popolazioni; ed i loro mezzi d’eseguimento, a quella moralitá, a quella mitezza, che essa pure, essa piú d’ogni cosa si diffonde naturalmente tra la cristianitá.—Ad ogni modo,[188] questo grand’errore dei liberali (ché cosi chiameremo, per abbreviare, anche le sètte delle quali se avessimo luogo noi distingueremmo i fatti ultraliberali ed anzi illiberali), quest’errore de’ governati liberali, figlio giá de’ primi errori de’ principi e de’ governanti, ne produsse altri nuovi. E primamente, che questi governanti assoluti imitarono questo stesso errore; fecero contro alle sètte liberali altre e varie sètte governative, assolutiste, e, che fu peggio, religiose: calderari, guelfi, ferdinandei, sanfedisti, e che so io; alle quali poco o molto, esplicitamente od implicitamente, in un modo o in un altro, in qualunque modo, parmi innegabile che s’aggiungessero alcune congregazioni che avrebbero dovuto rimanere religiose. E certo io credo, io son persuaso, che molti di tutti questi non vollero adoperare, non si sarebbero piegati mai ad adoprare mezzi chiaramente immorali, scelleratezze, peccati; ma, dal piú al meno, io son persuaso che molti delle sètte liberali non vi si sarebbero piegati nemmeno essi; e concedendo in ciò il vantaggio alle sètte pretendenti nome e scopo religioso, io veggo in esse per altra parte un grande svantaggio, un piú grave scandalo, quello d’avere abusato, piú che le sètte liberali (le quali ne abusaron pur esse), della mistura delle cose divine colle umane. Né bastò a’ nostri governi questo nuovo mezzo contro i liberali; usarono e portarono al sommo quel modo giá vecchio, che dicesi inventato o perfezionato da Leopoldo di Toscana, usato molto da tutti i governi rivoluzionari di che parliamo, in tutta Europa, ma forse piú che altrove in Italia, la polizia politica. Della quale non occorre dire che è chiaro come sia l’esagerazione dello stesso governo assoluto, come antipatica alla presente civiltá, come perciò vano, inutile, o nocivo mezzo di quello in questa. Insomma l’esiglio e il modo di restaurazione, e la preponderanza od anzi la prepotenza austriaca nel 1814, produssero il primo errore de’ governanti italiani del 1814, l’assolutismo retrogrado; questo produsse ne’ governati la parte liberale, e contemporaneamente l’error secondo delle sètte liberali, e queste poi furono madri, sorelle o figlie (ché non ne disputerò) delle controsette assolutiste, austriache, e pretese[189] religiose, e le polizie giunte al sommo. E cosí di sètte, controsette e polizie, e quindi di scoppi or falliti in sollevamenti di un giorno, ora riusciti a rivoluzioni di poche settimane o pochi mesi, seguite sempre di persecuzioni, purificazioni, esigli, carceri ed anche supplizi, si riempiè la storia di trenta e piú anni che seguirono il 1814; è una brutta storia segreta, sotterranea, ma pur troppo reale, e piú importante che non la pubblica e non bella nemmen essa; ed è storia quasi unica de’ primi venti, fino al 1834 o 35.
Nel 1815, fu temuto e represso uno scoppio nel Lombardo-Veneto, non saprei dire se anteriore, contemporaneo o posteriore all’impresa di Murat. Il quale minacciato dal congresso di Vienna, ed allettato dall’impresa di Napoleone, e probabilmente dalle sètte, uscí di suo regno, invase l’Italia fino al Po, si fermò ai primi incontri coll’esercito austriaco di Bianchi, retrocesse, combatté a Tolentino, fu vinto, fuggí di Napoli, tornò fra breve in Calabria con pochi, vi fu preso, giudicato e fucilato in poche ore dalla gente dei Borboni cosí restaurati.—Nello stesso anno fece miglior figura il Piemonte, che dicemmo il piú mal restaurato fra gli Stati italiani, ma dove re, popolo ed esercito fanno sempre buona figura ad ogni occasione militare. Furono i soli che prendesser parte alla guerra di tutta Europa contro a Napoleone; ebbero un bell’affaruccio a Grenoble.—Dal 1815 al 1820, nulla, nemmen riforme, impedite dalla paura delle sètte mal liberali, dall’influenza delle controsette illiberali e lor alleati.—Nel 1820, scoppiata la rivoluzione militare di Spagna, scoppiò una militare nel regno di Napoli, vi proclamò, vi stabilí in fretta la costituzione spagnuola del 1812, cioè la francese del 1791: un re senza «veto» né libertá di re né di cittadino; una sola Camera, una commissione permanente ne’ recessi di questa, una cosí detta monarchia con istituzioni repubblicane; la peggiore delle monarchie e delle repubbliche; la forma di governo rappresentativo la piú contraria a tutta la scienza rappresentativa. Sicilia volle serbare la sua costituzione all’inglese; si separò, guerreggiò, fu vinta al solito. Al principio del 1821, scoppiò una rivoluzione piemontese[190] imitatrice dell’imitazione napoletana; durò un mese: fu vinta dall’intervenzione austriaca, in poche ore; produsse la mutazione del buon re Vittorio Emmanuele I, che da un anno o piú accennava volgersi ad uomini e riforme liberali, in Carlo Felice; e intanto un esercito austriaco, attraversando tranquillamente l’Italia dal Po al Garigliano, disperdeva lá l’esercito napoletano, riconduceva il re che avea giurata e stragiurata la costituzione, ed or la spergiurava e distrusse.—Seguirono nove anni di pace e tranquillitá; cioè, supplizi alcuni, carceramenti non pochi; purificazioni, persecuzioni, esigli, moltissimi; sètte represse addentro, moltiplicate fuori; controsette, polizie trionfanti, fino al 1830. In luglio di questo, rivoluzione in Francia, cacciata dei Borboni; rivoluzione in Belgio, separazione, indipendenza di queste province, di quelle schiatte francesi, dalle tedesche d’Olanda; rivoluzione minacciata nella vecchia e sapiente ed esperta Britannia che se ne salva con una concessione della parte e aristocratica e conservativa, colla riforma parlamentare: rivoluzioni varie in Germania, ed estensione piccola della monarchia rappresentativa; rivoluzione in Polonia per l’indipendenza, ammirabilmente propugnata coll’armi da quel popolo armigero, perduta tra, e forse per le dispute di libertá. Ed in mezzo a tanto moto dí rivoluzioni, quasi tutte buone e tutte vere, che fece, che poté l’Italia? che poteron le sètte? Io non so. So che poterono piú le polizie e controsette; so che il moto italiano si ridusse a scoppi e sollevamenti piccoli qua e lá, in Romagna, nelle Marche, a Roma, quetati in parte dal principotto di Modena e dal nuovo papa Gregorio XVI, spenti da un’invasione austriaca giá terza in quelle province, e da una prima francese. Furono male spenti, è vero; il fuoco uscì dalle ceneri in fiammelle nel 1833 in Modena e Piemonte, ma, a spegnerle di nuovo e piú durevolmente, bastarono colá poca truppa austriaca, qua la polizia del paese; seguita poi l’una e l’altra di piú numerosi supplizi che non si fosser usati fin allora. E questo fu il culmine, o piuttosto il piú bassofondo di quella guerra, quella politica, quella storia sotterranea; fu l’epoca della maggior divisione tra governanti e governati italiani. Invece della quale,[191] invece di stabilirla da principio ed accrescerla sempre piú con orrori avvicendati, se avessero saputo i governanti accostarsi ai popoli con riforme liberali; ovvero i governati ai governi, per suggerire, insistere alle riforme ed aiutandovi con mettervisi essi, non è, non può rimaner dubbio che que’ venti anni sciagurati, invece di essere di peggioramento, sarebbero stati di un miglioramento, di un principio ed aiuto qualunque a ciò che seguí.
41. Continua [1833-1843].—E la maggior prova di ciò risulta appunto da quanto seguí. Il paese d’Italia piú importante senza contrasto in Italia fu fin dal 1814 il Piemonte. L’Italia non è da rimproverare di non aver ciò veduto; è piuttosto d’averlo veduto troppo, di aver fidato nel Piemonte solo, non ciascuno pure in sé; non solamente tutti i forti sperarono in lui, ma tutti i fiacchi si riposarono in lui, e quasi tutte le mene de’ cattivi si volsero a lui. L’uomo poi, fin dalla medesima epoca, piú importante in Piemonte e in Italia, fu senza contrasto Carlo Alberto. E quindi a lui piú che a nessuno mirarono, lui cercarono, circondarono, travagliarono e tormentarono variamente buoni, forti, fiacchi, cattivi, d’ogni sorta; ed aggiugnendosi alla varietà degli uomini la varietà della fortuna, n’uscí quella varia natura, che tutti seppero, molti calunniarono, pochi conobbero, e piú pochi sanno apprezzare. Il piú degli uomini perdono ad essere studiati; questi ha bisogno d’essere studiato, per essere, cosa rara, compatito insieme ed ammirato. E perciò, perché questo non può che guadagnare a ciò che se ne parli, e come centro che fu d’Italia per trentacinque anni, val la pena che se ne parli con qualche particolare, perciò mi scosto dal mio proposito, e mi vi fermo. Nato nel 1798 d’un ramo staccato da presso a duecento anni, e cosí discosto dal trono di casa Savoia, era di pochi mesi quando cadde questo trono in Piemonte; e cacciata la famiglia regia per Sardegna, suo padre e sua madre rimasero in Piemonte, privati fra que’ repubblicani. E mortogli poco appresso il padre, e passata alcuni anni appresso la madre a seconde private e feconde nozze, egli s’allevò in quella nuova famiglia, ed in parecchi convitti di giovani in Parigi, in Ginevra,[192] tra cattolici, protestanti, repubblicani, imperialisti; ed in quella condizione tra principe e privato, che è giá ambigua e difficile per sé, che gli si faceva piú ambigua d’anno in anno, non essendo nato e vivuto niun erede maschio a casa Savoia in Sardegna, e rimanendo egli cosí erede a quel regno, e pretendente agli Stati di terraferma. È noto come questa condizione di pretendente sia la piú ambigua, la piú infelice in che si possa educar un principe. Stava per uscirne ed entrar nell’esercito di Napoleone, quando questi cadde. E chiamato allora a un tratto alla reggia retrograda ed assoluta di Torino, e circondatovi insieme di vecchi assolutisti e di giovani liberali, pendé facilmente, naturalmente a questi, e per le memorie di sua educazione, e per la sua gioventù, e per il suo sangue stesso, avverso ad Austria, ed avido d’imprese, ed anche venture militari, di generazione in generazione. Nel 1820 e 1821, fu tra quelli che avrebbero aiutata la rivoluzione liberale, se si fosse fatta co’ mezzi legali, con riguardi agli obblighi suoi verso il suo re. Ebbe egli e ruppe bene o male impegni presi? non è qui il luogo di chiarirlo; né io scrivo un panegirico o una difesa. E sarebbero forse mal difendibili tutti gli atti durante o dopo la sua breve reggenza, e il suo mutar poi, o sembrar mutar opinioni e modi durante il regno di Carlo Felice. Questo dico e so, che le opinioni sue nel 1821 erano sinceramente liberali; per la libertá, senza gran cognizione e discernimento di essa; per la indipendenza, con quell’ardore, quel cuore, quella devozione di sé e de’ suoi, fin d’allora, che gli vedemmo ventisette o ventott’anni in poi. E quindi non rimane a me il menomo dubbio, che se si fosse lasciato svolgersi ed afforzarsi da sé quell’ardore, quello spirito, quell’animo primitivamente liberale, e che niuno oramai può non dire naturalmente generoso; se non si fosse alienato con disegni, che a ragione o a torto non gli parvero generosi; se fosse rimasto duranti i due regni intermediari circondato da quegli uomini liberali e generosi, che furono essi pure perduti in tutto quell’intervallo per la patria; non è dubbio, dico per me, che il suo accedere al trono nel 1831, subito dopo alle grandi rivoluzioni europee, sarebbe stato[193] principio di un regno fermamente, uniformemente liberale nel principe, e liberalmente aiutato da’ compagni ed amici di sua gioventù. Fu invece un regno di titubanze continuate fin presso al fine.—Incominciò con alcuni atti liberali, ma piccolissimi, i quali dimostrano insieme, e che il suo animo vero, i suoi disegni erano liberali, ma ch’ei dubitava, voleva tentar quella ch’ei prendeva per opinion pubblica, ed era solamente della corte, dei servitori, degli impiegati del suo predecessore. I quali naturalmente si scandalezzarono di que’ principi, vi si opposero, lo fermarono, lo determinarono ad atti opposti e via via cresciuti, fino a quelli deplorabili che accennammo della repressione, giusta in sé, ingiusta nelle forme e negli eccessi, della congiura del 1833. Si fece poi, e si fa un gran chiasso della aristocrazia piemontese, quasi che ella fosse che producesse, nutrisse e mantenesse questo pervertimento delle buone intenzioni di Carlo Alberto. Ed io non mi faccio nemmeno difensore di quella aristocrazia; ma mi par da osservare fin di qua, che quando in qualche storia distesa si verrà ai particolari ed al novero dei nomi veri aristocratici piemontesi, se ne troveranno molti piú nelle vittime del 1821, nelle opposizioni legali dal 1821 al 1848, o nella parte che aveva nome di liberale nella corte stessa, che non nella parte stazionaria, retrograda o persecutrice di questa; e che i veri persecutori poi furono di tutt’altro che di quella vera aristocrazia. Perché dar nomi falsi alle cose pur troppo vere? perché non chiamare semplicemente e veramente parte retrograda, residuo del regno precedente, effetto delle tristi persecuzioni e purificazioni del 1821, quel cumulo di governanti, che sviarono i primi anni di quel regno, il quale doveva finir poi, forse ancora il piú utile, certo il piú glorioso che sia stato mai, a casa Savoia, e, niuna classe esclusa, a tutta la nazione, a tutto il nome piemontese?
Lo dicemmo; il 1833 fu l’anno piú basso, piú oscuro di tutto questo periodo. D’allora in poi, piú o meno prontamente si risalì, si rischiarò il cielo d’Italia. Gli storici distesi accenneranno essi piú esattamente i fatti, i principi, le continuate opposizioni, le nuove titubanze, le fermate, i ritorni indietro, la[194] vittoria ultima dell’opinione liberale, progressiva, giusta, naturale al secolo, alla civiltá cristiana, ai decreti evidenti della provvidenza. Io accennerò solamente quello che mi pare primo principio, e, se non causa, occasione, mezzo usato da Dio, in tutto ciò. Carlo Alberto fu negli ultimi anni suoi sinceramente pio, intimamente, forse scrupolosamente coscienzioso. Ed io credo che la sua coscienza primieramente liberale si sollevasse contro agli stessi atti suoi del 1833, fosse l’origine di quell’austeritá de’ suoi atti, di sue parole, di tutti i suoi modi, di tutta sua vita, che incominciò appunto negli anni che seguirono l’origine del suo fermarsi nella via antiliberale, del chiamar uomini meno estremi, massimamente in fatto di persecuzioni e polizia, del suo camminar piú fermo nelle riforme. Fecene molte d’allora in poi; il suo Stato era rimasto il piú retrogrado tra gli italiani; fecene il piú progredito, il meglio ordinato. Riformò tutta la legislazione civile, e ridussela in codici; riordinò, ampliò la magistratura; ordinò le opere pie, le finanze dello Stato, che furono le piú fiorenti d’Europa; e con cura speciale l’esercito; protesse le lettere, le arti, le scienze, le societá d’agricoltura, le accademie, le universitá, i congressi. Tutto ciò indubitabilmente; tutto ciò, a parer mio, troppo lentamente, insufficientemente, come se avesse a durar sempre il regno assoluto o s’avessero secoli a far passi alla libertá. E quindi, quando venne questa, ed insieme l’occasione dell’indipendenza, il suo Stato ed egli stesso si trovarono apparecchiati all’una ed all’altra poco piú che se non si fosse fatto nulla; e tutte le riforme fatte da lui ebbero od han bisogno d’essere riformate; tutte le opere fatte con previsione, mancanti nella mira principale, non poterono durare. Insomma, il Piemonte non fu portato a segno d’entrare cosí bene come avrebbe potuto nell’occasione, non o mal preveduta, del 1848. Ma il Piemonte, ultimo degli Stati italiani dal 1814 al 1833, fu da quell’epoca all’incirca portato da Carlo Alberto a segno d’entrar prima, piú e meglio degli altri Stati italiani, quando scoppiò, quantunque mal preveduta, quell’occasione.
Negli altri Stati non si progredí parimente per due ragioni; la prima, che, qualunque sia la grandezza che la storia futura[195] compiutamente informata e scritta sará per concedere a Carlo Alberto, non è dubbio gli altri principi assoluti contemporanei suoi furono di gran lunga inferiori; e perché poi alcuni di questi altri Stati, meno male restaurati nel 1814, erano fin d’allora a quel punto di bontá a cui Carlo Alberto voleva portare e portò il Piemonte, a quel punto che è compatibile col principato assoluto. Napoli e Parma avevano conservati i codici e l’amministrazione di Napoleone con poche novazioni; avevano ordine sufficiente nelle finanze; e Napoli aveva di piú un esercito ed una marineria militare quasi fiorenti. La polizia v’era dura, intrigante, preoccupata di sètte e controsette; ma quando le prime non iscoppiavano, essa pure rimettendo de’ suoi rigori, ne pareva tollerabile. Della Toscana giá dicemmo che fin dalla seconda metá del secolo decimottavo essa era stata portata a vera perfezione di principato assoluto, e fu restaurata in essa fin dal 1814; e mantenutavi poi da due principi miti, ella sarebbe rimasto lo Stato piú avanzato, il meglio governato, in tutto, che fosse in Italia, se non fosse di quella negligenza ed anzi di quella repugnanza ad avere un esercito, di che son forse ad accusare meno i principi che i popoli, e forse i liberali, gli stessi, i migliori uomini di quell’imbelle od avara regione.—Quanto a Roma e Modena, mal restaurate nel 1814, elle rimasero peggio governate d’anno in anno in tutto questo tempo; cattiva polizia e persecuzioni furono comuni ai due Stati; speciali al pontificio i disordini di finanze, armi straniere, governo ecclesiastico nelle cose piú laicali, ed in che il sacerdozio perde piú di sua dignitá.—Finalmente, il regno lombardo-veneto, anch’esso (cioè il suo nòcciolo di Lombardia) non mal governato come parte d’imperio assoluto nel secolo scorso, non mal restaurato né mantenuto come tale, avrebbe potuto vincere al paragone di Toscana e Piemonte, se in teoria né in pratica fosse possibile far paragone tra qualunque governo anche pessimo nazionale, e qualunque anche ottimo straniero. Se io scrivessi per istranieri che hanno da secoli il sommo bene dell’indipendenza, e non conoscono per prova il sommo male della dipendenza, io accennerei almeno ad alcuni[196] particolari che dimostrano la realitá di questo sommo male, le differenze di schiatta, di lingua, di costumi, di sentimenti, d’interessi; la lontananza del centro governativo, la lentezza d’ogni decisione, i cinquanta o sessanta milioni tolti annualmente al paese, l’ozio naturalmente invadente, i vizi conseguenti, l’avvilimento universale inevitabile. Ma scrivendo ad italiani, che han provato e provano quel sommo male per sé, o nei compatrioti e vicini, ogni cenno che io ne dessi qui, sarebbe inferiore al vero che ne hanno concepito essi.—Insomma, a chi consideri ora tutta questa condizione comparata de’ diversi Stati d’Italia, è chiaro che se mai doveva venire qualche miglioramento vero, qualche impulso grande al progresso italiano, ei doveva venire dal Piemonte: gli altri Stati erano, anche in ciò che avean di meglio, stazionari; il Piemonte, anche in ciò che aveva di peggio, progrediva, aveva giá il moto ascendente; e il moto ulteriore non si poteva sperare se non dal moto. E cosí credevano, speravano allora gli italiani; tutti gli occhi eran rivolti al Piemonte, a Carlo Alberto. E le speranze comuni non furono ingannate.
Niuno di coloro che scriveranno la storia distesa, o qualsiasi compendio di questo periodo, non potranno dividere, come facemmo noi fin qui, la storia politica dalla letteraria. L’una e l’altra ebbero sí sempre molte relazioni pur troppo; ma in questi ultimi anni elle n’hanno tante, che ne rimangono continuamente frammiste.—Ne’ primi anni dopo le restaurazioni, sopravivevano (tranne Alfieri, Parini e Cesarotti) gli uomini principali delle rivoluzioni repubblicane e dell’imperio, Foscolo, Botta, Monti, Denina, Lagrangia, Volta, Canova. Ma lasciando qui le scienze e l’arti, che continuarono con isplendore, ma senza grandezze comparabili a quelle; e delle lettere stesse contentandoci a dir ciò che piú si connette colla politica, noteremo che niuno dei nominati non produsse piú nulla di gran conto, tranne il solo Botta. Il quale, all’incontro, rimasto in Francia, vi compose e pubblicò le due storie d’Italia dal 1530 al 1789, e dal 1789 al 1814, le quali sono forse non solamente le due opere sue migliori, ma i due piú lunghi e piú belli corpi[197] di storia patria che sieno stati scritti da niun italiano. Scritti, a malgrado i difetti, in istile ammirabilmente chiaro, largo, vivo, caldo e naturale, si leggono come una novella da chicchessia dotto od indotto, che è il sommo dell’arte storica. Difettano sí di scienza storica, e piú di scienza politica, a tal segno, che non solamente il vecchio liberale, anzi repubblicano, vi comparisce scrittore scettico, indifferente alle diverse forme di governo, e non persuaso se non della malvagitá degli uomini e dei tempi in generale; ma che nell’ultime pagine da lui scritte in conchiusione della storia dal 1530 al 1789, egli ci lascia quasi un progetto di governo a modo suo, che non rimane né monarchico né repubblicano, ed anche meno rappresentativo, ch’ei descrisse ma non intese né ammise. E quindi l’opere sue contribuirono a mantenere sí, e diffondere, ma non a determinare le opinioni liberali, anzi le indeterminarono e dispersero peggio che mai. Una pubblicazione mensile pubblicata per poco tempo in Milano, proibita poscia dalla polizia, ebbe, s’io non m’inganno, il medesimo vizio, il medesimo effetto. Vennero poi due scrittori, de’ quali non credo sia stato mai dacché si scrive niuno piú amabile, piú simpatico ad ogni cuor gentile, perché niuno scrisse con piú soavi tinte di gentilezza che questi due, Manzoni e Pellico, ammirabili e parchi poeti amendue, e scrittori di prosa tanto piú ammirabili, quanto piú seppero scrivere italianamente con semplicitá. Manzoni, milanese, s’illustrò con cinque canzoni, che riuscirono nuove e forse superiori a tutto, dopo il canzoniero accumulato nei sei secoli della poesia italiana; seguí con alcune tragedie storiche, o come si diceva allora, romantiche, e con alcune note ad esse ed alle storie del Sismondi; giunse al suo colmo in quel racconto de’ Promessi sposi, che fu, che diede il genere del romanzo alle lettere nostre, e lo portò d’un tratto a segno, da superar forse in fatto d’arte, e certamente in utile morale, quanti furono scritti mai in qualunque lingua antica e moderna. Pellico, piemontese, era giá amato per la Francesca, ed altre tragedie, quando, implicato nello scoppio del 1821, fu tratto allo Spielberg, vi rimase intorno a dieci anni, n’uscí poi per grazia implorata[198] dall’Italia, dall’Europa intiera, e pubblicò nel 1833 quel rendiconto delle sue prigioni, de’ suoi patimenti, che diffuse in Italia, in Europa, nel globo intiero, i particolari della tirannia austriaca, tanto piú scandalosi, quanto piú semplicemente e pazientemente descritti. Ambi questi scrittori furono accusati di rassegnazione politica; ma il fatto sta che questa era religiosa, e non entrando in quelle distinzioni tra l’una e l’altra, che sono difficili a farsi in pratica e piú difficili in teoria, lasciavan pure a ciascuno la libertá delle applicazioni; e che anzi il sentimento profondamente religioso insieme e liberale, che presedeva tutte le opere di Manzoni e di Pellico, serví anzi molto meglio che niune delle contemporanee a determinare anche politicamente il liberalismo italiano; serví anzi, riuscí a tôrlo dalle vie empie e perciò stolte ed incivili del filosofismo del secolo decimottavo, fece cattolici molti liberali, e liberali molti cattolici, accrebbe cosí e rinforzò la parte liberale, preparò la pace tra essa e la Chiesa, tra governati e governanti. Non dirò de’ contemporanei che continuarono l’opera di questi due grandi; vengo subito a chi l’accrebbe e determinò anche piú.
42. Continua. La rivoluzione delle riforme [1843-1848].—Dalla metá del 1843 corsero all’Italia quattro anni e mezzo di operositá oramai disusata, e che fu primamente non piú che letteraria, ma a poco a poco pur di pratica e di riforme politiche, rapidamente crescenti fino a quello scoppio del 1848, il quale, comunque sia per essere giudicato, fu incomparabilmente dappiú che non tutti i precedenti da trentaquattro anni, od anzi da parecchi secoli, il quale fu certamente principio o d’un nuovo periodo, o forse d’una nuova etá nella storia italiana. Parecchie delle rivoluzioni continentali moderne iniziarono dalle lettere, quella di Francia del 1789, quelle della Germania principalmente; ma nessuna forse cosí evidentemente come questa italiana. Ma se vogliamo essere compiutamente sinceri ed imparziali ne’ nostri giudizi, noi dobbiam dire che tra gli scrittori e gli operatori di politica suol essere sempre un continuo intercorso, ma di fatti crescenti a vicenda; ondeché poi chi cerca sinceramente[199] gli uomini iniziatori delle rivoluzioni, ne suol trovare due serie diverse, una di scrittori, ed una di operatori. Nel caso presente poi, le due serie sono rappresentate principalissimamente da due uomini, Carlo Alberto, di che giá dicemmo, e Vincenzo Gioberti.—Torinese questi, sacerdote, filosofo, teologo, di grande altezza, scrittore fecondo e magniloquente oltre ogni esempio italiano, fu illustre tra’ compagni ed in sua cittá fin dai banchi universatari, fu implicato nelle persecuzioni che seguirono la congiura del 1833; esigliato, incominciò a scrivere opere miste di filosofia e politica, e tendenti ad accrescere anziché guarire la divisione tra governanti e governati, tra principi e popoli italiani. Ma tra per candore e grandezza nativa, o per sinceritá o gravitá di studi, che gli fecero scorgere insieme e la nuova moderazione di Carlo Alberto, e l’util diretto che ne veniva all’Italia, e quello maggiore che ne verrebbe quando tal moderazione di principato si contraccambiasse ed accrescesse colla moderazione de’ popoli, il fatto sta che nel 1843 egli pubblicò quel libro del Primato civile e morale degli italiani, nel quale, esule generoso, egli si rivolse a lodare, a spiegare, a promuovere quella reciproca moderazione, e farne nuovo sistema di politica italiana. Gli si rivolsero contro naturalmente i piú degli esuli e perseguitati, incapaci di accedere a questa bella iniziativa di perdono, il volgo de’ liberali, le sètte principalmente invecchiate nel loro metodo di congiure e sollevamenti. Carlo Alberto all’incontro protesse il libro, lo lasciò correre ne’ suoi Stati, onde si diffuse in tutta Italia. Seguirono altri libri, altri scrittori che io mi proverei forse ad apprezzare con imparzialitá, entrando in particolari, ma che non mi sento in poche e proporzionate parole; alcuni libri di Durando, d’Azeglio, di Galeotti, e di nuovo di Gioberti e di me; oltre alcuni scritti minori di Capponi e di altri nell’Ausonio pubblicato dalla Belgioioso in Parigi. Osserverò solamente che i primi in tempo e piú fecondi di questi furono quattro piemontesi, due esuli e due tollerati in patria da Carlo Alberto, ondeché si volse a questo piú che mai ogni attenzione, ogni speranza. Le sètte erano soverchiate, respinte nell’oscuritá, fuor del moto e de’ modi presenti. Provarono due[200] imprese: a Rimini ed in Calabria; fallirono, furono seguite quella di persecuzioni ed esigli, questa di supplizi, al solito. Gioberti ed Azeglio tuonarono contro ai persecutori, compatirono ma ammonirono i perseguiti. Tutto ciò fino al principio del 1846, quando d’una contesa di dogane prese occasione Carlo Alberto d’entrare in pratica di que’ principi d’indipendenza, che lasciava oramai predicare apertamente. Austria domandava cessasse certo passaggio di sali per Piemonte a Svizzera. Non ottenuto l’intento, raddoppiò, a rappresaglia, il dazio de’ vini piemontesi in Lombardia. Carlo Alberto lasciò dapprima discutere liberamente nella Gazzetta ufficiale; poi fecevi uscire una dichiarazione governativa anche piú libera. Erano grandi novitá. Se ne commosse a festa il popolo di Torino, e fu la prima di troppe simili dimostrazioni fatte poi.—Ma come succede quando cresce un’opinione buona ed universale in una nazione, sorse fra pochi mesi una nuova e molto maggiore occasione, la morte di Gregorio XVI, l’elezione del successore. Grande l’aspettazione, divise le parti, e brevissimo tuttavia il conclave, fu eletto addí 6 giugno il cardinale Mastai, Pio IX. Dubitavasi di che parte fosse; egli lo chiarí in breve: addí 16 luglio pubblicò la piú bella, la piú larga, ed anzi la sola che meritasse il nome di «amnistia» fra le tante fatte in questo secolo, fecondo d’ogni cosa buona, cattiva e dubbia.
Da quel giorno la rivoluzione italiana, che era stata fino allora piú nelle lettere che nelle opere, uscí dalla teoria, entrò in pratica, entrò in quel secondo periodo che fu detto bene «delle riforme», e che fu pure di un’unione, un’unanimitá, un intendersi quasi tra Stato e Stato d’Italia, tra divisioni e suddivisioni della parte liberale, non escluse (almeno in apparenza) le stesse sètte, e di tutti quanti poi col compatito popolo di Lombardia e Venezia, solo in disaccordo col principe suo straniero; un periodo poi di speranze esaltate, di lodi e adulazioni reciproche, di feste avvicendate colle riforme, e cosí continue. E tutte le rivoluzioni incominciano cosí, per vero dire; e son famose, tra l’altre, le epoche di letizia e speranze del 1640 in Inghilterra, e del 1789 in Francia. Ma niuna arrivò al paro di questa[201] italiana, che durò diciotto mesi di matta letizia. Del resto, fu naturale; i miseri italiani non erano avvezzi piú oramai che a due serie d’idee e di fatti: congiure, repressioni, supplizi, esigli, e di nuovo congiure di tempo in tempo, teatri, canti, amoreggiamenti, feste ne’ tempi ordinari. E cessando i supplizi e lor paure, si precipitarono nelle feste. Accrebberle molti liberali per arte; volevano impegnar i principi, di che pur dubitavano; ed i settari ed altri repubblicani, che prevedevano non aver a rimaner contentati dalle riforme spontanee, apparecchiavano coi moti festosi quelli ostili della piazza. E questo, per certo, fu gran danno venuto da tale stoltezza delle feste, ma non il maggiore. Il quale fu, che questi miseri popoli italiani, disavvezzi, dico, da ogni civile opera politica o militare, se ne disavvezzarono sempre piú tra l’opera puerile delle feste, vi si contentarono, vi si sfogarono; non concentrarono, non risparmiarono, non serbarono all’occasione vera, seria, grave, fatale, tutti que’ pensieri, quelle passioni che non si concitano se non dopo frenate, che son necessarie a concitarsi fino all’ultima loro potenza, per produrre effetti buoni e durevoli. E gli italiani, sciupati, stemprati dalle feste, non ne seppero piú produr di tali; niuno grande, dico, pochi durevoli, molti piccoli: diversi dispersi, inutili o nocivi. Ad ogni modo, fu un vero baccanale di dimostrazioni festive nelle piazze, di festive passeggiate per le vie, banchetti in sale, banchetti all’aria, canto di giorno e di notte, dappertutto, cantate per li teatri, coccarde, nastri, bandiere, catene di pezzuole e veli femminili che si chiamavano d’«unione nazionale», o che so io; poesie, prose, vaneggiamenti, pazzie.—E ad ogni modo questo fu il séguito, la serie de’ fatti, la quale domando licenza di por qui cronologicamente, non soltanto per abbreviare a’ leggitori ed a me un’angosciosa fatica, ma perché parmi che riesca cosí piú chiaro, e quasi parlante da sé, il cenno di questi diciotto mesi, operosi se si riguardi indietro, sprecati in gran parte se si guardi innanzi, o, per parlar piú esattamente, produttori di libertá e di licenza; improduttivi di quell’indipendenza, che è anche piú da desiderarsi, dell’indipendenza che avrebbe dovuto esser la prima e la sola mira degli[202] italiani. All’8 agosto, fu fatto segretario di Stato il cardinal Gizzi, popolare allora. S’incominciò con riforme piccole; accademie, scuole e simili, e commissioni per preparar le piú grandi. All’8 settembre, nuova e gran festa popolare a Pio IX, seguita da altre piccole, ogni volta che usciva egli a visitare una chiesa, un ospedale o una villa. Intorno a’ medesimi giorni, congresso dei scienziati a Genova: era il sesto di que’ convegni annui, vera celia quanto a scienza, veri preparativi quanto a politica, e che perciò erano stati ottenuti a stento sotto ai governi assoluti. Questo fu libero oltre al solito, e naturalmente fu occasione di feste. La piú strana delle quali fu poi, senza paragone, quella pur fatta in Genova addí 5 dicembre, per il centenario del medesimo giorno dell’anno 1746, quando i genovesi cacciarono di lor cittá austriaci e piemontesi, allora male uniti. Se servisse tal festa ad unire o disunire que’ due popoli italiani, forse poteva giudicarsi fin d’allora, certo fu poi giudicato dai fatti. Ai 14 gennaio del 1847, il papa fu complimentato di tutti questi iniziamenti del suo pontificato, conformi alla civiltá universale cristiana e fino extracristiana, da un ambasciatore straordinario del sultano; il quale era stato qui preceduto da un figlio del re di Francia, e fu seguito in breve dal principe Massimiliano di Baviera, e Maria Cristina regina di Spagna, ed un ambasciatore del Chili, e congratulazioni degli Stati Uniti d’America. E dall’Irlanda si partí per Roma O’Connell; ma morí per via, e fu occasione di altre feste e discorsi funebri. E continuando intanto altre riforme piccole in Roma, seguí a’ 12 marzo la prima grande, e tanto grande che in meno di un anno riuscí compiuta la rivoluzione rappresentativa in Italia, dico la riforma della stampa. Non che le fosse conceduta la piena libertá; ma tra ciò che ne le fu conceduto e ciò ch’essa se ne prese a poco a poco in aggiunta, il fatto sta che bastò a quel gran risultato. Ma allora parve troppo poco, ed incominciarono le feste a diventar tumulti. Sorsero e moltiplicaronsi giornali in Roma e negli Stati, come poi, quando vi furono concedute le medesime libertá, in Toscana e negli Stati sardi. E come succede sempre negli Stati liberi, dove[203] la popolaritá è come il favore nelle corti assolute, ma come succede tanto piú negli Stati che sono in rivoluzione di liberarsi, perché la popolaritá vi è allora come il favore nelle corti tiranniche; chiunque corteggiava popolaritá, si pose fatalmente a spingere innanzi la rivoluzione, e pochi vollero od osarono tenerla ne’ limiti della prudenza e della moderazione, pochissimi professaron apertamente queste due ingrate virtú; e di questi, pochissimi perseverarono poi nell’impopolarissima professione.—Ai 14 aprile, seguí una riforma che parve allora e fu festeggiata come maggiore, e fu nulla; un sistema di governo che parve forse ad alcuni poter tener luogo per sempre del rappresentativo, che sarebbe certo stato bene ne tenesse luogo finché fosse finita la conquista dell’indipendenza, ma che, ad ogni modo, nol tenne nemmeno fino al principio di essa, nemmeno un anno. Questo sistema era il consultativo; cioè una Consulta (cosí si chiamò allora in Roma), o di un Consiglio di Stato, od anche di parecchi corpi di diversi nomi, i quali in qualsiasi forma consigliassero il principe nella elaborazione e pubblicazione delle leggi, senza avervi tuttavia niun voto impeditivo o realmente deliberativo. E questo sistema non era nuovo, anzi vecchio ed invecchiato sul continente, dov’era stato provato fin dal secolo decimosesto quasi dappertutto. In Italia era stato riprovato in Napoli e Torino, ma in ombra; ondeché non avea mutato il governo assoluto. Ma provato ora piú realmente in Roma (e poi in Firenze e Torino), e coll’opinione ferma in desiderare governi deliberativi e rappresentativi, ed insieme coll’altra novitá della stampa di fatto libera, egli produsse prontissimamente ciò che doveva produrre in tali condizioni, ciò ch’ei produrrá sempre piú o men prontamente, ma inevitabilmente oramai, il desiderato governo rappresentativo. Perciocché insomma, questi governi consultativi, è una forma ibrida che poté durare due secoli nella civiltá de’ secoli decimosettimo e decimottavo, e senza la libertá né la diffusione della stampa; ma che con queste, e nel nostro secolo decimonono, non avrá forse mai piú tant’anni di vita, quant’ebbe secoli; che non uscirá mai piú di questo dilemma di fatti: o rivoluzione[204] retrograda al governo assoluto, o rivoluzione progrediente al rappresentativo; e cosí sempre rivoluzioni. Ai 14 giugno, riforma minore ma piú durevole, come quella che è logica, e s’adatta ad ogni forma di governo; un primo ordinamento razionale del ministero per ordine di materie. Ai 16 giugno, anniversario dell’elezione dell’adorato Pio IX; e, naturalmente, festa maggiore. Ai 17, anniversario dell’incoronazione, e seconda festa. Parve troppo finalmente; e con bando del 22, Gizzi sgridò il popolo dolcissimamente; e il popolo se n’offese e gridò a Gizzi, quasi uno de’ retrogradi gregoriani, oscurantisti, sanfedisti, gesuiti, austro-gesuiti; nomi che incominciarono a prodigarsi da chiunque voleva andare innanzi a chiunque andava un passo meno che lui.—E sí che Gizzi e il papa andavano pure non poco, forse troppo. Al 5 luglio, istituzione della guardia civica, istituzione anche questa ottima, anzi indispensabile negli Stati rappresentativi, stolta in quelli che volevano rimanere consultativi.—Al 7, rinunzia di Gizzi; al 10, nomina di Ferretti. Addí 16, anniversario dell’amnistia, doveva esser gran festa; fu invece gran tumulto addí 14 e 15, ché sparsasi, naturalmente come succede in tali concitazioni, o ad arte come succede de’ concitatori, o l’uno e l’altro insieme, la voce d’una gran congiura retrograda, sanfedista e via via, si affiggono a’ muri i nomi de’ supposti congiurati, poi si cercano, si entra in lor case, s’arrestano, si serrano in Castel Sant’Angelo, si dá lor caccia per le campagne, e fino oltre i confini, e se n’istituisce, annuente il governo, un gran processo che non riuscí a nulla mai. Intanto, tumulti qua e lá nelle province.—E intanto (che diede ombra di veritá ai sospetti popolari), addí 17, escono gli austriaci dalla cittadella di Ferrara che occupavano dal 1814, s’acquartierano in cittá. Proteste quindi del cardinal Ciacchi governatore addí 6 agosto, e Ferretti a dí 12. Ma addí 13 gli austriaci occupano i posti militari della cittá; riprotestano Ciacchi e Ferretti, risponde il gabinetto di Vienna. Ne seguirono poi negoziati ufficiosi ed ufficiali a Roma, a Vienna ed a Milano, e finirono in dicembre colla restituzione della cittá alle truppe pontificie, con poche e piccole concessioni alle pretese dell’Austria, con[205] grande scapito di sua dignitá e tranquillitá in Italia; essendosene accesi intanto contro lei, e non domati, gli animi di tutti gl’italiani, popoli e principi, Pio IX con gli altri, e Carlo Alberto piú di nessuno. Fu minaccia senza effetto, o, ciò che equivale, fatto piccolo con grande scandalo; grand’errore.—E ne fu agevolato un affare che sarebbe stato grave, se avesse potuto durare, l’effettuazione di quella lega doganale tra gli Stati indipendenti d’Italia, la quale era stata giá piú desiderata che sperata dagli scrittori precedenti le riforme. Mandato monsignor Corboli Bussi da Roma a Firenze, Torino e Modena, se ne stipularono le basi tra le tre prime corti, addí 3 novembre in Torino; e non accedendo Modena austriaca, dichiarò pure non far ostacolo per il suo territorio di Massa, frapposto fra Piemonte e Toscana. Intanto, al 2 ottobre, ordinamento del municipio romano in forma piú liberale, e feste piú che mai in quel giorno, ed alla dimane e cinque dí appresso; e poi al ritorno del papa da sua villa di Castel Gandolfo, e per il viaggio a Porto d’Anzo e per il ritorno, e per una sua visita alla chiesa di San Carlo, e per un nuovo motuproprio sulla Consulta, e per l’installazione di lei addí 15 novembre, e per quella del municipio addí 24, e per la vittoria degli svizzeri contro il Sonderbund, addí 30. Né quest’ultima fu tutta festa: insultaronsi i gesuiti, e fu il primo di que’ tumulti che fecersi poi in tutta Italia contro a quella Compagnia, e furono seguiti dalla cacciata di lei pochi mesi appresso, quando appunto sarebbesi dovuto attendere a cacciare gli austriaci, e non a dividere italiani da italiani, preti o non preti, gesuiti o non gesuiti, scandalezzando, incominciando ad alienare Pio IX.—E finí l’anno in Roma [30 dicembre] con un nuovo e miglior ordinamento dell’ordine delle materie nel ministero. Ed io non so ciò che ne parrá ad altri; so bene che l’avere qui concentrate quelle numerose riforme, que’ grandi passi fatti in diciotto mesi, dal governo assoluto qual era stato lasciato da Gregorio XVI, a questo governo cosí largo di Pio IX, mi fa, non che ingiuste, parere ingiustissime le lagnanze allora di tanti, e duranti in alcuni ancor oggi, che egli andasse troppo lento in esse. E tanto piú, che molto piú lenti andavano gli altri principi italiani.
In Toscana, la rivoluzione delle riforme non si può dire incominciata se non un dieci in undici mesi dopo che a Roma, quando, addí 8 maggio, uscí una legge che rallentò le censure della stampa. Seguirono feste in Firenze e tutto lo Stato, insulti al console austriaco in Livorno; e poi giornali numerosi, liberi oltre la legge, liberissimi, ed alcuni licenziosi. Poi, commissioni a preparare altre riforme; e il governo consultativo che giá esisteva lá in ombra, riordinato, praticato; poi, ai 4 settembre, istituzione della guardia civica; e nuove feste, in cui apparí per la prima volta, fra altre innumerevoli, la bandiera tricolore. Intanto, feste e tumulti in Lucca; paura dei due duchi padre e figlio; e addí 1º settembre, concessione di tutto ciò che era stato conceduto in Toscana; poi fuga dei duchi, e cessione al granduca dell’usufrutto che tenevano finché morisse Maria Luisa, e lasciasse loro Parma. E cosí Lucca fu riunita a Toscana.
In Piemonte poi s’incominciò anche piú tardi; e fu fatale che quel paese e quel re, i quali avean date le prime mosse alle riforme, e dovevano poi prendere la prima e massima, e quasi sola parte all’impresa d’indipendenza, entrassero cosí ultimi in tutto ciò che ne era apparecchio. Ma il fatto sta che Carlo Alberto, vivissimo all’indipendenza, era lentissimo alla libertá, né, io credo forse e potrei dire so, per odio o vil paura ad essa, ma per nobilissima paura che questa nocesse a quell’acquisto d’indipendenza che era insomma il primo, il grande, il supremo de’ suoi pensieri. E certo, che questo spiega e le antiche e le intermediarie e le ultime azioni di lui, e le sue virtú e i suoi errori, le sue lentezze, le sue titubanze, le sue ostinazioni. Ad ogni modo, dal principio del 1846 al settembre del 1847, non s’era fatto un passo, non una riforma in Piemonte. Né una festa o un tumulto, che fu gran vantaggio a tener nuovi gli animi all’opere reali. Né a settembre stesso ed ottobre fu altro che una lettera confidenziale, ma confidenzialmente fatta pubblica, dove Carlo Alberto diceva che «se la provvidenza mandava la guerra d’indipendenza, co’ suoi figli a cavallo se ne farebbe capo». Il mondo sa come essi adempissero la parola. Ma allora non fece grand’effetto. L’opinione era alle riforme,[207] di che il re non faceva né diceva nulla. Sorsero, si rinnovarono frequenti tumulti, i piú pacifici e rispettosi siensi veduti mai. Finalmente, addí 29 ottobre, fu pubblicata una notificazione in che si promettevano tutte insieme le riforme che dovevano portare e portarono il Piemonte al paro dei due altri Stati riformati, Roma e Toscana; governo consultativo, cioè Consiglio di Stato, riordinato, corroborato di membri provinciali, nuove attribuzioni ad esso ed a’ Consigli provinciali e comunali; larghezza alla stampa che in breve ne diventò qui pure liberissima, cercatrice di popolaritá licenziosa; e guardia civica (?). E allora pur qui i tumulti piccoli diventarono feste grandi, ma cosí ordinate, che fu una meraviglia ed un’eccezione. E tutte queste promesse vennero effettuandosi poi con sinceritá e prontezza. Il re s’era deciso oramai; non die’ indietro, non titubò mai piú d’allora in poi. Ma fu certo gran danno che si fosse incominciato cosí tardi, che le riforme non avessero tempo ad effettuarsi, a preparare il paese, quando si venne ai due scoppi della libertá rappresentativa e dell’indipendenza. E fu danno maggiore, che entrando appunto nelle vie della libertá, egli si rallentasse nel pensiero dell’indipendenza a tal segno, che, anche dopo le minacce testé pronunciate, non facesse un apparecchio di guerra, non una riunione, non un collocamento militare di truppe, nulla, salvo la chiamata d’uno dei quattordici contingenti che erano a lor case. Miseria umana! negli uomini come nelle nazioni, una preoccupazione caccia l’altra. Napoleone stesso diceva non potersi fare che una cosa alla volta.
Nei due ducati di Parma e Modena, niuna riforma, pochi tumulti, sufficienti passioni. E cosí in Napoli e Sicilia: salvoché i tumulti scoppiarono in Reggio di Calabria e Messina [settembre]; ma furono repressi. Ferdinando Borbone si vantava di non aver bisogno di dar riforme; esser date da gran tempo lá: ed era vero, in ombra. Non gli venne in pensiero che si domandava e rimaneva a darsi la realitá. E cosi vantava il governo austriaco in Lombardia e Venezia; ed era vero poi, non solamente in ombra, ma in parecchie realitá. Se non che, costá il gran desiderato era di ben altro che riforme, e l’Austria nol[208] poteva effettuare. Festeggiossi, tumultuossi in Milano per l’instaurazione d’un nuovo arcivescovo [settembre], e festeggiossi e parlossi in Venezia in occasione del congresso scientifico. Ma il governo, la polizia d’Austria reprimevano ben altrimenti che quelle de’ principi italiani. La repressione piú efficace fece poi, al solito, tanto piú efficace lo scoppio.
Questa era la condizione d’Italia, questo il progresso della rivoluzione riformativa al principio del fatale anno 1848. E in men di tre mesi era compiuta la rivoluzione, era incominciata l’impresa d’indipendenza. Al 1º gennaio gran festa in Roma, non per altra occasione che del capo d’anno. Se ne spaventa la corte, apparecchia armi. Il popolo se n’offende, e la corte cede, scioglie gli armati; e il papa esce il dí appresso per le vie, e il popolo trionfante, Ciceruacchio capo solito di esso, acclama, inghirlanda, imbandiera la vittima sua.—Addí 2 e 3 moti in Milano... e feste funebri in tutta Italia. Addí 12 poi, moti anche piú gravi in Sicilia, e poi Napoli. Dove essendosi tumultuato e represso, e l’uno e l’altro invano, da parecchie settimane, finalmente i siciliani appuntarono pubblicamente quel giorno per sollevarsi davvero, se non fosse fatto nulla dal governo. E non essendosi fatto, si sollevarono cosí in Palermo. Resistettero le truppe regie, e vinte due volte si ritrassero, e fu fatto lá un governo provvisorio, a che aderí Sicilia tutta. E addí 16, domato il re finalmente, fece a un tratto e inutilmente tutto ciò che non aveva voluto fare a tempo ed agio; concedette libertá di stampa, governo consultativo, amministrazione separata per la Sicilia. Non serví piú; il popolo tumultuava peggio che mai addí 17. Cede il re, muta il ministero, chiama a capo di esso Serracapriola, promette costituzione. Addí 29 ne pubblica le basi, addí 10 febbraio ne pubblica il testo. Fu egli ridotto a tal passo ulteriore che finí la lenta (finché non fosse fatta l’impresa d’indipendenza) pendente rivoluzione riformativa, ed iniziò la rappresentativa, da quella necessitá appunto e sempre dall’imprudenza di coloro che non seppero essere prudentemente operosi? ovvero da qualche gelosia, dalla vanitá personale di far piú a un tratto, che non gli altri principi italiani fin allora;[209] di essere conseguente a se stesso, che s’era vantato di non aver a far riforme giá fatte nel suo regno? Sono questioni intenzionali che non si potrebbero sciogliere, se non in una storia fatta da Dio. Ad ogni modo, in quell’anno, in quei giorni, in quelle condizioni d’Italia, che qualunque favilla anche minore scoppiata in un luogo serpeva quasi lampo in ogni altro; non era possibile oramai che questa gran parola, questo immenso e desiderato fatto d’una costituzione rappresentativa, compiuto e proclamato in uno degli Stati italiani, rimanesse esclusivo in quello, non facesse sorgere fatti simili in tutti gli altri. I particolari delle feste e tumulti che giá non si potevan distinguere, delle domande legali od illegali, opportune od inopportune, coraggiose o cedenti, e delle cedenti resistenze, sarebbero troppo lunghi per questo cenno, e cadrebbero in que’ giudizi che non voglio qui promuovere. Ondeché mi accontenterò di dire, che la costituzione rappresentativa fu pubblicata in massima addí 8 febbraio, sancita in statuto addí 4 marzo; la costituzione toscana promessa addí 7 febbraio, e data in statuto addí 17 marzo, e la costituzione romana promessa addí 14 febbraio, e data in statuto addí 14 marzo. Cosí, quattro Stati, cioè tutti gli Stati grandi indipendenti d’Italia, cioè diciassette dei ventitré milioni, due terzi degli italiani, entrarono nella gran rivoluzione rappresentativa europea, ebbero rappresentativi statuti. E se n’applaudirono a vicenda principi e popoli, quando in quegli ultimi giorni di febbraio scoppiò la rivoluzione repubblicana di Francia. E se n’applaudivano principalmente i liberali piú moderati ed amici della monarchia. La concessione degli statuti, dicevano, n’avea salvi dalla repubblica. Pochi sapevano ricordare che giá due volte, alla fine del secolo decimoquinto e decimottavo, Francia ci aveva interrotto l’assestamento, il progresso riformativo d’Italia; sapevano temere che la nuova libertá italiana e la nuova repubblica in Francia, fossero due ostacoli invincibili alla guerra d’indipendenza che tutti vedevano imminente.
43. Continua l’appendice. Principio d’un’etá ottava della storia d’Italia? La guerra d’indipendenza [1848-1849].—Se non m’inganni quell’illusione troppo frequente che fa a ciascuno parer grandissimi[210] que’ fatti, quelle sventure in che visse, operò o soffrí, io credo che l’anno 1848 sia per rimanere uno de’ piú notevoli nella storia non solamente della gran rivoluzione rappresentativa, ma forse anche di quella che non può non seguire delle nazionalitá europee. Quattro grandi desidèri politici, o, se cosí si vogliano chiamare, idee, scoppiarono insieme qua e lá in Europa, la sconvolsero in quell’anno. 1º Il desiderio della democrazia assoluta, esclusiva, sotto i due nomi poco diversi di «comunismo» e «socialismo». 2º Il desiderio della libertá rappresentativa. 3º Il desiderio delle indipendenze nazionali. 4º Il desiderio delle cosí dette unitá delle nazioni, o riduzioni di esse a un governo solo o centrale. La rivoluzione francese di quell’anno fu prodotta non piú che dal primo e piú stolto di questi desidèri; la germanica, dal quarto e piú vano di essi; l’italiana sola fu l’effetto di quei due che non si debbono dir solamente piú legittimi e piú santi di que’ desidèri o sentimenti, ma principi imperituri dell’esistenza d’ogni nazione civile, i due sentimenti, desidèri, o passioni o principi, della libertá e dell’indipendenza. Sventuratamente l’Italia ebbe a propugnare i due insieme, e sventuratissimamente (dando retta di nuovo a consiglieri scartati negli ultimi anni) ella v’aggiunse il vano desiderio dell’unitá, o sogno settario. Chi vuol arrivare, non può avere che uno scopo solo; due, o peggio tre vie, sono impossibili a seguire. La mente umana non è infinita, anzi è misera; piú misera la mente di un popolo, dov’è la difficoltá di riunir tante menti in una. Napoleone stesso, una delle meno misere fra le menti umane, e mente unica assoluta d’una gran nazione, si vantava di non far mai che una cosa alla volta. Finché l’Italia fará imprese di due o tre scopi alla volta, ella le perderá sempre, quand’anche avesse occasioni piú belle che non quella del ’48, che è difficile, e quand’anche avesse a capo un Napoleone, che non è possibile, senza quell’unitá, la quale non si può (quando si dovesse) cercare senza l’indipendenza; la quale appunto si tratta d’aver prima ed anzi sola.
Tuttavia, a malgrado la sua importanza, l’anno 1848 non rimarrá per le altre nazioni èra di niuna nuova etá.
La democrazia assoluta tentata in Francia, e l’unitá governativa tentata in Germania, sono giá state vinte una volta; e perché quella è assurditá contraria a tutte le presenti e crescenti civiltá, questa vanitá o almeno utilitá non proporzionata a sue difficoltá, elle saranno probabilissimamente vinte altre volte.—Ma, all’incontro, perché due dei tre motori della rivoluzione italiana del ’48, sono, non che conformi, ma necessari a questa medesima universale e cristiana civiltá, perciò non credo debba rimaner dubbio a nessuno, e non rimane almeno a me: questi due scopi continueranno a concitare le menti italiane, a far nuove rivoluzioni, finché non sieno pienamente ottenuti. Dopo il fatale ma grande nostro ’48, non sono piú possibili né i vili ozi del Seicento, né le stentate riforme del Settecento, né le guerre sotterranee, gli scoppi inutili, le sètte inefficaci della prima metá dell’Ottocento; né per conseguenza quella preponderanza straniera che oltre tre secoli durò giá tranquilla con tali servi, poco inquietata da tali nemici. Dopo lo scoppio pur infelice, ma tutto diverso dei precedenti del ’48, rimangono e rimarranno, Dio solo sa quanto, gli stranieri in Italia materialmente, né piú né meno che prima. Ma non sono piú essi che possano dare lo spirito ai fatti, né i nomi alla storia d’Italia; sono, saranno le memorie del ’48; è, sará quella libertá rimasta in risultato e ricompensa degna ai propugnatori veri dell’impresa del ’48. Durerá dieci, cento, mille anni la nuova etá? Si chiamerá essa della libertá e dell’indipendenza conquistate? ovvero della conquista della libertá e dell’indipendenza? ovvero anche (che non credo, e Dio pietoso nol voglia) dell’inutile tentativo alla libertá e all’indipendenza? Io nol so; ma questo so dagli esempi di trentasei secoli noti alla storia, dalle condizioni di questo nostro in tutto il mondo; che le rivoluzioni (non le congiure) di libertá, una volta iniziate, possono retrocedere sí, ma non cessare; che la libertá interna è incompatibile colla servilitá al di fuori; che potrá quindi essere in Italia un’etá forse lunga, forse terribile, forse infelicissima, di lotta tra servi e padroni, ma non piú un’etá di servilitá da una parte, e quindi di preponderanza dall’altra. Sarebbe, cosí[212] Dio non voglia, piú possibile un’etá di servitú, che di servilitá o preponderanza. Questa è finita oramai; incomincia dal 1848 un’etá nuova, che io numero ottava della storia d’Italia, che i posteri battezzeranno essi, secondo che saranno piú o meno buoni della generazione nostra iniziatrice.
Qui giunto, cresce la difficoltá di quest’appendice. Potrei scusarmi di finirla qui. Ma poiché (bene o male) io superai giá quella di parlare dei fatti a cui preser parte gli amici ed avversari miei, io mi proverò a superar pur quella che qui s’aggiunge di parlar de’ fatti in cui ebbi parte anch’io. E supererolla al medesimo modo, solo possibile in questa brevitá, di giudicare sí i fatti, ma non la parte che v’ebbe ciascuno. E faccio e domando quindi per me la medesima riserva, che mi par giustizia. Quand’io loderò o condannerò un fatto in che ebbi parte io, come altri, non vuol dire che io lodi o condanni me. A un fatto moralmente cattivo è cattiva qualunque partecipazione per certo; ma un errore politico, pur rimanendo errore al complesso di quella nazione e di quelle persone che il fecero, può essere, non che scusabile, ma bello e generoso in chi il fece per iscansare errori maggiori. Gli errori del ’48 sono certi, poiché fallimmo l’impresa; ma quali sono? Chi vede gli uni, chi vede gli altri, io ne vedo forse piú che nessuno; e noterolli, anzi non vo incontro all’ingratissima fatica se non per notarli, perché credo possa essere piú utile ciò che tutto il resto del mio volume. Ma il giudicare qual parte abbia avuto ognuno in quegli errori, sarebbe materialmente impossibile qui; e non sarebbe poi anche in opera piú lunga possibile a me. Delle cose a cui si partecipò io credo che sia piú bello, piú franco farsi non giudice, ma piú modestamente avvocato; scrivere non storia, ma memorie. E queste detterò poi, quando io abbia tempo e voglia; ché non credo aver né l’un né l’altra.
Dicemmo, gli statuti, la libertá essere stata data a Napoli addí 11 febbraio, a Torino addí 4 marzo, a Firenze addí 17, a Roma addí 14 marzo.—Addí 18 incominciò il sollevamento de’ milanesi; al 19 Carlo Alberto die’ ordine di adunare l’esercito al Ticino. Nella notte del 22 al 23, dopo cinque giornate[213] di sollevamento, inopportunamente fatto, meravigliosamente proseguito e finito, Milano fu libera dai tedeschi. E nel medesimo dí, cinque ore prima che ne giugnesse nuova a Torino, la guerra d’indipendenza era dichiarata dal piccolo re di Piemonte, cioè di quattro milioni e mezzo d’anime, senza un’alleanza, né politica, all’imperator d’Austria, cioè di trentasei milioni, appoggiato dall’alleanza d’Europa dal 1815. Non importa; si gridò in tutta Italia alla tardanza, alla titubanza piemontese.—Addí 25, un primo corpo piemontese entrò in Milano, addí 26 il re partí di Torino, addí 3 aprile entrò in Pavia, e proseguí poi a Crema, con soli venticinquemila uomini contra l’esercito austriaco di settantamila. Questi, fuggenti dalle cittá sollevate, si raccoglievano al campo di Montechiaro. Il re lo minacciò, lo sloggiò piegando a destra, e scendendo il Po. L’operazione era bella, la guerra era portata d’un tratto sul Mincio. Addí 8 aprile, si combatté a Goito, si prese e si passò quel fiume; addí 9 si combatté e si passò a Monzambano, addí 10 ed 11 a Valeggio. Allora la guerra era necessariamente in que’ campi tra Mincio ed Adige, dove, quando non era se non la fortezza di Mantova, Buonaparte giovane e vittorioso dimorò e vinse per otto mesi, dove ora era il terribile quadrilatero di Peschiera, Mantova, Verona e Legnago, apparecchiate, rinforzate e studiate ne’ trentaquattro anni di pace dai sospettosi stranieri, dove ora il re conduceva un esercito nuovo di venticinquemila uomini, contro sessanta o settantamila austriaci. Il grido d’Italia, cioè de’ settari, dei tribuni di piazza, degli oratori di circoli, degli scrittori di giornali, del governo provvisorio di Milano, forse senza eccezioni, e quello stesso dei ministri e consiglieri del re con pochissime eccezioni, era che si passasse attraverso i due fiumi, le quattro fortezze, i sessantamila nemici, per dar la mano a Venezia, Vicenza e l’altre cittá, e si portasse la guerra agli sbocchi, anzi alle cime dell’Alpi da Como a Trieste. Né fa meraviglia che la povera Italia, inesperta di guerra anche piú che di politica, gridasse siffatte stoltezze; sí il può fare che rimangano queste in alcuni libri di uomini anche militari. Quand’anche fosse stata vera, generale ed armata insurrezione in[214] Lombardia e Venezia, sarebbe stata inutilitá, fanciullaggine, correre a dar la mano a’ veneti, perdendo piede in Lombardia, che è la solita perdizione di tutte le guerre d’insurrezione. Ma questo poi non era né poteva essere in Lombardia né in Venezia, non v’essendo armi colá, né potendone dare il Piemonte, che non n’avea, pur troppo, il corredo suo intiero per il proprio esercito; ondeché, chi accusa lombardi e veneti di non essersi levati ad insurrezione armata, è poco meno ingiusto che chi accusa il re di non esser corso a congiungersi (quand’anche fosse stato materialmente possibile) con quell’insurrezione che non esisteva. Il fatto sta che gli eventi tutti di questa guerra dimostrano ora facilissimamente ad insegnamento (che Dio voglia non disperdere) delle generazioni future, che la somma, che il tutto di questa prima, ardita, forse temeraria, generosa guerra d’indipendenza, era, doveva essere, non poteva non essere se non nell’esercito piemontese; che questo doveva dunque serbarsi, salvarsi, mantenersi, accrescersi, aiutarsi, incoraggiarsi, lodarsi, amarsi, e quasi adorarsi unicamente da tutta Italia; e tenersi perciò dal suo capo coraggiosamente, inalterabilmente sulla difensiva, ogni volta che non venisse un’occasione quasi sicura di offensiva; e prendersi questa allora solamente, e finché durasse l’occasione, tornando poi alla difensiva, dando tempo alle popolazioni di procacciarsi armi ed esercitarvisi, ed ai principi italiani di mandar aiuti, ed ai popoli di accorrervi; dando tempo, insomma, a quel tempo che è il piú grande alleato di tutte le guerre d’insurrezione, che era allora il solo nostro. Ma le stolte grida fecero fare una guerra tutta opposta, una guerra in furia, una guerra che volevasi corta e grossa; e questo fu l’errore che perdette tutto, che il perderá, se occorre, altre volte; perché da questo nacquero tutti gli altri, piccoli e grandi, numerosi, di rado interrotti, sempre risorgenti, e finalmente fatali. Né io conto per tale l’aver tentata con poca e piccola artiglieria Peschiera fin dal 13 aprile, Mantova fin dal 19; questo era necessario per tastare il nemico, per vedere se era veramente o no scoraggiato, se appunto si poteva fare o no una guerra tumultuaria, senza o contra regole. Ma la vanitá[215] dei due tentativi provò appunto il contrario; e fu errore non vederlo subito, e non chiamare fin d’allora il parco d’assedio, per una guerra che doveva essere evidentemente d’assedi, numerosi, ripetuti, continuati o lasciati, centrali a tutte le operazioni eventuali, alla Buonaparte. Ad ogni modo, fecesi bene, molto bene, ne’ dí seguenti. Arrivava, ordinossi l’esercito di sessantamila uomini piemontesi e de’ ducati; fecesene un corpo di due divisioni sotto Sonnaz a sinistra, uno di due altre sotto Bava a destra, una riserva di una divisione sotto il duca di Savoia. Questo era l’esercito d’operazione; ma alcune migliaia varianti in numero di volontari lombardi guardavan l’Alpi a sinistra, sulla sponda occidentale sul lago di Garda; cinque in seimila toscani arrivavano, furono posti poi a guardia contro a Mantova; diciassettemila pontifici varcavano il basso Po, e invece di unirsi co’ veneziani, e chiamare a sé tutti i veneti per fare un grosso esercito minaccioso da Padova e il Bacchiglione, corsero tutto il Veneto, chiamati da tutte le cittá, inutilmente allora, fatalmente poi; e in ultimo era arrivato un migliaio, e s’aspettavano venticinquemila napoletani. Con tali forze presenti, tali sperate, il re fece passare il Mincio a tutto l’esercito d’operazione, addí 26 e 27, occupò addí 28 e 29 que’ colli che salgono da Valeggio per Somma Campagna e Sona fino alla sponda destra dell’Adige, e quindi si collegano al Montebaldo, alle storiche posizioni di Rivoli e delle Chiuse d’Italia. Cosí investiva Peschiera; ma gli austriaci mostrarono volersi difendere a Pastrengo. Il re ve li assalí addí 30, e li vinse in bella giornata, che sarebbe stata forse piú bella se si fosse spinta per qualche ora di piú. Ad ogni modo su que’ colli era il luogo di fermarsi, di fortificarsi, di radicarsi, per far l’un dopo l’altro l’assedio di Peschiera addietro, di Verona poi all’innanzi. Delle quattro terribili piazze non erano necessarie a prendersi se non queste due, per portare, non piú stoltamente ma sicurissimamente l’esercito nella Venezia, per far cadere forse ed annullare per certo le altre due. Questo era non solamente precetto, regola d’arte, ma senno o senso volgare o comune. Ma le grida non permettevano senno e regole; volevano, dettavano[216] sregolature, colpi di genio, miracoli. Si tentò uno di questi addí 6 maggio. S’assalí Verona, la gran piazza d’armi d’Austria in Italia, con fanti, cavalli, e pezzi di campagna: riuscí come sogliono tali miracoli; fu respinto l’esercito piemontese da Santa Lucia dove era giunto, fu salvo nel ritirarsi dal bravo duca di Savoia. Allora si ricorse alle regole; e riuscirono a bene. In regola si fecero venir le artiglierie grosse; in regola si camminò per le trincee, si fecero parallele, si costrussero batterie, si aprí il loro fuoco [18 maggio] contro Peschiera, sotto gli ordini del duca di Genova; e in regola si propose una capitolazione, addí 26, ed in regola fu ricusata. Intanto Radetzki, l’insultato, ma ammirabil vecchio di 86 anni, si moveva da Verona addí 27, per far levar l’assedio con bella operazione. Veniva a Mantova [28], assaliva il mattino appresso con quarantamila i cinquemila toscani e pochi napoletani, staccati, od anzi, pur troppo, sacrificati a Curtatone e Montanara; e i toscani mostrarono costí non essere la mancanza di valor naturale, e nemmeno quella della disciplina che impedisca di diventar militare, ma solamente la colpevole trascuranza de’ loro governanti, o forse l’avarizia del paese che non vuole avere esercito per non ispendervi. Ad ogni modo, si fecero uccidere al loro posto, gloriosamente. Né fu forse inutilmente del tutto: ché, fosse Radetzki indugiato da tal resistenza od altro, il fatto sta ch’ei non proseguí in quel giorno, e non giunse se non alla dimane [30] all’attacco disegnato sulla punta della destra piemontese a Goito. Ed ivi con bella e pronta riunione di sue truppe giá stava Carlo Alberto. S’appiccò la battaglia poche ore prima della notte; fu diretta bene, in buona regola, e vinta da Bava. Né era finita del tutto, quando giunse sul campo la nuova della resa di Peschiera, conseguita il medesimo dí. Questa giornata del 30 maggio a Goito fu la piú bella di quella campagna, che fu la piú bella che siasi fatta mai dagli italiani da sette secoli. Quel nome e quella data, ed anzi quei due mesi e mezzo dal 18 marzo al 30 maggio, quella prima metá della campagna del 1848, rimarranno, che che sia per succedere poi, cari e sereni nella memoria degli italiani che vi parteciparono o li videro, ed in quella pure[217] dei posteri. E non giá che non vi fosser fatti di quegli errori che si fan sempre in tutte le guerre, e piú in siffatte subitanee e disapparecchiate; ma perché vi furono piccoli e grandemente riparati.
Ed all’incontro quelli che succedettero furono gravi, non riparati, forse irreparabili. Radetzki, respinto e rotto a Goito, s’era facilmente coperto e rifatto in Mantova. Questo è il vantaggio incommensurabilmente grande, ma nemmen veduto dagl’ignoranti, del guerreggiare tra grosse fortezze proprie; poter esser battuto ma non sconfitto, mentre il nemico in aria è sconfitto appena battuto. E da Mantova Radetzki spingeva vanguardie, ricognizioni, fin all’Oglio. Allora a gridare che si sagrificava Lombardia, Milano, da quelli stessi che pochi giorni addietro pretendevano s’andasse nel Veneto, a Venezia, all’Isonzo. Si die’ lor retta, s’indugiò, si rimase a Goito, vi si raccolser tutte le forze piemontesi per quattro giorni intieri. Finalmente, addí 4 giugno, si volle assalir Radetzki; era scampato nella notte. Si spinse fin sotto Mantova, non si trovò ancora. E allora, ancora eran due cose a fare: ovvero inseguire il nemico tra Mincio ed Adige, od anche oltre Adige, che allora soltanto fu forse possibile; ovvero assalir Verona, la gran Verona che ha forse bisogno d’un esercito a guarnigione ed allora non l’aveva, e cosí forse prenderla, certo minacciarla in modo da richiamarvi in fretta e cosí in disordine l’esercito austriaco. Non si fece né l’un né l’altro, né nulla per sei giorni; e addí 10 fecesi peggio che nulla, quel che non si dovea fare, ciò che era lungi dal vero campo di quelle operazioni, lungi dal vero nemico; si corse alla somma sinistra sull’Alpi, a Rivoli abbandonato.—Intanto Radetzki faceva la piú bella forse delle operazioni sue, trasse profitto della sua stessa rotta. Ritiratosi per Legnago, piombò su Vicenza dove Durando s’era raccolto dopo aver invano tentato d’opporsi alla congiunzione di Nugent con Radetzki. Ora giungeva un secondo gran rinforzo d’oltre a quindicimila sotto Welden per Tirolo. Radetzki chiamò anche questo contra Vicenza. Durando e i suoi e i cittadini resistettero addí 10 gloriosamente, ma inutilmente; capitolarono alla sera.[218] Ed alla medesima sera solamente da Garda, il re si rivolse a marciar contro a Verona. Addí 12, fu concentrato l’esercito a Villafranca; addí 13, fu portato presso alla gran fortezza. Ma vi si seppe il ritorno di Radetzki poc’ore innanzi da Vicenza presa; mancarono alcune intelligenze coll’interno della cittá, si rinunziò all’impresa, si ritrasse nella notte l’esercito, contento di non essere inseguito.—Seguí dal 14 giugno al 13 luglio un mese intiero di ozio, di silenzio, militarmente inconcepibile, inudito, non interrotto che da alcuni colpi di fucile e cannone da Rivoli e la Corona che s’era presa dopo Rivoli. Né fu risoluzione, appiglio a guerra difensiva. Cosí fosse stato! Trincerandosi sui colli tra Valleggio e Bussolengo, aspettandovi i rinforzi di Piemonte e Lombardia che venivano alla sfilata, che furono in un mese d’un venticinquemila uomini, che avrebbon potuto essere fra pochi altri d’oltre a centomila (come fu dimostrato poi al principio del ’49 dall’esserne sorti oltre a cinquantamila nel solo Piemonte esausto), sarebbesi dato quel tempo al tempo, che ridiciamo esser il piú grande aiuto alle guerre nazionali, che avrebbe qui posto alla nazione italiana l’interpellanza, se voleva o no davvero aiutar Piemonte che veniva, indipendente esso, ad aiutarla all’indipendenza. Ma non fu tal risoluzione; furono trenta irresoluzioni di giorno in giorno; non si mosse una zolla di terra sui colli difensivi, poche s’alzarono sulla strada da Verona a Peschiera; non si pensò ad assalir Verona con buona artiglieria, e buona pazienza, in regola, in faccia a sé, dove s’era mal tentata due volte; si pensò assalirla per la manca d’Adige, ficcando l’esercito tra esso e l’Alpi, che era una stoltezza, e non si tentò nemmeno; si pensò, forse piú strano, ad assalir Legnago, forticello piccolo, fiancheggiato dalle due fortezze grosse, e non si tentò; e si pensò finalmente, e pur troppo si tentò e incominciò, l’assedio di Mantova. In quella stagione, non v’era aria cattiva, ond’è probabile che se fosse durato quell’assedio sarebbe finito colla perdizione dell’esercito intiero. Ma se fosse finito colla presa di Mantova, non era fatto nulla, o poco; rimanendo intiera agli austriaci la linea dell’Adige, Legnago, e massime la gran Verona,[219] quella Verona che è la vera ròcca d’Austria, il vero freno d’Italia. Ad ogni modo, addí 13 s’investí la piazza; due divisioni (si noti bene), un ventimila uomini, a destra di Mincio; il resto dell’esercito, un sessantamila uomini, a scaglioni tra Sacca e Marmirolo fino a Rivoli e la Corona; cioè in somma una linea sproporzionatamente lunga, una grossa testa intorno a Mantova, una lunga coda fino all’Alpi. Sorrideva finalmente la fortuna saputa aspettare dal vecchio maresciallo austriaco; colsela, accarezzò, aggravò l’errore nostro, e piombò ardito poi a punirlo. Fin dal 14 spinse a Ferrara un corpo minacciante i ducati. Bava si mosse verso questi; gli austriaci si ritrassero; e Bava, non volendo perder sua mossa, si distrasse a prender Governolo addí 18. Allora, estesa cosí piú che mai ed assottigliata la linea de’ piemontesi, e fermata tutta l’attenzione loro a lor somma destra, Radetzki li fece assalire addí 22 a somma sinistra, alla Corona. I nostri vi si difeser bene, anzi vinsero. Ma Sonnaz, giudicando bene non esser ivi la somma delle cose, ripiegossi quantunque vittorioso verso Peschiera. E di fatti, all’alba dei 23, Radetzki assalí Sona e Somma Campagna, con grandi forze, le prese, ne cacciò i pochi nostri che pur si ritrassero a Peschiera, ed esso spinse sino al Mincio, a Salionze, a Monzambano e Valleggio. Addí 24, Sonnaz rinunciò a raggiungere il grosso dell’esercito nostro per la manca del Mincio, anzi, a difender questo seriamente, mosse per la destra fino a Volta. Radetzki non fece passare se non ricognizioni; e facendo anzi fronte addietro, collocò egli l’esercito suo in quella bella posizione difensiva dei colli da Valleggio a Somma Campagna. Il re intanto avvertito fin dalla mattina innanzi a Marmirolo, aveva levato l’assedio di Mantova, raccoltene tutte le truppe che erano a manca di Mincio, portatele nella notte a Villafranca. Ardita, magnifica mossa, che poté far credere a chi udian da lungi, essere destinato il nome di lui ad accrescer la breve serie de’ grandissimi capitani, esser destinata ed oramai compiuta l’indipendenza italiana. Sventuratamente la mossa fu incompiuta, titubante, era senza disegno; il re lasciò due divisioni a destra del Mincio, due divisioni, ventimila uomini[220] oziosi, mentre andava a combattere il tutto fra Villafranca e Valleggio. E perché il tutto fu dubbio in quel giorno, e perduto di poco al dí seguente con quei ventimila uomini di meno sul campo, certo è, matematicamente certo, che s’egli avesse avuto quel cosí grosso soprappiú, avrebbe vinto invece d’essere appena vinto. Ma, cosí è della guerra; la sorte di lei, il destino delle nazioni v’è deciso da una ispirazione, anzi un pensiero facile; e questo, facile, volgarissimo per sé, era facilitato ancora dall’esempio cosí contrario di Buonaparte su quel medesimo terreno. Qui convien abbassare il capo dinanzi al Dio ispiratore ed acciecatore dei capitani e dei re: qui non piú dir altro che Dio nol volle; me lo perdoni il mio re, immerso ora nel fonte della veritá.—In somma, con quell’esercito peggio che dimezzato dai primi e da quest’ultimo errore, con poco piú che venticinquemila uomini, il re assalí, senza aspettar altri od altro, nella giornata stessa dei 24 gli austriaci su quei colli stessi, che erano stati, che avrebbon dovuto forse essere sempre la sua posizione difensiva inalterabile. E li vinse in quella giornata, quantunque piú numerosi, sia per la difficoltá e il pericolo sempre grande d’un cambiamento di fronte addietro, sia per l’impeto superiore de’ buoni piemontesi. Ma fu un inganno, fu una perfidia di fortuna. Se fosse stato vinto di quel poco che vinse, il re avrebbe probabilmente indugiato l’attacco della domane, raccolte tutte le sue truppe, combattuto con quaranta o cinquantamila uomini invece di poco piú di venti.—Ad ogni modo, addí 25 si rinnovò la battaglia; non ne dirò i casi, gli errori disputabili, disputati, inutilmente disputati; era perduta prima che incominciata. Ognuno dei due eserciti aveva le spalle alla base d’operazioni, al paese nemico; in tal situazione le battaglie son disperate, da ambe le parti, ma sempre svantaggiose a quella che assalita e sorpresa ha difficoltá a raccogliersi, perdute se non s’è saputa vincere prima quella difficoltá. L’esercito piemontese, soldati, ufficiali, generali, principi, vi fece prove di valore, riconosciute poi dal nemico piú generoso che i compatriotti, dall’Europa militare e che stava allora, tutta salvo il resto d’Italia, sotto l’armi. Lo sforzo[221] principale fu del duca di Savoia a difender Custoza; non vi riuscí, non vi potea riuscire; rimasene il nome a quella giornata infausta ed immortale. Se ne ricordi e se ne penta la pigra Italia finché l’abbia fatto dimenticare. Gli errori, le spensieratezze dei capitani, son cose frequenti, solite, da computarsi in tutte le guerre, piú in queste di sollevamento ed indipendenza. Queste non si debbono fare senza computar quelli, senza porsi in grado di vincerle a forza di numero, di pazienza, di perduranza. Senza dar almeno due armate pari all’austriaca ancorata sulle sue quattro fortezze, non vi sará mai probabilitá di vincer questa. Finché l’Italia orientale, centrale e meridionale non potrá, saprá o vorrá aver un esercito secondo, vegnente sul Po ad aiutare il piemontese giunto dall’Alpi occidentali e al Mincio ed all’Adige, se lo tolga di mente, la pigra, o divisa, o disputante Italia, ella non sará probabilissimamente mai liberata da questo, per quanto generoso, ardito, temerario, devoto o sacrificato od anche meglio ordinato egli sia per essere. Quattro milioni e mezzo in armi non bastano a liberare ventitré milioni d’oziosi contro a trentasei milioni di resistenti, se non per un caso, un miracolo, che è viltá sperare. Disse l’Italia che voleva far da sé; ma non fu vero: fece il Piemonte per lei tutta a Custoza. Seppe dire ognuno che una nazione non dee contare su aiuti stranieri; ma ella non dee contare nemmeno su una parte sola, su un quinto di se stessa, non dee diminuire dal cinque all’uno la sua probabilitá d’indipendenza.—Ad ogni modo, questa era ridotta a zero; alla sera dei 25 luglio l’esercito piemontese ritrattosi a Villafranca, si ritrasse nella notte a Goito. Il nemico vittorioso a stento, rispettò la ritirata dei vinti.
Alla domane [26] l’esercito tutto raccolto sulla manca del Mincio vi trovava le sue divisioni lasciatevi senza combatter nulla, e quella di Sonnaz che pur troppo non avea combattuto il dí innanzi. Potevano giovare a difendere la ritirata. Nuovo errore: Sonnaz fu lanciato inutilmente e solo contra Volta: l’assalí a sera, presela, fu respinto nella notte, riassalí rinforzato nel mattino, e fu respinto di nuovo. Il dí appresso [27],[222] il re domandò un armistizio e ritirarsi dietro Oglio; gli fu imposto dietro Adda, lasciando ducati e Peschiera; ricusò, error gravissimo.—Allora s’incominciò la ritirata disordinata, fuga. Allora tornarono in mente a que’ soldati ed ufficiali non solamente, come fu detto, il paese e la dolce famiglia giá abbandonata ed ora pericolante, ma le ingiurie, i rimproveri, le stoltezze gettate loro in faccia da tutta Italia e da casa stessa mentre combattevano e vincevano; questo pensiero, che avrebbe pervertito forse a vendette un vecchio e vittorioso esercito, pervertí a indisciplina il nuovo e vinto piemontese. Ad ogni modo, si corse ad Oglio, e si lasciò dopo poco combattere Cremona; si corse ad Adda, e si lasciò senza combattere. Il re poteva passare il Po a Piacenza; coprirsi di quel fiume e questa cittá, e quindi al bisogno ricoverarsi a quella linea d’Alessandria e Genova che è la nota e sola buona difensiva del Piemonte, ma veniva chiamato dalle grida, dalle supplicazioni de’ milanesi. Cedette a questi, e parve nuovo e grave errore militare. Ma ogni guerra, e questa piú d’ogni altra, dovea cedere pure alle condizioni, ai sentimenti politici; e fu bello al re cedere al sentimento di difendere fino all’ultimo gli alleati, ingenerosi per certo, ma per cui s’era, in somma, incominciata e fatta tutta quella guerra. Addí 3 agosto, veniva il re da Lodi a Milano con venticinquemila uomini al piú, e li collocava fuor delle mura meridionali. Addí 4, v’arriva Radetzki all’incontro con trentacinquemila, cresciuti in breve a quarantamila e piú. La battaglia s’attaccò subito. Tranne pochissimi, i milanesi non fecer nulla; e i piemontesi, piú sdegnati che mai, non combattendo piú che per l’onor dell’armi; e combatterono bene alcune ore, e si ritrasser poi dietro le mura. A notte, il re domandò una capitolazione, Radetzki la concedé; ritirata de’ piemontesi dietro al Ticino, due giorni dati a’ milanesi che volesser seguirli. Ma alla mattina incominciò la prima di quelle tre giornate di sacrilega ingratitudine onde s’infama la storia della nostra impresa di libertá e d’indipendenza, quelle tre giornate che per opera di pochi scellerati hanno sporcato i nomi di tre nobili cittá italiane. Né sará degna l’Italia mai di rinnovare con[223] sufficiente virtú la grande impresa, finché dall’Alpi ai tre mari non venga vergogna vera di quelle macchie d’odio, e non sien lavate con lagrime, o meglio con fatti di pentimento, di concordia e d’amore. Dal mattino di quel dí [5 agosto] si gridò per le vie, per le piazze, dinnanzi al palazzo Greppi, alloggio del re, traditore quel re sacrificatore (piú che mai da ventiquattro ore) di sé, de’ suoi figli, di sua antica dinastia, di suo popolo indipendente, all’indipendenza del popolo lombardo; si fucilò lunghe ore contro la porta e le finestre; si stracciò dal re la capitolazione, si rifece dallo sbigottito municipio, si liberò il re da una compagnia di bersaglieri corsa finalmente contro a quell’attruppaglia; il re si ritrasse a piedi in mezzo alla notte fino al di fuori delle mura, inseguito dalle ingiurie e dalle schioppettate lontane, rattenente la vendetta de’ suoi. Addí 6, egli e i piemontesi erano oltre Ticino, e Radetzki entrava tranquillo a Milano. Addí 9, firmavasi un armistizio inaspettatamente favorevole, a giudizio d’ogn’uomo militare o politico d’allora, e d’ogni scrittore assennato dappoi; e fu gridato tradimento nuovo non piú a Milano solamente, ma in tutta Italia e Torino stesso, e gridatovi per sei mesi quasi infame il nome dell’ufficiale innocente e devoto che aveva dovere di firmarlo. S’intende che nella concitazione delle rivoluzioni tutti i popoli son talor pazzi. Ma chi l’è, o vi dura troppo, del tutto, s’intende che non riesce a compierle bene mai, non riesce a rompere ma a ribattere propri ferri.
Ma passiamo dai generosi errori militari agli ingenerosi e piú numerosi errori civili, che si stavano facendo intanto in tutta Italia.—In Milano e Lombardia, per cui principalmente e cosí vicino si combatteva, non è vero che cadesse ogni ardor militare dopo le cinque giornate. Sorsero numerosi volontari che combatteron sull’Alpi o tra le file piemontesi, o raccolti in quelle divisioni lasciate inoperose a Mantova. In quattro mesi, e disarmati, sarebbesi difficilmente potuto far piú; forse sarebbesi potuto meglio, rinunciando ad avere esercito proprio, riducendosi a supplir le file diradate dei battaglioni di guerra, ingrossando le rade dei depositi piemontesi. Ma questo e tutti[224] gli altri errori vennero da quello altro che si suol chiamare col nome nuovo di «municipalismo», ma che comprende in sé i due vizi antichi, vergognosi, capitali e sempre fatali, della superbia e dell’invidia, superbia d’ogni menomo merito, invidia degli stessi piú evidenti benefattori. Milano impazzita di sue cinque giornate, trattò in grida, in atti, in fatti, i piemontesi accorsi due dí dopo, non come liberatori che erano stati forse veramente minacciando giá dal Ticino, e non come almeno aiuti necessari, ma come tardivi, inutili, usurpatori di vittoria di giá compiuta e sicura; trattò il re, com’ebbe a dire egli stesso, a quel modo che la repubblica francese del 1792 trattava i suoi generali. Il governo provvisorio presieduto da quel Casati che come podestá avea giá fatta la lunga e bella guerra legale, ma raccolto, com’è naturale, d’ogni frazione, d’ogni tinta del partito liberale, dalle corti alle sètte, dai semplici riformisti ai repubblicani rossi o comunisti, diviso, discorde in sé, fu impotentissimo a dominar le discordie dell’opinione, della stampa, delle sètte, de’ circoli, della piazza. Credette comporle con questo mezzo termine: proporre al voto universale la fusione (parola nuova o male applicata e che rimane infausta) di Lombardia a Piemonte, con questo patto orgoglioso che del nome, delle memorie, delle leggi, dello statuto stesso del vecchio e or ora rinnovato Piemonte non rimanesse, salvo la casa di Savoia, nulla di conservato se non sancito e rifatto da una Costituente lombardo-piemontese. E Piemonte, re, Camere, principi, ministri, grandi, popolani, intendenti o non intendenti, ripugnanti o non ripugnanti a quello stoltissimo fra gli errori di qualunque rivoluzione incipiente, tutti s’affrettarono d’accettare, per non turbare la guerra d’indipendenza, dico dell’indipendenza non piemontese, ma lombarda. E nota che tutto ciò si faceva a mezzo maggio, tra le due vittorie piemontesi di Pastrengo e Goito.—Non dico altro. Nemmeno le condizioni aggiunte, la coda di quella fusione parimente imposta, parimente accettata. A petto di questo furon nulla tutti gli altri errori d’allora, quello stesso errore del governo di rifiutar l’offerta fatta dallo Schnitzer, inviato austriaco, di lasciar libera Lombardia fino all’Adige; questo[225] almeno si potrá scusare per la prudenza, o almeno per il non dividersi dalla compagna Venezia. L’errore sconoscente della Costituente non fu superato se non dalla piú sconoscente infamia della giornata del 5 agosto, che termina la breve e fatal serie dei fatti di Lombardia libera, ricomincia quella dei suoi dolori. Rispettiamoli e passiamo.—Venezia essa pure incominciò con un errore grave, ma forse scusabile, e certamente breve, e piú che compensato poi dalla sua perdurante, magnifica difesa. Male o bene, tutto vi fu effetto delle sue condizioni peculiari, non solamente locali, ma anche politiche. La servitú di Milano, antica giá di oltre a tre secoli, dal 1535 in poi, era stata quasi interrotta da quindici o diciotto anni di apparente indipendenza; e rinnovata da trentaquattro anni, era stata grave sí, ma pure splendida fino a un certo punto, e quasi adulata talora, fino agli ultimi anni e mesi; e quindi Milano, forse piú profondamente, certo piú anticamente avvilito, era meno umiliato anche prima delle insuperbienti cinque giornate. All’incontro, Venezia non era serva che da cinquanta anni di umiliazioni e patimenti continui, materiali, sentiti da tutti, grandi e popolo insieme; quindi meno avvilita forse, ella si mostrò certo piú umile, piú modesta, piú arrendevole, piú intendente la necessitá dei tempi e luoghi. S’aggiunse la fortuna d’aver cacciati gli stranieri facilmente fin dal 24 marzo, colle sole minacce, quasi senza sangue, e cosí quasi senza causa o pretesto d’insuperbire. Ébbene un’altra: che gli uomini principali i quali iniziarono la sua rivoluzione, furono meno discordi; ed uno di essi, il Manin, crebbe in breve sopra gli altri, e sopra se stesso; seppe e poté farvisi duce e quasi dittatore. Ma questa fortuna o saviezza fu figlia dell’altre; essendo gran saviezza nelle rivoluzioni saper farsi o lasciarsi fare un buon duce. Ad ogni modo, appena liberatasi Venezia, si costituí in repubblica, ma di San Marco, piú che alla francese, od a modo de’ carbonari o della Giovine Italia; e quanti di costoro accorsero, il Manin seppe annientarli e scostarli, od anche cacciarli; e appena si parlò di fusioni, ella pure Venezia seppe aderirvi, e con Milano primamente quantunque non repubblicana, e con Piemonte quantunque monarchico. E s’armò,[226] che è sempre il piú difficile e piú proficuo, per terra e per mare, assoggettando sue truppe ad ufficiali piemontesi, sue navi all’ammiraglio genovese, senza pettegolezzi di memorie antiche o di gelosie nuove. Né esercitonne colle sue antiche province, e talor soffrinne da esse; che se fossero state parimente savie, avrebbero inteso di poter, non che governarsi, ma difendersi molto meglio facendo capo grosso grossissimo a Venezia e Padova, che non ognuna da sé. E fatta finalmente la fusione con Piemonte, ed accettati i commissari piemontesi pochi dí prima della rotta di Custoza, Venezia e Manin restituirono sí la repubblica e San Marco, ma non che eccedere in stoltezze repubblicane ne’ mesi successivi, continuarono anzi crebbero in prudenza civile e militare, e cosí si fecer degni di soffrir poi quel magnifico assedio dell’anno appresso che ha rivendicato oramai il nome di lei dalle vergogne degli ultimi anni di sua libertá, da quelle di sua caduta, da quelle di sua servitú. Da ultimo, forse il nome di Venezia s’è fatto nel ’48 il primo fra quelli delle cittá italiane. E sia che ella debba tal gloria a Manin, od anzi questi la sua a Venezia, certo pure il nome di lui rimane il primo fra quelli degli uomini politici italiani di quell’anno.—Piacenza, Parma, Reggio, Modena, operarono sole saviamente e generosamente, operando subito, unanimamente e senza condizioni politiche le loro unioni con Piemonte. Fa meraviglia, e quasi dicevo tenerezza, vedere in mezzo a quello scatenamento di superbie e d’invidie, la semplicitá delle parole, l’esposizione dei veri e materiali interessi municipali con che quelle cittá dichiararono le loro unioni, e fa senza meraviglia pur tenerezza ricordare la fraternitá vera e di fatti, non di false parole, dei prodi loro co’ nostri, su’ nostri campi di battaglia. Francamente, nobilmente grati essi allora a noi, s’abbiano la rimeritata gratitudine nostra.
Del Piemonte, centro e base d’operazioni militari e politiche di tutta quell’alta Italia (onde giá prendevasi prematuramente e cosí forse risibilmente il nome al nuovo regno), del Piemonte sarebbe per ciò a dir forse piú lungamente; ma ne dirò tanto meno quanto piú vi sono interessato. Il meglio del Piemonte,[227] i nostri figli, i nostri prodi, non erano in Piemonte. Torino deserta era piú magnifica, che non sia per esser mai affollata. Nobili e plebei, liberali vecchi e nuovi e non liberali, militari in attivitá o giá in ritiro o ancora alle scuole, pregavano, supplicavano per un posto qualunque, o partivano senza posto, all’esercito. Un vecchio colonnello in ritiro portò lo schioppo, e con frutto, per tutta la campagna. Sette fratelli Brunetta fecero le due. Undici d’un nome e d’un sangue vi si trovarono il dí di Pastrengo. Chiusa l’universitá, gli studenti diventati bersaglieri. Un giovinotto quasi fanciullo lascia la famiglia e il palazzo, va bersagliare dinanzi Peschiera, ha una palla nel cappello, gli par bella cosa, corre a Torino a mostrarlo alla madre ed ai compagni, e torna bersagliare a Pastrengo. All’accademia militare giá spoglia de’ corsi superiori, si sollevano quelli de’ corsi inferiori, che avean diciotto anni, pretendendo che non la scienza ma l’etá dava diritto a combattere; e non fatti ufficiali, partono sottoufficiali. Nella guardia nazionale di Torino servono volontari i fanciulli di quattordici anni. Chi per l’Italia, chi per il Piemonte, chi per il re e casa Savoia, chi per nessuno, per battersi. Questo, e questo solo, si chiama spirito militare; questo auguro all’Italia; che non so se abbia piú o meno merito, so bene che serve alla patria piú che la passione, nobilissima sí, ma, come ogni passione, fugace, della patria stessa. In men d’un mese l’esercito fu portato da venticinque a cinquantamila uomini e piú, l’artiglieria da quarantotto pezzi a centododici, oltre del parco d’assedio, oltre i depositi, le riserve, ed una coscrizione nuova chiamata. Se s’avessero avuti ufficiali bastanti, o si fosser potuti far tali tutti i sottoufficiali, si sarebbe avuto un esercito come quello di otto mesi appresso.
Non tutte le province, per vero dire, forniron uomini in pari proporzioni. Non nominerò quelle che meno; sí quelle che piú, il Piemonte antico e l’antichissima Savoia. Spoglia di truppe, ed assalita questa ne’ primi dí d’aprile da una mano di canaglia francese che chiamavan se stessi «feroci», si sollevarono da sé i buoni savoiardi e se ne liberarono. Da diciassette o diciottomila combattenti ebbe sempre, e de’ migliori: oltremontani[228] di sito e di lingua, furono i veri fratelli d’Italia, piú che tanti che si cantavan tali. In Torino era reggente il principe di Carignano, fremente armi come i suoi cugini, obbediente al posto assegnatogli dal suo re. Il ministero, formato, con tutti que’ primi costituzionali, di uomini d’ogni tinta liberale epperciò eterogenei, non si divise perciò, rimase unito dal sentimento comune della indipendenza; finché non furono adunate le Camere addí 9 maggio. Né in queste stesse si urtarono guari le parti, da principio, finché durò al campo la vittoria. Ma venuti gli indugi, gli errori dopo Goito, venner le accuse, giuste in parte, ingiustissime ed anche piú inopportune nelle loro esagerazioni, contro all’esercito; ed intanto poi la domanda de’ genovesi di distruggere (in mezzo alla guerra!) due de’ loro forti; e poi, dopo la fusione lombarda unanimemente pronunciata, quella coda della Consulta legislativa staccata, che i lombardi vollero fino all’adunarsi della comune Costituente; allora si divisero naturalmente ma miseramente e Camera e ministero; e fu cresciuta la confusione dalle iterate demissioni di questo e gl’indugi a formarne un altro, e finalmente dalle sconfitte dell’esercito. Due gravi, diversi, anzi opposti, rimproveri furono fatti allora e poi alla diplomazia piemontese; dall’una parte, di non avere conchiusa una confederazione o almeno una lega italiana domandata da Roma e Toscana; dall’altra, di non aver conchiusa la pace colla linea dell’Adige offerta da Schnitzer a Milano e da Himmelauer a Londra. Ma, quanto alla lega, i documenti posteriori e le narrazioni stesse fattene in senso contrario dimostrano che tali negoziati non servirono quando furon fatti, non avrebbero servito, se fatti prima, se non (come succede in ogni negoziato senza base niuna possibile), se non a divider piú. E quanto alla linea d’Adige, io concedo facilmente che il non accettarla fu error sommo per il Piemonte certamente, ed anche per l’Italia; ma fu di quegli errori che non era forse possibile non fare allora, che il non farli non avrebbe servito a salvar le sconfitte, e che ad ogni modo furono, come tutto il resto, generositá, lealtá, o se si voglia pazzie piemontesi, compensate come abbiamo giá veduto. Piú reale e nocivo[229] errore fu forse l’avere, colle riunioni accelerate e le parole imprudenti ufficiali, spaventato l’Italia media e meridionale.—Tutto ciò in quel settentrione, che solo veramente, proporzionatamente a sue forze, epperciò degnamente, guerreggiò o almeno soffrí per l’indipendenza. Della restante Italia giá dicemmo quant’è bello a dire, quanto fecero per quella causa i pochi toscani, pontifici e napoletani, tanto piú lodevoli essi quanto piú pochi, quanto piú è bello essere operoso e prode in patrie inerti. Poche parole aggiugneremo su’ loro errori fatali e crescenti.
Se non fosse dell’inerzia militare, di che io credo colpevoli principe, popolo e grandi, volgo, governanti e governati, tutti quanti in Toscana, questa sarebbe il paese del mondo piú fatto a civiltá e libertá. Il ministero Ridolfi formato in marzo, il parlamento adunatosi in giugno, furono forse i men divisi, i piú civili, i migliori in tutto che sieno stati a quella grand’epoca iniziatrice. Se non che, come succede pur troppo soventi in tutti i paesi di governi rappresentativi, le parti a cui non s’era dato adito al ministero ed alle Camere, furono tanto piú vive e dannose fuori. Liberali estremi, o come allor si disse alla francese, «rossi», repubblicani e settari fecero capo in Livorno. Il ministero tranquillo nel parlamento, ebbe a pugnar colla piazza di Livorno e suoi rimbombi a Firenze. Né tuttavia scoppiava tuttociò, finché le vittorie piemontesi tenner fermi i governi italiani.—Cosí in Roma sotto il ministero Antonelli [nominato li 10 marzo], ma per pochi giorni appena. Ché incominciò a turbarsi l’animo di Pio IX per li tumulti, anche piú anticivili che antireligiosi, contro ai gesuiti le cui case fu ridotto a far chiudere egli stesso [30 marzo]. E si turbò piú che mai per il proclama con che Durando invitava quasi a crociata l’esercito pontificio [5 aprile]. E dicesi si turbasse per le temute ambizioni del Piemonte e per il suo indugio a trattar la confederazione; ma quelle furono posteriori ne’ lor segni, e questa avrebbe cresciuti anziché scemati i suoi scrupoli di guerreggiare. E il fatto sta che questi furono effetto principalmente delle voci che venivano d’Austria, anzi di Germania tutta, che que’ vescovi,[230] que’ cleri, que’ cattolici si alienassero da lui parteggiante, guerreggiante contro essi per Italia, si separassero dalla Santa Sede, facessero scismi. Erano voci, timori esagerati, ma naturali. Cosí fu da Alessandro III e Gregorio VII in qua, e sará sempre; epperciò, sempre il dissi e sempre il ridirò, i papi non possono esser duci a niuna impresa d’indipendenza nostra: fattine duci l’abbandonano, il loro dovere di papi superando il loro dovere di principi italiani, e la fa loro abbandonare; e abbandonandola come duci, la rovinano. Quando, all’incontro, si saprá fare senz’essi, essi avranno anche come papi le medesime ragioni a non mettervisi contro, che ebbero a non mettersi contro a’ nostri nemici; lasceranno fare, tollereranno dapprima, e se ne contenteranno poi, indipendenti essi allora piú che mai, o indipendenti allora soltanto veramente. Ad ogni modo, tutti questi scontenti, scrupoli, timori, troppo naturalmente incitati dalla parte austriaca o retrograda, troppo stoltamente dalla liberale, scoppiarono all’ultimo in una allocuzione concistoriale del 29 aprile, nella quale Pio IX respingeva da sé ogni partecipazione alla guerra, e tanto piú la presidenza della confederazione o lega, ch’egli chiamava «una cotal nuova repubblica degli universi popoli d’Italia»[3]. E da quel giorno fu tolta di mezzo la forza principale della causa d’Italia, tolta ogni forza alla parte moderata, che s’appoggiava al concorso dei principi, e di questo sopra tutti. Il primo effetto fu la caduta del ministero Antonelli, e la formazione d’un nuovo [4 maggio] che fu presieduto dal cardinal Soglia, ma prese nome ed andamento dal Mamiani. Il papa scrisse e mandò un legato all’imperator d’Austria per la pace, ma inutilmente. Adunaronsi le Camere, o come si disser lá i due Consigli [5 giugno]. E subito ad ogni tratto, ad ogni fatto, per ogni piccola parola del discorso del governo, degli indirizzi delle Camere, delle orazioni dei deputati, fu un dividersi, un disputare, un non intendersi, un inasprirsi a vicenda, senza paragone maggiore che negli altri parlamenti. Era naturale, i membri [231]del parlamento e parecchi de’ ministri stessi volevan ridurre al nulla, o come si disse «cacciar nelle nubi» il principe ecclesiastico, molto piú che non si volesse od osasse fare allora de’ principi laici; e il papa si credeva anche piú degli altri in dovere di non soffrire tale spogliazione. Tuttavia, nemmeno a Roma nulla scoppiò finché durò la fortuna piemontese.—Non cosí nella caldissima, anzi infocata Napoli. Dove, appena dato lo statuto, eransi giá succeduti due ministeri presieduti dal Serracapriola e dal Cariati, quando venute le notizie della guerra incominciata da’ piemontesi, il popolo la chiese, il re la dichiarò e fece un altro ministero presieduto da Carlo Troya [7 aprile]. Partirono alcuni volontari primamente condotti dalla principessa Triulzi-Belgioioso, poi il decimo reggimento che per via di Toscana andò ad unirsi all’esercito piemontese e vi combatté bene; poi per le Marche fino a Bologna un esercito capitanato da Guglielmo Pepe, e partí a un tempo l’armata di mare per l’Adriatico. Ma erasi adunato intanto il parlamento siciliano addí 26 marzo; e nominatosi reggente dell’isola Ruggiero Settimo, e decretata la separazione dell’isola dal Regno e la decadenza di casa Borbone da quella corona separata, si apparecchiarono e serbaron l’armi ed armati miseramente non all’indipendenza vera e nazionale d’Italia, ma, profanando il nome, a quella che s’osò chiamare indipendenza d’una provincia italiana: era diminuzione dell’unione esistente, era disunione perpetrata allora appunto che si andava proclamando l’unitá. E quando la flotta napoletana passò lo stretto per l’Adriatico, Messina le tirò contro. Né erano piú savi a Napoli. Appressandosi la convocazione del parlamento per il dí 15 maggio, non che riunirsi, come altrove, i partiti in quella speranza, in quell’effettuazione dello statuto, fosse opera delle sètte piú potenti lá che altrove, o degli emissari repubblicani francesi, o diffidenza ed odio al re, o che che sia, il fatto sta che giá gridavasi non voler Camera dei pari eletta dal re, non lo statuto qual era, non giuramento a questo senza riserva. Disputossene, fra re, ministri, deputati, pari, guardia nazionale e popolo, ne’ giorni precedenti a quello della convocazione. Nella sera[232] de’ 14 incominciarono barricate all’incontro del palazzo regio e delle truppe che stavanvi a guardia. A mezza mattina dei 15, eran cresciute le barricate e guardie. Popolo di qua, truppe in battaglia di lá, non potevano restare oziose gran tempo. Parte un colpo: s’appiglia la zuffa, la battaglia, il macello, il saccheggio, ogni nefanditá di guerra cittadina. Le truppe rimangono vittoriose; il re muta ministero; Cariati presidente del nuovo; si sciolgon le Camere senza essersi legalmente aperte; i deputati perseveranti in lor aula, son cacciati da’ soldati; un proclama ripromette lo statuto; i repubblicani fuggono a Calabria, e vi levano guerra civile. Il re richiama l’esercito da Bologna, dismettendo Pepe. Questi con pochi disobbedisce, e vanno a Venezia. Statella sottentratogli, riconduce il resto in disordine. E cosí i pontifici di Durando abbandonati da un esercito intiero su cui contavano, furono perduti; cosí l’esercito piemontese perdette tra questi e quelli i trentamila uomini che formavano tutta la sua destra: cosí la guerra d’indipendenza, infiacchita giá il 29 aprile dalla allocuzione del papa, fu perduta intieramente il 15 maggio, mentre i piemontesi pur combattevano, morivano e vincevano per lei a Pastrengo ed a Goito. Noi non celammo gli errori che trasser questi da tali vittorie alla sconfitta di Custoza. Ma siffatti errori, al paragone, sono piccoli, sono di quelli che si fanno in ogni guerra, anche condotta da’ migliori capitani. Questi sono gli errori grossi, che causarono que’ piccoli, ed impedirono di rimediare a’ piccoli; questi, quelli che due mesi prima di Custoza avean giá perduta la guerra d’indipendenza. E con lei la parte moderata, la parte soda, sana, virtuosa, devota d’Italia.
44. L’armistizio [agosto 1848-20 marzo 1849].—Il periodo de’ sette mesi che seguí tra la prima e la seconda campagna di nostra guerra d’indipendenza fu cosí fecondo d’errori e d’insegnamenti politici, come era stato il primo di militari; fu anzi un cumulo, un precipizio, un vero baccanale d’inciviltá. La guerra d’indipendenza aveva fatto tacere le esagerazioni di libertá, la stolta idea dell’unitá: cessata ora la prima, scoppiarono quelle e questa. Se l’Italia media o meridionale fossero[233] state mature all’indipendenza, allora si sarebbe veduto, allora sarebber sorte sottentrando al vinto Piemonte: ma fu tutto all’opposto; d’allora in poi non sorse, non accorse un battaglione da quelle due Italie imbelli e distratte. I settari reduci dall’esilio, avevano giá nel primo periodo empite e corse le cittá d’Italia, Milano, Genova, Livorno, Roma, e Napoli principalmente; ma, fosse invidia o vergogna dell’impresa iniziata da altri, v’avean presa poca parte, ed erano i piú rimasti nell’ozio o nell’ombra: sbucarono sí allora da ogni parte, si mostrarono ne’ circoli e sulle piazze, penetrarono ne’ parlamenti e ne’ ministeri, abbatteronvi governi esistenti, ne crearono dei provvisori e vi promossero la licenza sotto nome di «libertá democratica», la unitá sotto quello di «Costituenti italiane». Cacciati di Milano dalla conquista austriaca, di Venezia dalla prudenza di Manin, di Napoli dalla controrivoluzione, s’ingrossarono tanto piú in Roma, Firenze, Livorno, Genova e Torino, vagando, come fu detto allora, quasi compagnie comiche dall’una all’altra di quelle scene aperte a lor fortune, sventura d’Italia. Alcuni uomini, nuovi o non logori dalla calunnia e dai tradimenti del primo periodo, tentarono resistere, ma invano. E non avendo noi luogo a distinguere i loro meriti, vogliamo almeno siano eccettuati da quel biasimo, del resto universale, che la severa e sola utile storia non può qui se non versare sull’Italia intiera, che sará confermato da’ posteri, se saranno migliori di noi. Se ne persuada una volta la misera Italia: ella fu perduta da’ suoi adulatori, dagli accarezzatori de’ suoi vizi e delle sue passioni, dagli scusatori delle colpe sue: finché ella dará retta a costoro ed ai successori di costoro, storici, politici, oratori di ogni sorta, ella non può riconoscere i suoi vizi; e finché ella non li abbia riconosciuti, ella non è nemmen sulla via di correggerli; e finché ella non li abbia corretti, ella vizierá, ella perderá tutte le occasioni, tutte le imprese, come ella viziò e perdette quella magnifica ed insperata del ’48.
In Torino il ministero Casati, entrato il 27 luglio, si dimise subito dopo l’armistizio, addí 13 agosto; sottentrò uno presieduto dapprima da Alfieri, poco appresso da Perrone. Tardi, ma[234] opportunamente ancora, il parlamento die’ ogni potere al re, e fu prorogato.—A Bologna arrivarono gli austriaci addí 7 agosto, e s’accamparono per accordo intorno alla cittá tenendone le porte. Ma sollevatosi il popolo il giorno appresso, li cacciò di lá intorno; ed accorsi i campagnuoli, li forzarono a raccogliersi verso Ferrara. Fu bello e raro esempio, ma seguíto dai soliti disordini popolari che durarono tutto quel mese e fino al principio dell’altro. E Roma era turbata da questi ed altri moti delle province, e addentro dai circoli, dalle sregolatezze, dal discredito del ministero. Il quale finalmente si ricompose addí 13 settembre, sotto la medesima presidenza del cardinal Soglia, ma si rinforzò di altri uomini popolari e soprattutti di Pellegrino Rossi. Esule questi d’Italia fin dal 1815 dopo aver preso parte al governo di Bologna istituito da Murat, erasi rifuggito in Ginevra dove aveva acquistata tal fama di professore, scrittore ed uomo di Stato, che gli fu affidato il carico di proporre un nuovo patto federale per tutta la Svizzera. Non accolto questo, erasi trasferito in Francia, dove accrescendo la triplice fama sua, era stato fatto pari ed ambasciadore a Roma. E qui accresciutala di nuovo in vari negoziati, ma lasciato il posto da febbraio in qua, era pur rimasto consigliero, amico del papa, amico delle riforme e dello statuto e d’ogni liberalitá; ondeché non era uomo in Italia che desse tanta speranza di sé a’ moderati, tanto timore ed odio ai settari, ai repubblicani, ai cosí detti democratici. E quest’ire e quest’odii si accesero tanto piú ne’ due mesi che, prorogate le Camere, il nuovo ministero governò, reprimendoli ed ordinando, come si poteva, bene l’amministrazione e le finanze.—In Napoli, dove il re aveva convocato un nuovo parlamento, e le elezioni aveano rimandato il medesimo fin dal primo luglio, re e parlamento non fecer altro guari che dividersi, com’era a prevedere, piú che mai, e quindi addí 5 settembre nuova prorogazione fino a’ 30 novembre. Quasi dappertutto adunque tregua politica come militare.—Ma non nella debole Toscana, dove, fosse caso o disegno, scoppiaron le opere de’ settari.
NOTA
I
Inculcare ai suoi connazionali e contemporanei che, prima di preoccuparsi del problema, intorno a cui tanto si travagliavano, dell’unitá, o dell’altro, pur cosí variamente discusso, della forma di governo, dovessero provvedere a risolver quello, ben altrimente importante, dell’indipendenza, lasciando da banda le effusioni rettoriche, le logomachie accademiche, le dimostrazioni di piazza e le macchinazioni settarie, e procurando piuttosto di mantenersi concordi e di riacquistare, fin quanto fosse possibile, quello spirito e quell’educazione militare, che purtroppo s’eran perduti da secoli, fu lo scopo cui Cesare Balbo tenne sempre fiso l’occhio durante la sua lunga, laboriosa e onestissima vita letteraria. E sempre solo mezzo idoneo al conseguimento del fine nobilissimo gli parve un libro storico, che, narrando gli avvenimenti svoltisi nella penisola in tre millenni, mostrasse, senza sforzi di ragionamento, ma con l’evidenza d’un imparziale racconto, che, allora soltanto l’Italia fu grande, prospera e felice, quando, animata dallo spirito d’indipendenza, seppe tener lontano dalle sue fertili e agognate contrade l’aborrito straniero.
Quando si abbia innanzi a sé, fissato con nettezza che non si potrebbe maggiore, il punto donde convenga guardare il corso degli avvenimenti, e quando a ciò si accoppii una folla di requisiti, che assai raramente si trovano riuniti insieme:—animo probo, tranquillo, sereno, che è naturalmente disposto a render giustizia a tutti, anche ai propri avversari;—serio spirito scientifico, che dei fatti non sa discorrere, se non dopo averli scrupolosamente[237] e minutamente investigati e accertati;—competenza profonda, per lungo esercizio professionale, nei pubblici affari, sia meramente amministrativi, sia politici e diplomatici, sia militari;—ingegno aristocratico, che non si appaga d’una cultura grettamente specialista, ma vuol veder chiaro anche in altri rami dello scibile (specialmente in filosofia e storia letteraria);—e finalmente vera fantasia poetica, la quale, oltre che infonder la vita negli avvenimenti del passato, sappia ritrarli in un magnifico stile «storico», serrato, conciso, aborrente sia da fronzoli e leziosaggini, sia da sciatterie e soverchia familiaritá:—si è davvero in condizioni eccezionalmente favorevoli per imprendere e condurre a termine un lavoro storico. Tutto, dunque, farebbe supporre che al Balbo, dare all’Italia quella storia, che egli vagheggiava, fosse per riuscire impresa piana e agevole. Eppure pochi libri sono costati tanto aspra e tormentosa fatica, quanto quest’aureo Sommario, che ora si ripubblica; scritto, è vero, in poco piú d’un mese, ma pensato e ripensato per trent’anni: trent’anni di lotta, trent’anni di conati, trent’anni di delusioni[4].
Mille volte parve all’autore, durante cosí lunga incubazione, d’aver trovata la sua strada; e con gioia si poneva a tavolino,[239] sperando di potersi liberare una buona volta da quel peso, che tanto l’opprimeva. Illusione! la via era cosí poco trovata, che prima[240] questione, che gli si presentasse alla mente, era proprio quella che si poteva rimandare all’ultimo luogo; la questione, cioè, del titolo da dare al proprio lavoro. Ne adottava uno; e poi, non contento, lo mutava; e poi lo rimutava ancora una terza, una quarta, una decima, una ventesima volta[5]; fintanto che, sbollito, in codesto sterile e quasi pedantesco tormentarsi, l’entusiasmo e inaridita la vena, gli occorreva deporre, con gesto addolorato ma rassegnato, la penna, augurandosi di poterla riprendere in piú favorevoli circostanze.
E la riprendeva, e aveva anche la forza d’imporre a se stesso di non occuparsi, provvisoriamente, di quella questione preliminare, intorno a cui credeva suo debito cotanto travagliarsi. Ma il luogo di questa veniva preso da un’altra, che, nel modo in cui il Balbo se la proponeva e voleva risolverla, riusciva non meno oziosa e insolubile: la questione delle parti onde doveva constare il suo lavoro, ossia dei periodi principali e secondari, in cui bisognava dividere e suddividere la storia d’Italia. Questione oziosa e insolubile, perché la storia, che è continuitá, non è suscettibile di divisioni cronologiche razionali, che si possano astrattamente fissare a priori: è invece lo stesso racconto storico, giá configurato nella mente dell’autore, che può suggerirgli, a semplice scopo di chiarezza espositiva e di utilitá mnemonica, di attenersi a questa o a quella fra le tante escogitate ed escogitabili divisioni temporali (tutte piú o meno grossolane e approssimative), cui si suol dare il nome di «periodi storici». Ma pel Balbo, che pensava diversamente[6],[241] e pel quale la ripartizione della materia storica costituiva qualcosa di essenzialmente diverso dall’esposizione, la questione assurgeva a importanza capitale: a narrare gli pareva di non poter nemmeno cominciare, se non avesse preliminarmente classificati i fatti in periodi principali, secondari e via dicendo; ossia se non avesse innanzi, perfetto anche nei minimi particolari, uno schema cronologico, razionalmente e quindi astrattamente fissato, che poi conveniva sviluppare e colorire. Accadeva, naturalmente, quel che doveva accadere; cioè che il Balbo, dopo essersi procurata un’altra serie di tormenti e di ambasce, durante la quale prospetti cronologici susseguivano a prospetti cronologici, ciascuno dei quali annullava il precedente e ciascuno dei quali lo contentava meno del precedente, finiva, sgomentato e sbigottito, per deporre ancora una volta la penna e credere che la storia d’Italia non fosse impresa da lui.
Ma vi ritornava poi, con la tenace costanza, con la quale le mille volte si ritorna a una donna amata, cui le mille volte si sia giurato un eterno addio. E, accontentatosi d’un titolo e d’uno schema purchessia, cominciava finalmente a scrivere. Uno, due, tre capitoli erano rapidamente svolti: poi a poco a poco la materia, di cui si credeva cosí sicuro padrone, cominciava a sgretolarglisi nelle mani; i periodi gli riuscivano sempre meno euritmici e in pari tempo piú faticosi e difficili; l’esposizione generale perdeva di mano in mano vita e calore, diventando languida, scucita, frammentaria. Purtroppo nemmeno quella volta la via era trovata, e bisognava ricominciar daccapo a torturarsi coi titoli, i prospetti, gli schemi e via discorrendo.
Un fenomeno, ripetuto con tanta frequenza in un uomo che era uno storico nato, induce a riflettere e a domandare: era proprio un bel titolo o una soddisfacente ripartizione cronologica ciò che mancava al Balbo, o a lui faceva difetto qualcos’altro, di cui egli non riusciva a rendersi conto, e in cui tutte le torture, che s’era procurato apparentemente per questa e per quello, avevano la loro vera e profonda ragione? La risposta non può esser dubbia, e a chiunque abbia un po’ di pratica dello scrivere verrá spontanea sulle labbra l’osservazione, che il trapasso dalla mera impressione alla limpida visione artistica—quel trapasso rapidissimo e agevole in alcuni fortunati scrittori; lentissimo, faticosissimo e quasi patologico in altri—nel Balbo non aveva ancora avuto luogo. La storia d’Italia, non ostante tanti studi e tanti sforzi, era ancora per lui materia amorfa, che un lampo di genio doveva convertire in un’opera d’arte, ossia in un libro organico. In fondo all’animo suo era ancora un cantuccio buio, che quel lampo doveva illuminare. E tutti i conati da lui fatti non erano se non stimoli esterni, da lui inconsciamente adoperati per far sprizzare in modo artificiale quella divina scintilla. Ma l’arte non vuol esser conquistata né con la violenza né con sotterfugi: vuol venire ella stessa, spontaneamente, a noi, quando forse meno l’aspettiamo, e allora abbandonarsi tutta nelle nostre braccia. E cosí avvenne al Balbo.
S’era alla fine del 1845, ed egli, ormai vecchio, alla storia d’Italia aveva rinunziato, contento se altri, piú fortunato, potesse avvalersi del tesoro di ricerche e d’esperienza da lui accumulato. Un bel giorno si reca da lui il Predari e gli propone di scrivere l’articolo «Italia» per l’Enciclopedia popolare, che si pubblicava presso il Pomba[7]. Il buon vecchio sulle prime, spaventato, rifiutò netto: [243]chi gli avrebbe infuso il coraggio, dopo tante delusioni, di fare un ultimo e disperato tentativo? Tuttavia quel nome «Italia» gli aveva rimescolato tutto l’animo: nome indifferente forse ad altre orecchie, ma che per lui significava non soltanto la patria adorata, ma anche il meglio della sua vita trascorsa, con le sue ansie, le sue gioie, i suoi dolori. E la possente fantasia, che sembrava addormentata, cominciò a rievocare, con colori ancora piú poetici, gli itali, osci e tusci, che si alleano per ricacciare di lá dal mare l’odiato Pelasgo; i popoli latini, che si stringono intorno a Roma per tener fronte al Gallo invasore; i comuni lombardi, che giurano fratellanza e concordia a Pontida per respingere oltre le Alpi l’aborrito Tedesco. Strano! quella materia, che il Balbo non era mai riuscito a plasmare, assumeva ora da se stessa forme e contorni. I suoi occhi finalmente vedevano. Quella via, cosí angosciosamente ricercata, brancolando nel buio, gli appariva ora piana, sfolgorante di luce meridiana, conducente diritto alla mèta. Il primitivo rifiuto si cangiò in un’entusiastica e quasi baldanzosa accettazione, e con ardore giovanile egli si rimise al lavoro. Non piú esitazioni, non piú dubbiezze, non piú pentimenti: i fatti venivano a collocarsi, senza alcuno sforzo, al posto loro dovuto; i periodi stupendi sgorgavano, come un fluido corso d’acqua, l’uno dopo l’altro e l’uno indissolubilmente legato con l’altro; l’esposizione era finalmente, quale egli l’aveva tanto vagheggiata, rapida, serrata, drammatica, piena di movimento e di vita. Quella volta, non fu una fatica e un tormento, ma una liberazione e un trionfo. Dopo otto giorni, i primi tre libri erano scritti; dopo quarantatré, tutta l’opera era compiuta. E riuscí quel che il Balbo voleva: un capolavoro.
II
Non è certo il caso di spendere troppe parole intorno alle varie edizioni del Sommario e ai criteri seguiti nella nostra. Ricorderemo soltanto che, non ponendo nel novero una traduzione tedesca dovuta al Moll (Pest e Vienna, 1851), il libro fu stampato finora undici volte: 1 e 2) Torino, Pomba, 1846, nell’Enciclopedia popolare[8] e a parte; 3) Losanna, 1846[9]; 4) Losanna, 1848; 5) Losanna, 1849; 6) Milano, s.a.; 7) Napoli, s. a.; 8) Bastia, s. a.; 9) Torino, Pomba, 1852; 10) Firenze, Felice Le Monnier, 1856; 11) Napoli, Pelard, 1860.
Di codeste edizioni le sole che abbiano valore, perché provenienti direttamente dal Balbo, sono, oltre la prima: la terza, nella quale egli poté correggere, com’era suo vivo desiderio, parecchie inesattezze, nelle quali era incorso per la fretta, e aggiungere la stupenda prefazione, riprodotta a principio della presente ristampa; la nona, la quale, per altro, salvo l’aggiunta della dedica a Carlo Alberto[10], differisce poco o punto dalla terza[11]; e finalmente la decima, che, pubblicata tre anni dopo la morte dell’autore dal figlio, rappresenta, se non la stesura definitiva (quale stesura, per uno scrittore come il Balbo, poteva essere definitiva?), almeno [245]l’ultima fra le tante che egli dette all’opera sua. Si legga infatti la seguente lettera, che è premessa a quell’edizione:
Pregiatissimo signor Le Monnier,
Eccole il Sommario, preceduto da una prefazione, che l’autore disegnava di apporre alla nona edizione, fatta a Torino nel 1852. Da questa prefazione si scorge com’egli intendesse aggiungere al Sommario un’appendice, dal 1814 ai tempi attuali[12]: se non che egli dalla sua malferma salute fu impedito di condurla a termine; onde ciò, lui vivente, restò un desiderio, e l’edizione non differí dalla terza di Losanna, fin allora la piú completa. In margine d’un volume di questa, moltissime ed importanti correzioni avea fatte l’autore; le quali, con diligenza riportate, insieme coll’appendice tal quale ella è, le invio.
È dunque evidente, signor Felice pregiatissimo, che l’edizione, ch’Ella è per farne, verrá ad essere la prima veramente completa, la sola che risponda al concetto, al desiderio del mio ottimo padre.
Aggradisca ora i saluti, ecc.
Torino, 5 giugno 1855.
Prospero Balbo.
Era ovvio, dunque, che l’edizione Le Monnier fosse da noi riprodotta fedelmente; e ciò per l’appunto abbiamo fatto, conservando scrupolosamente la punteggiatura cosí personale del Balbo, e introducendo soltanto lievi modifiche grafiche, giusta i criteri generali della presente raccolta. Qualche raro errore di stampa abbiamo qua e lá corretto. Al contrario, in alcune inesattezze storiche commesse dal Balbo (p. e. nella confusione fra due omonimi della medesima famiglia) non abbiamo voluto, e non dovevamo, metter le mani, tranne che non risultasse evidente che si trattasse di materiali lapsus calami o di momentanee amnesie (p. e. il far risuscitare Andrea d’Ungheria, confondendolo con Luigi, dopo aver narrata la tragica morte del primo[13]).
Nell’edizione Le Monnier segue un lungo Indice dei nomi, completo per quelli di persone, capricciosamente lacunoso per quelli di luogo. Pare che colui, che lo compilò, non nutrisse troppa [246]simpatia per l’evo moderno, giacché è in codesta parte che le omissioni sono piú frequenti e piú gravi. Né mancano poi sdoppiamenti della medesima persona, o, ancora meno di rado, unificazioni di due individui diversi. A codeste lacune ed errori abbiamo procurato di riparare come meglio potevamo e sapevamo, cercando anche d’identificare e di designare, nei numerosi omonimi, con la maggiore precisione i diversi personaggi storici. Ma, poiché in siffatti lavori, per quanta pazienza e attenzione si ponga, riesce assai difficile raggiungere la compiutezza e la perfezione, invochiamo fin da ora, sulle nostre eventuali sviste e omissioni, la benevola indulgenza degli studiosi.
INDICE DEI NOMI
Abano (D’) Pietro, 289.
Abbiategrasso, 264, 268.
Abelardo, 281.
Abruzzi, 226.
Abukir, II, 142.
Acaia, 67, 259, 261.
Acerraggio, 124.
Acqui, 115.
Accursio, 282.
Acri, 216.
Acros, 24.
Acuto (l’), 254.
Adalberto, marchese di Toscana,
148.
Adalberto, figliuolo di Berengario II, 151, 152, 153, 154.
Adalberto, marchese d’Ivrea, 149.
Adalberto di Brema, 165.
Adaloaldo, 118.
Adamo, 96.
Adda, 106, 115, 199, 225; II, 223.
Adelaide, figliuola di re Rodolfo,
150, 151, 155.
Adelaide di Russia, 183.
Adelaide di Torino, 165, 179, 258.
Adelchi, 126, 135.
Adelgiso, vedi Adelchi.
Adige, 48, 151, 223.
Adige (Val d’), 193.
Adolfo di Nassau, 236.
Adonai, 31.
Adone, 31.
Adorni (gli), 253.
Adria, 26.
Adriani, II, 39.
Adriano, imperatore, 71, 87.
Adriano I, papa, 125, 126, 137.
Adriano IV, papa, 198, 201.
Adriano V, papa, 231.
Adriano VI, papa, II, 22.
Adriatico, 26, 27, 43, 253.
Affò, II, 171.
Africa, 30, 43, 44, 53, 67, 75, 81,
85, 107, 229.
Agilulfo, 117, 118, 120, 127.
Agnadello, II, 15.
Agnello, 169.
Agnese, madre d’Arrigo IV, 165.
Agostino (sant’), 78, 90, 98, 117.
Agostino veneziano, II, 47.
Agricola, 70.
Agrippa, 55.
Agrippina, 69.
Aix, II, 59.
Alachi, duca di Trento, 119.
Alamanni, II, 39.
Alani, 84.
Alaria, 25.
Alarico, 84, 129.
Alba, 115, 208.
Alba-Fucense, 34.
Albanesi, 269.
Albani, vedi papa Clemente XI.
Albano, 60.
Albano, pittore, II, 87.
Alberico, conte di Tusculo, 149, 163.
Alberico iuniore, figlio di Marozia, 150.
Alberico da Barbiano, 255.
Alberoni card., II, 99, 100, 112.
Alberti Benedetto, 253.
Alberti Leon Battista, 293.
Alberto Azzo, 151.
Alberto d’Austria, 236, 239.
Alberto Magno, 281.
Albigesi, 214.
Albino, imperatore, 72.
Albino, senatore, 107.
Albizzi (Degli) famiglia, 252, 263.
Albizzi (Degli) Rinaldo, 263, 264, 265.
Alboino, 113, 114.
Albornoz cardinale, 247, 248.
Alciato, II, 89.
Alcuino, 138, 168.
Aldobrandini, vedi papa Clemente VIII.
Alemanni, 72, 73, 74, 101.
Alençon (duchessa d’), II, 24.
Aleramica casa, 258, 259.
Aleramo, 258.
Alessandria della paglia, 204, 205,
206, 208, 220, 223, 256; II, 110.
Alessandria d’Egitto, 88.
Alessandriadi, 42.
Alessandrini, 259.
Alessandro, 44.
Alessandro Severo, 73.
Alessandro, imperatore di Russia, II, 152, 157.
Alessandro II, papa, 167, 168.
Alessandro III, papa, 167, 201, 203, 207, 212; II, 21, 231.
Alessandro IV, papa, 224, 225.
Alessandro V, papa, 257.
Alessandro VI, papa, II, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 62.
Alessandro VII, papa, II, 67.
Alessandro VIII, papa, II, 73.
Alessio, 217.
Alessio il giovane, 217.
Alessio (D’) Giuseppe, II, 68.
Alfieri (ministero), II, 234.
Alfieri Benedetto, II, 173.
Alfieri Vittorio, 196, II, 41, 54, 126, 166, 167, 197.
Alfonso, re di Castiglia, 230.
Alfonso III d’Aragona, 233.
Alfonso il Magnanimo, V come re d’Aragona, I come re di Napoli, 251, 262, 266, 270, 272.
Alfonso II d’Aragona, re di Napoli, II, 9.
Algardi, II, 88.
Alighieri Dante, vedi Dante.
Alighieri Iacopo, figliuolo di Dante, 292.
Allegri Antonio, vedi Correggio.
Allegri, maestro di musica, II, 89.
Allia, 29.
Allobrogi, 47.
Almanza, II, 96.
Almogavari (Compagnia degli), 243.
Alpi, 21, 135.
Alpi Carniche, 105, 113.
Alpi Cozie, II, 121.
Alpi Pennine, 27.
Alrico, 159.
Alsazia, II, 145.
Altieri, vedi papa Clemente X.
Alviano, II, 115.
Alzate, 163.
Amalarico, re dei visigoti, 107.
Amalasunta, 108.
Amalfi, 142, 146, 185, 215, 291.
Amali, 105.
Ambrogio (sant’), 90.
Amburgo, 156.
Amedeo di Savoia, 179.
Amedeo V di Savoia, 259, 260.
Amedeo VI, 260.
Amedeo VII, 260.
Amedeo VIII, 260, 261, 262, 272, 58.
Amedeo IX, il beato, 272.
America, 221, 287, 5, 42.
America (Stati-Uniti d’), 205, 203.
Americani, 113.
Amerigo, vedi Vespucci.
Amiens, 148.
Aminta (L’), favola boschereccia del Tasso, 82.
Ammirato, 39.
Anacleto, antipapa, 192, 193, 194.
Anagni, 235.
Anastasio, bibliotecario, 124, 169.
Anastasio IV, papa, 193.
Anco Marzio, 29.
Ancona, 109, 120, 198, 203, 205, 214.
Andalusia, 296.
Andrea d’Angiò, 246.
Andrea di Longimello, 291.
Andrea pisano, 285, 290.
Angelico (il beato), 293.
Angioini, 192, 226, 229, 231, 233, 236, 238, 251, 252, 257, 6.
Angli, 112.
Anglo-americana nazione, 97.
Anglo-americani, 205.
Aniene, 28.
Anna, duchessa di Bretagna, 6.
Anna, regina d’Inghilterra, 97, 99.
Annese Gennaro, 69.
Annibale, 44, 45.
Annone, arcivescovo di Colonia, 165, 167.
Ansa, 126.
Anselmo da Biagio, 167.
Anselmo (sant’) d’Aosta, 170, 281.
Anselmo (sant’) da Lucca, 170, 281, 89.
Ansprando, 120.
Antemio, 85.
Antenore, 25.
Antilla, 296.
Antiochia, 77, 216.
Antioco, re di Siria, 45.
Antonelli, 230, 231.
Antonino Pio, 71, 87.
Antonino (sant’), arcivescovo di Firenze, 292, 293.
Antonio L., 55.
Antonio M., 51, 55, 56.
Antonio (sant’) di Padova, 222.
Anzelino, 291.
Anzio, 253.
Anzo (Porto d’), 206.
Aosta, 150, 23.
Apollinare, 90.
Apollo, 31.
Apostoli, 77.
Appennini, 22, 26, 258.
Appiani, 174.
Appiano (D’) Iacopo, 255.
Apuleio, 88.
Apuli, 41.
Aquileia, 85.
Aquisgrana, 134, 137, 140, 141, 132.
Aquitani, 53.
Aquitania, 123, 125, 136, 140, 142.
Aquitanica provincia, 67.
Arabi, 66, 71, 169, 215, 218.
Arabia, 67.
Aragona, 214, 226, 232, 233, 234, 238, 6.
Aragonesi, 192, 243, 249, 258.
Aranda, 120.
Arcadi (accademia degli), 165.
Arcadio, 84.
Arcetri, 85.
Archimede, 59.
Arcoli, 138.
Arcos (duca d’), 69.
Ardea, 29.
Ardenti, 29.
Arduino, 156, 157, 158, 177.
Aretino Pietro, 40, 46.
Argentiera, 18, 108, 135.
Argos, 24.
Arialdo d’Alzate, 163.
Ariberto, 119, 120.
Ariberto, arci vescovo di Milano, 160, 161, 162, 163, 185.
Ario, 18.
Arioaldo, 118.
Ariosto Ludovico, 221, 294, 39, 42.
Ariperto, 119.
Aristotele, 56, 296, 40.
Armagnacco (conte d’), 255.
Armeni, 66.
Armenia, 51, 67, 69.
Arminio, 67.
Armorici, 66.
Arnaldo da Brescia, 195, 197, 198, 247.
Arnobio, 90.
Arnoldo di Baviera, detto il cattivo, 150.
Arnolfo, duca di Carintia, 145, 146, 147.
Arnolfo di Lapo, 228, 290.
Arnulfo, arci vescovo di Milano, 158.
Arrigo II di Sassonia, 156, 157, 158, 159.
Arrigo III di Franconia, 162, 163, 164, 165.
Arrigo IV, 165, 167, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184.
Arrigo V, 183, 189, 190, 191, 204, 208.
Arrigo VI di Hohenstaufen, 211, 212.
Arrigo VII di Lucemburgo, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 259.
Arrigo d’Este, detto il superbo, 194.
Arrigo, figliuolo di Federico II, 222, 226.
Arrigo, principe inglese, 229.
Arrigo VII d’Inghilterra, 6.
Arrigo VIII, 276.
Arverni, 47.
Arx, 24.
Asburga, 230.
Ascoli, 42.
Asdrubale, 44.
Asia, 27, 30, 46, 51, 75, 81, 83, 212, 219, 231.
Asia minore, 21, 45, 50, 74.
Asiatici, 76.
Assietta (Colle dell’), 112.
Assisi, 255.
Asti, 115, 119, 158, 197, 204, 206, 208, 237, 266, 8, 9.
Astolfo, 123, 124, 129.
Atalarico, 108, 129.
Atanasio (sant’), 90.
Ataulfo, 84.
Atella, 9.
Atene, 50, 221.
Atene (il duca d’), 240.
Ateniesi, 40.
Atlante, 66.
Atlantico mare, 45.
Attalo, re, 46.
Attalo, imperatore, 84.
Attigny, 142.
Attila, 85, 103.
Augsburg, 179.
Augusto, 39, 49, 55, 65, 67, 68, 87, 88, 129, 184, 281, 17.
Augusto, elettor di Sassonia, 104, 105.
Augustolo, 104.
Aureliano, 74, 78.
Aurelio Claudio, 74.
Aurelio M., 71, 72, 78, 87.
Auriate, 115.
Ausonio, 88.
Ausonio (L’), giornale pubblicato dalla Belgioioso in Parigi, 200.
Austerlitz, 152, 153.
Austrasia, 106, 123.
Austria, 115, 192, 211, 231, 32, 67, 99, 100, 113, 114, 139, 143, 144, 151, 152, 158, 163, 201.
Austriaci, 102, 111, 145, 205, 214, 235.
Autari, 116, 117.
Avari, 118, 119.
Avignone, 241, 246, 247, 248, 72.
Avito, 85.
Azeglio (D’), 167, 200, 201.
Azio, 56.
Baal, 31.
Bacchiglione, 216.
Bacone Francesco, 280, 78.
Bade, 98.
Baduilla, 109.
Bagio, 167.
Baglioni (i), 7, 13, 14, 22.
Baglioni Malatesta, 26, 27.
Baglioni Pandolfo, 255.
Baiardo, 23.
Balbino, 73.
Balbo Ferdinando, 158.
Balbo Prospero, 142.
Balchignano, 201.
Baldinucci, 84.
Baldo, giureconsulto, 292.
Baldovino, conte di Fiandra, 217, 230.
Baleari, 47.
Balkano, 83.
Baltico, 103.
Bandinelli Baccio, 47.
Bandini, 274.
Bar, 105.
Barbavara, 256.
Barberini, vedi papa Urbano VIII.
Barberino, 259.
Barbiano, 255.
Barbo Pietro, vedi papa Paolo II.
Barcellona, 25, 96.
Barcellonetta, 98.
Bard, 146.
Baretti, 168, 173.
Bari, 143, 158, 105.
Barisone, 202.
Barnaba (san), 90.
Baroccio, 88.
Barricate (le), 108.
Bartoli Daniello, 83.
Bartolo, 289.
Bartolomeo da Cremona, 291.
Bartolomeo da San Concordio, 289.
Bartolomeo (fra), pittore, 294, 44.
Basilea, 262.
Basilio (san), 90.
Bassano, 137.
Bassano (i), 88.
Bassano (il), pittore, 46.
Bastelica (da) Sampiero, 90.
Bastia, 102.
Batavi, 70.
Battoni, 173.
Bautzen, 159.
Bava, 216, 217, 220.
Bavaresi, 150.
Baviera, 117,135, 137, 141, 151.
Baviera (l’elettor di), 96, 107.
Beatrice di Toscana, 164, 167.
Beatrice, moglie di Carlo d’Angiò, 225.
Beauharnais, vedi Eugenio Beauharnais.
Bec, 281.
Beccaria Cesare, 168.
Beccaria Giovanbatista, 172.
Belgi, 53.
Belgica provincia, 67.
Belgio, 221, 93, 133, 190.
Belgioioso, 200.
Belgrado, 99, 100.
Belisario, 108, 109, 110, 111, 128.
Bellini Giovanni, 45.
Bellini Vincenzo, 174.
Bellisle (cavaliere di), 112.
Bellosguardo, 85.
Belloveso, 27.
Belo, 31.
Bembo, II, 39.
Benedetto, papa, 154.
Benedetto VIII, papa, 157, 158.
Benedetto IX, papa, 161, 163, 164.
Benedetto X, papa, 235.
Benedetto XI, papa, 241.
Benedetto XIII, antipapa, 257, 262.
Benedetto XIII, papa, II, 103.
Benedetto XIV, papa, II, 117.
Beneventano (scrittore anonimo), 169.
Benevento, 42, 115, 119, 135, 146, 159, 160, 164, 177, 203, 226.
Bentivoglio (i), II, 7, 13, 14, 16.
Bentivoglio Giovanni, 255.
Bentivoglio Guido, cardinale, II, 84.
Benvenuti, II, 174.
Berengario I, 145, 146, 147, 148, 149.
Berengario II, 150, 151, 152.
Beresina, II, 158.
Bergamo, 114, 115, 146, 204, 208, 220.
Bernardino da Siena (san), 293.
Bernardo, figliuol di Pipino e nipote di Carlomagno, 140, 141, 142.
Bernardo (san), 193, 194, 195, 281.
Berni, 294; II, 39.
Bernino, II, 88.
Berta, moglie di Rodolfo di Borgogna, 150.
Berta, moglie d’Arrigo IV, 165, 179, 258.
Bertarido, 119.
Bertrando del Poggetto, card., 240.
Berwick, II, 96.
Betica provincia, 67.
Bianca, figliuola naturale di Filippo Maria Visconti, 266.
Bianchi, II, 190.
Bianchi (i), 229, 235, 236.
Bibbiena, II, 39.
Bicocca, II, 22.
Biondo, 255.
Biron, II, 59.
Bitinia, 49, 67.
Bitonto, II, 105.
BIandrate, 186.
Blenheim, II, 95.
Blois (trattato di), II, 11.
Bobbio, 127, 169.
Bovro, 124.
Boccaccio, 228, 246, 250, 288, 292; II, 36, 47, 89.
Boccalini, II, 83.
Bocco, 47.
Boezio, 107, 126.
Boi, 25.
Boileau, II, 79.
Bologna, 27, 194, 195, 204, 208, 218, 220, 224, 230, 236, 249, 254, 256, 281; II, 26, 31, 235.
Bolognesi, 223.
Bolsena (lago di), 108.
Bona, in Africa, II, 62.
Bona di Savoia, 273, 274.
Bonanno, 285.
Bonaparte, vedi Napoleone.
Bonario (Ludovico il), vedi Ludovico il bonario.
Bonarroti, vedi Michelangelo.
Bonaventura (san), 215, 281, 284; II, 89.
Bondi, II, 167.
Bonfadio, II, 39.
Bongartell Anichino, 250.
Bonifazio, conte di Lucca, 142.
Bonifazio, marchese di Toscana, 160, 164.
Bonifazio, conte di Savona, 258.
Bonifazio VIII, papa, 234, 235.
Bonifazio IX, papa, 252, 257.
Bonnivet, II, 23.
Borbone (il), principe, contestabile di Francia, II, 23, 24, 25.
Borboni (i), 193, 261; II, 100, 101, 154, 190, 232.
Borboni (de’) Carlo, vedi Carlo di Borbone.
Bordeaux, 232.
Borghese, vedi papa Paolo V.
Borghetto, II, 136.
Borghini, II, 38.
Borgia Cesare, II, 11, 12, 13, 14, 15.
Borgo (Del), II, 102.
Borgogna, 147, 148, 150, 160; II, 6.
Borgogna (duca di), 269.
Borgognoni, 85, 107, 109, 148.
Borromeo (san Carlo), II, 54.
Borromini, II, 88.
Bosforo, 215, 218, 249.
Bossi, II, 174.
Botero, 61, 83.
Botta d’Adorno, II, 111.
Botta Carlo, 210; II, 51, 62, 64, 68, 75, 92, 113, 123, 136, 167, 197.
Boucicault, 257.
Bourdaloue, II, 80.
Bovadilla, 296.
Bovines, 214.
Braccio da Montone, 257, 261, 262.
Bracciolini Francesco, II, 83.
Bracciolini Iacopo, 274.
Bracciolini Poggio, 292.
Brahama, 31.
Bramante, 294; II, 46.
Braschi, vedi papa Pio VI.
Breda, II, 112.
Bredulo, 115.
Brema, 165.
Brenta, 223.
Brenta (Val di), II, 137.
Brescello, 115.
Brescia, 27, 115, 118, 124, 146, 190, 199, 200, 204, 206, 208, 220, 222, 237, 256, 265; II, 16.
Bressa, II, 59.
Bretagna, II, 6.
Bricherasco, II, 112.
Brienne, II, 161.
Brigida (santa), 248, 289.
Brihuega, II, 97.
Brindisi, 219.
Brisgau (duca di), II, 163.
Brissac (citta), II, 90.
Brissac (capitano), II, 33.
Bristol, II, 42.
Britanni, 60.
Britannia, 22, 27, 53.
Britannico, 69.
Brixen, 180.
Broglia, 255.
Brun (Le), II, 145.
Brune, II, 148.
Brunelleschi Filippo, 293.
Brunetta (sette fratelli), II, 228.
Bruni Leonardo, 292.
Bruno Giordano, II, 86.
Brunswick (il), II, 25.
Bruto, 54, 57.
Bruzolo (trattato di), II, 60.
BuccelIino, 111.
Bugey, II, 59.
Bulgari, 107, 113.
Bulgaria, 212.
Bulgaro, 282.
Buoncompagni, vedi papa Gregorio XIII.
Buonconvento, 237.
Buoso da Doara, 224, 229.
Buoso Lucio, pisano, 284.
Burchiello, 292.
Burgundi, 101.
Burke, 58.
Burlamacchi, II, 30.
Buschetto, 170, 285.
Bussolari (De) Iacopo, 249.
Bussolengo, 219.
Bussone Francesco, vedi Carmagnola.
Byron, 83.
Cabotto Giovanni, 42, 89.
Cabotto Sebastiano, 42, 89.
Cadaloo, vescovo di Parma, 167.
Cadmo, 34.
Caffa, 249.
Cagli, 124.
Cagliari, 25, 126.
Cagnola, 174.
Caio, nipote di Augusto, 68.
Caio, vedi Caligola.
Caio Gracco, 47.
Calabria (duca di), vedi Carlo l’illustre.
Calabrie, 12, 153, 201.
Calcinato, 95.
Calderari, 189.
Calderon, 77, 84.
Caldiero, 151, 154, 160.
Caledoni, 69.
Caligola, 69.
Calisto I, papa, 191.
Calisto III, papa, 269.
Calvi, 167.
Calvi Bonaventura, 284.
Calvo (Carlo il), vedi Carlo il calvo.
Cambacérès, 145.
Cambiaso Luca, 88.
Cambrai (lega di), 15, 19.
Cambrai (trattato di), 25, 26, 34.
Cambrai (tregua di), 34.
Camerino, 115, 13, 30.
Camillo, 41, 175, 199.
Camiti, 21, 31.
Campanella, 86, 91.
Campani, 26, 41;
Campania, 51
Campidoglio, 29, 74, 247, 101.
Campoformio (trattato di), 140, 142.
Camposanto, 108.
Camuccini, 174.
Candia, 218, 50, 66, 67.
Can Grande della Scala, vedi Scala (Della).
Canning, 58.
Canossa, 151, 179, 182, 190.
Canova, 174, 197.
Cantacuzeno, 249.
Cantorbery, 281.
Capezi (i), 159.
Capo delle Tempeste o di Buona Speranza, 295, 5.
Capodimonte, 116.
Cappadocia, 49, 67, 69.
Cappello Bianca, 54.
Capponi Guido, 200.
Capponi Neri, 271.
Capponi Piero, 8.
Caprara, 90.
Caprario (monte), 125.
Capri, 69.
Capua, 44, 143, 160, 164, 177, 197, 142.
Caracalla, 72, 73, 184.
Caracci (i), pittori, 46.
Caracci Agostino, 87.
Caracci Annibale, 87.
Caracci Ludovico, 87.
Caraffa, vedi papa Paolo IV.
Caravaggio (da) Michelangelo, 88.
Caravaggio (da) Polidoro, 45.
Carbonari, 188.
Carbone, 50.
Cardona, avventuriero, 238.
Cardona (di) Raimondo, 16, 17.
Careggi (villa di), 17.
Cariati (principe di), 232, 233.
Cariddi, 158.
Carignano (principe di), 229.
Carino, 75.
Carintia, 145.
Carissimi, 88.
Carli, 171.
Carlo Martello, 122, 123.
Carlomagno, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 168, 175, 176, 231; II, 89, 123, 145, 177.
Carlo, primogenito di Carlomagno,136, 139, 141.
Carlo il calvo, figliuol di Ludovico il bonario, 142, 143, 144.
Carlo, figliuol di Lotario, 143.
Carlo, figliuol di Ludovico re diGermania, 144.
Carlo il grosso, 144.
Carlo IV, imperatore, 247, 250, 255, 260.
Carlo V, imperatore, 231; II, 19, 21,2 2, 25, 26, 27, 30, 33, 46, 178.
Carlo II di Spagna, II, 70, 72, 75, 93.
Carlo, arciduca d’Austria, re di Spagna, poi Carlo VI imperatore, II, 95, 96, 97, 102, 104, 107.
Carlo VII, re di Boemia e imperatore, II, 107, 110.
Carlo, arciduca d’Austria (maresciallo), II, 138, 143, 151.
Carlo I d’Angiò, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233; II, 179.
Carlo II d’Angiò, 233, 234, 236.
Carlo Martello, figlio di Carlo II d’Angiò, 236.
Carlo l’illustre, figlio di Roberto d’Angiò, 238.
Carlo III di Durazzo, 252.
Carlo il temerario, di Borgogna, 276.
Carlo VII di Francia, II, 6.
Carlo VIII di Francia, II, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 75, 106, 178.
Carlo di Borbone, duca di Parmae Piacenza, poi re di Napoli, poi Carlo III di Spagna, II, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 115, 116, 120.
Carlo Antonio di Borbone, poi Carlo IV di Spagna, II, 116.
Carlo I d’Inghilterra, II, 132.
Carlo II di Savoia, II, 7, 28.
Carlo III di Savoia, il buono, II, 28, 33.
Carlo Emmanuele I di Savoia, II, 58, 59, 60, 61, 64, 71, 74.
Carlo Emmanuele II di Savoia, II, 65, 66, 67, 74.
Carlo Emmanuele III di Savoia, II, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 125, 126.
Carlo Emmanuele IV di Savoia, II, 137, 142, 162.
Carlo Felice di Savoia, II, 191.
Carlo Alberto di Savoia, 129, 182; II, 56, 96, 136, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 200, 201, 206, 207, 213, 214, 216, 217, 220, 221, 223, 224.
Carlo I, duca di Mantova e Monferrato, vedi Gonzaga Carlo I.
Carlo II, vedi Gonzaga Carlo II.
Carlo III, vedi Gonzaga Carlo III.
Carlomanno, figlio di Pipino, 123, 124.
Carlomanno, figlio di Ludovico re di Germania, 144.
Carlowitz (pace di), II, 73.
Carmagnola (il), 251, 265.
Carnot, II, 134.
Caro, imperatore, 74, 75.
Caro Annibale, II, 40.
Carolina d’Austria, regina di Napoli, II, 116, 141, 142, 161.
Carolingi, 133, 141, 154; II, 177.
Carrara (da) Francesco, vedi Francesco Novello.
Carraresi (i), 238, 240, 254, 256, 267.
Cartagine, 33, 43, 44, 45.
Cartaginesi, 44, 46.
Casa (Della), II, 40.
Casalecchio, II, 15.
Casal Monferrato, II, 93.
Caserta, II, 116.
Cassano, 201, 225; II, 143.
Cassio, 54, 55.
Cassiodoro, 106, 116, 126, 129.
Castagna, vedi papa Urbano VII.
Castelfranco, 240.
Castel Gandolfo, II, 206.
Castel San Mariano, 124.
Castel Sussubio, 124.
Casti, II, 166.
Castiglia, 230, 233; II, 6.
Castiglia (almirante di), II, 69.
Castigliani, 40.
Castiglione, II, 137.
Castiglione Baldassar, 294.
Castriotto Giorgio, 269.
Castruccio Castracane, 238, 239, 244.
Cataio, 296.
Cateau-Cambrésis (pace di), II, 4, 34, 48, 50, 52.
Caterina da Siena (santa), 248, 289.
Catilina, 52.
Catone il vecchio, 44, 57, 88.
Catone uticese, 52, 53, 54.
Catullo, 57.
Caucaso, 51.
Caudine forche, 42.
Cavalca fra Domenico, 289.
Cavalcanti Guido, 289.
Cecco d’Ascoli, 289.
Celestino II, papa, 195.
Celestino III, papa, 212.
Celestino V, papa, 234.
Celio Secondo, II, 91.
Cellini Benvenuto, II, 25, 39, 47, 91.
Celti, 22, 31.
Celtiberi, 46, 54, 66.
Celtica regione, 22.
Celti-umbri, 22.
Celto-umbra lingua, 33.
Cencio o Crescenzio, 178.
Ceneda, 115, 240.
Ceresole, II, 28.
Ceri, 35.
Cerignola, II, 13.
Cervantes, 288; II, 39, 78, 84.
Cervia, II, 14.
Cervino, vedi papa Marcello II.
Cesalpini, II, 41.
Cesare G., 44, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 67, 88, 175.
Cesarea, 216.
Cesárea [Alessandria], 208.
Cesare Ottaviano, vedi Augusto.
Cesena, 124.
Ceva, II, 102.
Châlons, 85.
Champaubert, II, 161.
Chasles, 169.
Chatterton, II, 83.
Cherasco (trattato di), II, 65.
Cherasco (tregua di), II, 135.
Chiari, II, 94.
Chieri, 197, 258; II, 50.
Chigi, vedi papa Alessandro VII.
Childeberto, 116, 117.
Childerico, 123.
Chili, II, 203.
Chioggia, 207, 253.
Chisciotte (il Don), II, 78.
Chiusa (San Michele della), 125.
Chiusi, 28, 43, 115.
Choiseul, II, 120.
Ciacchi, cardinale, II, 205.
Cibo, di Genova, 295.
Cibo Franceschetto, 296.
Cicerone, 52, 53, 55, 56, 57, 88.
Ciceruacchio, II, 209.
Ciclopi, 22.
Cicognara, II, 168.
Cidna, 45.
Cieco (Francesco Landino detto il), vedi Landino Francesco.
Cilicia, 67, 70.
Cimabue, 285, 290.
Cimarosa, II, 174.
Cimbri, 27, 48, 105.
Cimmeri, 27, 48.
Cina, 23, 31, 215; II, 87.
Cinna, 50.
Cino da Pistoia, 289.
Cinzica Sismondi, 157.
Ciompi (i), 253, 263.
Cipriano (san), 90.
Cirenaica, 67.
Cirillo (san), 90.
Cisalpina repubblica, II, 139, 140, 148.
Cispadana repubblica, II, 137.
Cittá di Castello, II, 13.
Ciullo d’Alcamo, 284.
Cividal del Friuli, 113, 143.
Claudiano, 88.
Claudio, 69.
Claudio, pittore, II, 80.
Clefi, 114, 116.
Clemente (san), alessandrino, 90.
Clemente (san), papa, 90.
Clemente II, papa, 164.
Clemente III, papa, 212.
Clemente IV, papa, 225, 228.
Clemente V, papa, 235, 236, 238.
Clemente VI, papa, 246.
Clemente VII, antipapa, 252.
Clemente VII, papa, II, 22, 24, 25, 26, 27, 44.
Clemente VIII, papa, II, 62.
Clemente IX, papa, II, 67.
Clemente X, papa, II, 67.
Clemente XI, papa, II, 103.
Clemente XII, papa, II, 103.
Clemente XIII, papa, II, 117, 120, 121.
Clemente XIV, papa, II, 121.
Cleopatra, 54, 55, 56.
Clermont (concilio di), 183.
Clodoveo, 107, 133.
Cluny, 164.
Cobentzel, II, 140.
Coigny, II, 104.
Cola di Rienzo, 247, 248.
Cola Montano, 273.
Coleoni Bartolomeo, 266, 272.
Colombano (san), 127.
Colombo, medico, II, 41.
Colombo Cristoforo, 281, 291, 295, 296; II, 42, 89.
Colonia, 165.
Colonna (i), 235, 247, 262; II, 7, 13, 25.
Colonna Pompeo, II, 24.
Colonna Vittoria, II, 40.
Colonnesi (i), vedi Colonna (i).
Comacchio, 124.
Comagene, 67, 69, 70.
Comba, 125.
Comestore Pietro, 281.
Comines, 249.
Commodo, 72.
Como (cittá), 195, 197, 199, 204, 206, 208.
Como (lago), 152.
Compagni Dino, 234, 284.
Compiègne, 142.
Concini, II, 91.
Conquistatore (Guglielmo il), vedi Guglielmo il conquistatore.
Conti, vedi papa Innocenzo XIII.
Conti (principe di), II, 109.
Corboli Bussi, monsignore, II, 206.
Cordova, 141.
Corfinio [Italia], 49.
Corfú, II, 99.
Corinto, 45.
Cornaro Marco, 291.
Corneille, II, 79.
Cornelio Nipote, 57.
Cornelio P., vedi Scipione Africano.
Corniole (Dalle) Giovanni, II, 47.
Cornovaglia, 230.
Corradino, 224, 225, 226, 228.
Corrado di Franconia, imperatore, 159, 160, 161, 165.
Corrado, primogenito di Arrigo IV, 183, 187, 258.
Corrado II di Hohenstaufen, 191, 194, 196, 197.
Corrado, primogenito di Federigo II, 224.
Corsica, 22, 43, 45, 67, 104, 108, 135, 158, 190, 200; II, 55, 124, 133, 134.
Corsini, vedi papa Clemente XII.
Cortenuova, 222.
Cortona, 34.
Cortona (da) Pietro, II, 88.
Corvino Mattia, re d’Ungheria, 269.
Cosacchi, II, 157.
Costante, figlio di Costantino, 82.
Costante, imperator greco, 119.
Costantino, 75, 76, 79, 80, 81, 88, 91, 129.
Costantino, marito d’Irene imperatrice, 137.
Costantinopoli, 80, 83, 86, 91, 104, 126, 215, 217, 225, 232, 268.
Costanza, 197, 208, 209, 257, 262.
Costanza, figliuola di Ruggeri, 211, 212.
Costanza d’Aragona, 226, 231.
Costanzio, 82.
Costanzio Cloro, 75, 76.
Costanzio, giá capitano d’Onorio poi imperatore, 85.
Costanzo (di) Angelo, II, 39.
Crasso, 51, 52, 53.
Crema, 200, 201, 206, 211; II, 214.
Cremaschi, 200.
Cremona, 43, 143, 155, 161, 183. 190, 195, 199, 200, 201, 204, 206, 208, 256; II, 11, 223.
Cremonesi, 201, 211.
Crescenzio romano, 155.
Crescenzio, vedi Cencio.
Crescenzio Piero, 289.
Crespi, II, 173.
Crespy, II, 28.
Creta, 51.
Cristianesimo, 26, 77, 78, 79.
Cristiano, arcivescovo di Magonza, 205.
Cristina di Francia, moglie di Vittorio Amedeo I, II, 65, 66.
Cronaca (Il), II, 46.
Crotona, 24.
Crusca (accademia della), II, 82.
Cuba, 296.
Cuma, 25, 110.
Cunegonda, 158, 159.
Cuniberto, 119.
Cunimondo, 113.
Curione, II, 91.
Curtatone, II, 217.
Cusano, cardinale, 293.
Cusano (Da), 244.
Czartorinski, II, 152.
Daci, 70.
Dacia, 74, 83.
Da Farnese, vedi Farnese.
Dalmati, 55.
Dalmazia, 85, 104; II, 50, 73.
Damaso, papa, 164.
Dandolo Enrico, doge, 217, 269.
Danesi, 140.
Danimarca, 153, 214.
Dante, 78, 98, 196, 209, 225, 228, 229, 233, 234, 236, 238, 240, 241, 248, 250, 259, 279, 286, 287, 288, 290, 291; II, 47, 89.
Dante da Maiano, 284.
Danton, II, 91.
Danubio, 22, 26, 48, 66, 67, 71, 73, 74, 82, 107, 230.
Dati Carlo, II, 84.
Datto, 157, 158.
Davanzati, II, 38.
David, pittore, II, 174.
Davide, 77, 168.
Davila, II, 90.
Decio, imperatore, 73, 78.
Delfinato, II, 72, 96.
Delfini (i), 261.
Demarato, 57.
Demonte, 108.
Demostene, 58.
Denain, II, 98.
Denina, II, 126, 168, 173, 197.
Deodata, vedi Saluzzo Deodata.
Desaix, II, 147.
Descartes, 288; II, 79.
Desiderio, 124, 125, 126.
Deucalione, 23.
Deudch, 22.
Deutsch, 99.
Diana, 31.
Diaz, 295.
Didio Giuliano, 72.
Diedo, II, 171.
Digione, II, 145.
Diocleziano, 75, 76, 78, 80, 81, 89, 129.
Diodati, II, 91.
Dionisio alessandrino, 90.
Dionisio d’Alicarnasso, 24, 32.
Diotisalvi da Siena o Pisa, 285.
Dod, 22.
Dolci, II, 88.
Domenichino, II, 88.
Domenico (fra), compagno del Savonarola, II, 11.
Domenico (san), 214.
Domiziano, 70, 78.
Donatello, 293.
Dora (Val di), II, 146.
Doria Filippino, II, 25.
Doria Giannettino, II, 30.
Doria Paganino, 249.
Doria Percivalle, 256.
Drava, II, 160.
Dresda, II, 159.
Ducos, II, 145.
Duphot, II, 141.
Durando, II, 200, 218, 230, 233.
Durante, II, 174.
Durazzo, vedi Carlo III di Durazzo.
Dutillot, II, 124.
Ebrei, 77; II, 115.
Ebro, 140; II, 156.
Eckmüll, II, 154.
Edika, 103.
Edmondo, figliuolo del re d’Inghilterra, 224, 225.
Efrem (sant’), 90.
Egina, II, 73.
Egitto, 23, 45, 54, 55, 56, 67, 74, 81, 215; II, 87, 144.
Egizi, 31.
Egiziani, 215.
Elba, 112, 140, 148, 163.
Eleatica scuola, 34.
Eliogabalo, 73.
Elisi, 23.
Elitorio, 27.
Elleni, 23, 25, 28, 31; II, 175.
Ellenia, 22.
Ellenica lingua, 33.
Elvezia, 85; II, 145.
Emilia, 109; II, 108.
Emiliano, imperatore, 73.
Emmanuele Filiberto di Savoia, II, 33, 34, 50, 52, 56, 57, 58, 90.
Emo, 83.
Enea, 25.
Enghien (duca d’), II, 151.
Ennio, 57.
Enotri, 24.
Enrico, infante di Spagna, 295.
Enrico II di Francia, II, 27, 31, 34.
Enrico III, ultimo de’ Valois, II, 59.
Enzo, figlio naturale di Federigo II, 223, 226.
Epiro, 42.
Erchemperto, 169.
Ercolano, II, 116.
Ercole, 25.
Eritreo, 215.
Erlembardo, 167, 185.
Ermanno di Lorena, 180, 182.
Ermengarda, figlia di Desiderio, 124.
Ermengarda, moglie di Adalberto d’Ivrea, 149.
Erodoto, 24, 140.
Eruli, 103.
Esichio, 90.
Esiodo, 34, 280.
Este (casa d’), 151, 159, 165, 221, 238, 268, 272; II, 7, 13, 22, 61, 103.
Este (d’)Alfonso II, II, 51, 55, 61, 81.
Este (d’) Alfonso IV, II, 169.
Este (d’) Cesare, figliuol naturale d’Alfonso II, II, 61.
Este (d’) Ercole, 272, 274.
Este (d’) Ercole Rinaldo, II, 124, 163.
Este (d’) Francesco I, II, 67.
Este (d’) Francesco II, II, 67.
Este (d’) Francesco III, II, 103, 124.
Este (d’) Leonora, II, 81.
Este (d’) Luigi, cardinale, II, 81.
Este (d’) marchese, 222.
Este (d’) Niccolò, 272.
Este (d’) Rinaldo, figlio di Francesco II, II, 72, 103.
Estensi (gli), vedi Este (casa d’).
Etiopi, 66.
Etruria, 26, 31, 33, 35, 41, 50, 52.
Etruria antica, 28.
Etruria nuova, 27.
Etrusca lingua, 33.
Etrusci, 21, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 40, 59; II, 175.
Eufemio da Messina, 142, 143.
Eufrate, 51, 66, 67, 73, 76, 215.
Eugenio, imperatore, 84.
Eugenio III, papa, 195, 197.
Eugenio IV, papa, 262.
Eugenio Beauharnais, viceré d’Italia, II, 154, 159, 162.
Eugenio di Savoia, II, 94, 95, 96, 97, 99.
Eugubine tavole, 33, 34.
Eulero, II, 164.
Eurarico, 109.
Euridice (L’), musica del Peri, II, 88.
Europa, 21, 26, 30, 34, 48, 243; II, 130.
Eusebio (sant’), 90.
Eusino mare, 45, 48, 105.
Eutropio, 88.
Evandro, 25.
Eylau, II, 153.
Ezio, 85.
Ezzelini (gli), 221.
Ezzelino III, 222, 223, 224.
Fabi, 29.
Fabio Pittore, 57.
Facchinetti, v. papa Innocenzo IX.
Facino Cane, 256, 264.
Faenza, 109, 195, 208, 220, 276; II, 13.
Faggiola (della) Uguccione, vedi Uguccione della Faggiola.
Faleri, 34.
Falerio, 26.
Faliero Marin, 250.
Fano, 121, 124.
Fantoni, II, 167.
Fantuzzi, II, 170.
Farini, II, 231.
Farnese (Da), 255.
Farnese Alessandro, vedi papa Paolo III.
Farnese Alessandro, figliuolo d’Ottavio, II, 61, 62, 90.
Farnese Antonio, II, 103.
Farnese Elisabetta, II, 99, 112.
Farnese Francesco, figliuolo di Ranuccio II, II, 72, 99, 103.
Farnese Odoardo, II, 62, 66, 67.
Farnese Ottavio, II, 30, 51, 55, 61.
Farnese Pier Luigi, II, 28, 30.
Farnese Ranuccio I, II, 62.
Farnese Ranuccio II, II, 67.
Faro di Messina, 212, 218.
Farsaglia, 54.
Fattorino (il), vedi Penni.
Federigo, re dei rugi, 104.
Federigo di Hohenstaufen, nipote di Arrigo V, 191.
Federigo I, detto Barbarossa, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 221, 247; II, 179.
Federigo II d’Hohenstaufen, 211, 212, 213, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 284.
Federigo I d’Aragona, re di Sicilia, 234, 235, 257.
Federigo II d’Aragona, re di Sicilia, 258.
Federigo d’Aragona, re di Napoli, figlio di Ferdinando I, II, 9, 12.
Federigo d’Austria, figlio d’Alberto d’Austria, 239.
Federigo III d’Austria, imperatore, 266, 268; II, 7.
Federigo, duca d’Urbino, 274.
Federigo II di Prussia, detto il grande, II, 107, 108, 109, 110.
Federigo Augusto di Sassonia, II, 103.
Federigo Guglielmo, re di Prussia, II, 107.
Fedro, 87, 88.
Felice V, antipapa, vedi Amedeo VIII di Savoia.
Felsina [Bologna], 27.
Fénélon, 288.
Fenici, 43, 215.
Fenicia, 23, 34, 215.
Ferdinandei, II, 189.
Ferdinando, principe di Castiglia, 258.
Ferdinando I d’Aragona, re di Napoli, 270, 272, 275, 276; II, 8.
Ferdinando II d’Aragona, re di Napoli, II, 9.
Ferdinando il cattolico, 276; II, 6, 7, 12, 14, 15, 19, 178.
Ferdinando I d’Austria, imperatore, II, 33, 34.
Ferdinando VI di Borbone, re di Spagna, II, 112, 116.
Ferdinando IV, poi I, di Borbone, re delle Due Sicilie, II, 116, 142, 160, 163.
Ferdinando II di Borbone, re delle Due Sicilie, II, 208, 209, 232, 233.
Ferdinando di Borbone, duca di Parma e Piacenza, II, 123, 124.
Ferdinando di Baviera, II, 93.
Ferdinando III di Lorena, granduca di Toscana, II, 123, 163.
Fernando il cattolico, vedi Ferdinando il cattolico.
Ferrara, 204, 224, 272, 275; II, 13, 51.
Ferrara (cittadella di), II, 205.
Ferrari Gaudenzio, II, 43.
Ferreri Vincenzo (san), 292.
Ferretti, cardinale, II, 205.
Feticismo, 30.
Feuillade (La), II, 95.
Fiandra, 217.
Fiandre, II, 34.
Fibonacci Leonardo, 169, 291.
Ficino, II, 17.
Fieschi (i), 253.
Fieschi Luigi, II, 30.
Fiesole, 34, 109.
Filelfo Francesco, 293.
Filiasi, II, 171.
Filiberto II il bello di Savoia, II, 28.
Filicaia, II, 83.
Filippa, figlia di Palestrello, moglie del Colombo, 295.
Filippi, 55.
Filippine, II, 179.
Filippo, re di Macedonia, 45.
Filippo, imperatore romano, 73.
Filippo di Svevia, fratello d’Arrigo VI, figliuolo di Federigo I, 213.
Filippo il bello, re di Francia, 235.
Filippo di Valois, 238.
Filippo I di Savoia, nipote d’Amedeo V, 259.
Filippo II di Savoia, II, 28.
Filippo II, re di Spagna, II, 33, 34, 50, 53, 64, 93.
Filippo III, II, 64.
Filippo V, II, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 112.
Filippo di Borbone, duca di Parma e Piacenza, II, 107, 108, 112, 123.
Fiorentini, 238, 248, 257, 274; II, 10, 26.
Firenze, 115, 143, 157, 180, 190, 195, 223, 225, 228, 234, 235, 237, 238, 240, 245, 247, 248, 249, 251,253, 256,257, 262, 277; II, 8, 9, 16, 18, 22, 26, 27, 144, 216.
Firmian (conte di), II, 127.
Flavi (i tre), 70.
Flavio Vespasiano, vedi Vespasiano.
Floriano, imperatore, 74.
Foglietta, II, 39.
Foix, 58.
Foix (di) Gastone, II, 16.
Folchetto, 284.
Foligno, 294; II, 13.
Fontainebleau, II, 155.
Fontenay, 143.
Forlí, 124, 195, 205; II, 13.
Forlimpopoli, 124.
Formoso, papa, 147.
Fornovo, Il, 9.
Foro Giulio, 113, 115.
Forteguerri Niccolò, II, 165.
Foscari Francesco, doge, 269.
Foscari Iacopo, 269.
Foscarini, II, 168.
Fox, 58.
Francesca (La), tragedia di Silvio Pellico, II, 199.
Francesco (san), 214, 284.
Francesco I, re di Francia, II, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 46.
Francesco da Barbarino, 289.
Francesco di Giorgio, sanese, 293.
Francesco di Puglia, francescano, II, 10, 11.
Francesco I, duca di Lorena, poi imperatore, II, 105, 106, 110, 122, 127.
Francesco II d’Austria, II, 133, 152, 153.
Francesco, arciduca d’Austria, duca di Modena, II, 163.
Francesco Giacinto di Savoia, figliuolo di Vittorio Amedeo I, II, 65.
Francesco Novello di Carrara, 253, 254, 256.
Francesi, 103, 213, 217, 226, 232, 233, 284; II, 9, 12, 28, 58, 61, 65, 77, 96, 112, 134, 135, 160.
Franchi, 74, 82, 101, 103, 107, 109, 110, 119.
Franchi muratori, II, 187.
Francia, 135, 136, 141, 145, 203, 214, 233, 297; II, 16, 32, 60, 113, 114, 144, 145, 151, 191, 210.
Francia (il), pittore e incisore, II, 44, 47, 87.
Franco bolognese, 290.
Franconi imperatori, 159, 165, 180, 191, 231.
Franconia, II, 96.
Frassineto, 148, 150
Freducci (i), II, 13.
Fregosi (i), 253.
Fréjus, II, 146.
Friedland, II, 153.
Friuli, 118, 136, 143, 146, 199.
Frontino, 88.
Frontone, 88.
Frugoni, II, 167.
Fruttuaria (abazia di), 158.
Furio Camillo, vedi Camillo.
Fust, 294.
Gabrino Fondolo, 256.
Gaddi (i), 290.
Gaddi Taddeo, 290.
Gaforio Franchino, II, 47.
Gages, II, 109.
Galata, 225, 249.
Gaiba, 69.
Galeotti, II, 200.
Galerio, 76, 79.
Galiani Ferdinando, II, 168.
Galiate, 197.
Galileo, II, 78, 79, 84, 85, 86, 172, 179.
Galli, 27, 28, 29, 30, 32, 40, 41, 43, 45, 66, 106; lI, 175.
Gallia, 22, 27, 48, 74, 75, 81, 84, 107.
Gallia cisalpina, 28, 44, 53, 55.
Gallia transalpina, 44, 55.
Gallieno, 73, 74.
Gallizia, II, 156.
Gallo, imperatore, 63.
Gallo, cesare con Costanzio, 82.
Galluppi, II, 174.
Galvani, II, 172.
Gambacorta Pietro, 255, 257.
Ganganelli, vedi Clemente XIV.
Garda, II, 219.
Garda (lago di), 152; II, 137, 216.
Gargano (monte), 158.
Garibaldo, re longobardo, 119.
Garigliano, II, 13.
Garona, 107.
Gastone di Foix, vedi Foix.
Gavinana, II, 26.
Gelasio II, papa, 191.
Gengis Khan, 222, 291.
Genova, 115, 119 203, 205, 208, 212, 215, 222, 224, 230, 237, 240, 249, 253, 255, 264, 271, 272, 277, 295, 296; II, 16, 30, 50, 51, 55, 60, 67, 71, 102, 109, 111, 112, 124, 125, 139, 151, 162, 163, 203.
Genovesi, 158, 200, 216, 217, 225, 233, 249, 253, 274, 112, 125, 203, 229.
Genovesi Antonio, II, 168.
Genserico, 85.
Gentile Girolamo, 272.
Genzano, II, 109.
George, II, 151.
Gepidi, 107, 113.
Geraci (i), II, 68.
Gerberto, papa, vedi Silvestro II.
Germani, 53, 66, 70, 82, 99.
Germania, 27, 53, 67, 84, 85, 112, 114, 137, 138, 143, 145, 148, 151, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 178, 179, 180, 182, 183, 190, 191, 194, 196, 197, 198, 202, 203, 208, 213, 218, 222, 226, 231; II, 7, 93, 191.
Germanico, 69.
Germani el vetici, 53.
Gerosolimitani cavalieri, 236.
Gerusalemme, 70, 183, 211, 212, 216, 219, 220.
Gerusalemme (La) del Tasso, II, 81.
Gesú Cristo, 77, 89.
Gesuiti, II, 118, 119, 120, 121, 206, 230.
Geta, 72.
Geti, 27.
Ghiara d’Adda, II, 11.
Ghibellini (casa dei), vedi Franconi.
Ghibellini secondi (casa dei), vedi Hohenstaufen.
Ghibellini (partito politico), 213, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 230, 231, 234, 236, 237, 239, 240.
Ghiberti Lorenzo, 293.
Ghiberto, arcivescovo di Ravenna, antipapa, 180, 182.
Ghirlandaio (il), 293; II, 44.
Ghisilieri Guido, 284.
Ghisilieri, vedi papa Pio V.
Giaccaldi, II, 103.
Giacomo d’Aragona, re di Sicilia, 233.
Giacomo d’Aragona, marito di Giovanna I, 246, 247.
Giacomo II, re d’Inghilterra, II, 119.
Giaffa, 216.
Giambullari, II, 39.
Gian Francesco II di Monferrato, II, 7.
Giannone Pietro, II, 126, 168.
Giano, 31.
Giapetici, 21, 31, 101; II, 27.
Giaveno, 125, 259.
Ginevra (lago di), 259; II, 146.
Gioacchino Murat, vedi Murat Gioacchino.
Gioberti Vincenzo, II, 76, 167, 200, 201.
Giocondo (fra), II, 46.
Gioia Flavio, d’Amalfi, 291.
Gioia Melchiorre, II, 168.
Giordano Luca, II, 88.
Giorgio di Venezia, 284.
Giorgio I di Hannover, II, 99.
Giorgione, 294; II, 46.
Giornico, 274.
Giotto, 228, 250, 285, 290, 292.
Giovanna I, regina di Napoli, 246, 247, 252.
Giovanna II, 262.
Giovanna d’Austria, moglie di Francesco I di Toscana, II, 54.
Giovanni, imperatore romano, 85.
Giovanni (fra) da Vicenza, 222.
Giovanni I, papa, 107.
Giovanni VIII, papa, 144.
Giovanni X, papa, 148.
Giovanni XI, papa, 150.
Giovanni XII, papa, 152, 154.
Giovanni XIII, papa, 154.
Giovanni XVI, papa, 155.
Giovanni XIX, papa, 160.
Giovanni XXI, papa, 231.
Giovanni XXII, papa, 238,239,241.
Giovanni XXIII, papa, 257.
Giovanni Crisostomo (san), 90.
Giovanni da Pian Carpino, 291.
Giovanni d’Aragona, 272.
Giovanni da Procida, 232.
Giovanni d’Austria, figlio naturale di Carlo V, II, 53.
Giovanni di Nicola, architetto e scultore, 290.
Giovanni, re di Boemia, il venturiero, 240, 244, 247.
Giovanni II, re di Portogallo, 296.
Giovanni, figliuolo di Guglielmo di Monferrato, 259.
Giovanni d’Aragona, fratello d’Alfonso il magnanimo, 270.
Giovanni (ser) fiorentino, 292.
Giove, 31.
Giovenale, 88.
Gioviano, imperatore, 82.
Giovio Paolo, II, 39.
Giraldi Cinzio, II, 48.
Girgenti, 25.
Girolamo (san), 90.
Gisela, figlia di Carlomagno, 145.
Giudea, 67, 69, 77.
Giudei, 70.
Giuditta de’ Guelfi Estensi, 196.
Giugurta, 47.
Giulia, figlia di Augusto, 68.
Giuliano l’apostata, 82, 88.
Giulini, II, 171.
Giulio II, papa, II, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 36, 45, 62.
Giulio III, papa, II, 32.
Giulio romano, II, 45.
Giunone, 31.
Giunta pisano, 285.
Giuseppe I, imperatore, II, 95, 97.
Giuseppe II, imperatore, II, 123, 124, 127.
Giuseppe Bonaparte, II, 141, 153, 154, 161.
Giustiniani (i), II, 55.
Giustiniano, 108, 112, 128, 129.
Giustino, scrittore, 88.
Giustino (san), 90.
Giustino, imperatore, 108.
Giustino II, 112.
Gizzi, cardinale, II, 203, 205.
Glaucia, 48.
Glicerio, imperatore, 86.
Godeberto, 119.
Goethe, II, 164.
Goffredo di Lorena, 164, 166, 167.
Gog, 27.
Goito, II, 214, 217, 218, 222, 225, 233.
Golfo persico, vedi Persico golfo.
Gomer, 27, 48.
Gondi, II, 90.
Gonsalvo di Cordova, II, 10, 12, 13, 14.
Gonzaga (i), 249; II, 7, 28, 60, 61.
Gonzaga Carlo I, duca di Nevers, poi duca di Mantova, II, 61, 65, 67.
Gonzaga Carlo II, II, 67.
Gonzaga Carlo III, II, 67, 71, 73, 94, 96.
Gonzaga Federico, marchese, poi duca di Mantova, II, 26.
Gonzaga Ferdinando, cardinale e duca, II, 60, 61.
Gonzaga di Nevers Ferdinando, II, 93.
Gonzaga Ferrante, governatore di Milano, II, 30.
Gonzaga Francesco I, II, 9.
Gonzaga Francesco II, II, 60.
Gonzaga Guglielmo, duca di Mantova e Monferrato, II, 51, 55, 60.
Gonzaga Vincenzo, figlio di Guglielmo, II, 60.
Gonzaga Vincenzo, fratello del cardinal Ferdinando, II, 60, 61.
Gordiano I, imperatore, 73.
Gordiano II, imperatore, figlio del precedente, 73.
Gordiano III, imperatore, figlio del precedente, 73.
Goti, 74, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 126.
Gottolengo, 265.
Governolo, II, 220.
Gozzi Gaspare, II, 166.
Gracchi (i), 47.
Granata, 296; II, 6.
Granata (trattato di), II, 12.
Gravina Gian Vincenzo, II, 84.
Graziano, imperatore, 82.
Greci, 42, 45, 60, 109, 110, 111, 114, 215, 217, 250, 292.
Grecia, 21, 32, 34, 35, 43, 44, 50, 84, 95; II, 87.
Gregorio (san) nazianzeno, 90.
Gregorio (san) nicearco, 90.
Gregorio (san) taumaturgo, 90.
Gregorio I (san) il magno, papa, 117, 126, 127, 128, 230.
Gregorio II, papa, 121, 184, 230.
Gregorio III, papa, 121, 122.
Gregorio IV, papa, 143.
Gregorio V, papa, 155.
Gregorio VI, papa, 163, 164, 175.
Gregorio VII, papa, 164, 167, 170, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 187, 190, 195, 208, 214, 230, 234, 279, 281; II, 21, 22, 89, 122, 177, 231.
Gregorio VIII, papa, 212.
Gregorio IX, papa, 219, 222.
Gregorio X, papa, 229, 230, 231.
Gregorio XI, papa, 252.
Gregorio XII, papa, 257, 262.
Gregorio XIII, papa, II, 54, 62, 122.
Gregorio XIV, papa, II, 62.
Gregorio XV, papa, II, 62.
Gregorio XVI, papa, II, 191, 201.
Greppi (palazzo), II, 224.
Grigioni, 206.
Grigioni (i), II, 60.
Grimoaldo, 119.
Grossi, II, 167.
Guarini, architetto, II, 88.
Guarini Giambattista, II, 83.
Guarnieri (duca), 244, 246, 250.
Guastalla, II, 165.
Gubbio, 110, 124.
Guelfi (famiglia), 165, 166.
Guelfi (partito politico), 211, 213, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240.
Guelfi (setta del principio dell’Ottocento), II, 189.
Guelfo, di casa d’Este, duca di Baviera, 165.
Guelfo d’Este, figlio del precedente, 182.
Guelfo d’Este, fratello di Arrigo il superbo, 194.
Guercino, II, 88.
Guglielmi, II, 174.
Guglielmo, duca d’Aquitania, 159.
Guglielmo I Normanno, detto il cattivo, re di Napoli, 198, 199, 203.
Guglielmo II, il buono, 203, 211, 212.
Guglielmo, marchese di Monferrato, seniore, 259.
Guglielmo, marchese di Monferrato, iuniore, 272.
Guglielmo il conquistatore, 281.
Guicciardini, 294; II, 29, 37, 38.
Guidi Alessandro, II, 83.
Guidiccioni, II, 39.
Guido, duca di Spoleto, poi imperatore, 146, 147.
Guido, marchese di Toscana, 149.
Guido, figliuolo di Berengario secondo, 152.
Guido da Siena, 285.
Guido di Champeaux, 281.
Guido di Monforte, 229.
Guidotto da Bologna, 284.
Guinicelli Guido, 284.
Guinigi Paolo, 255.
Guisa (duca di), II, 34.
Guisa (duca di), iuniore, II, 69.
Guitton d’Arezzo, 289.
Gundeberga, 118.
Guttemberg, 294.
Hanau, II, 160.
Hannover, II, 98.
Hannover (casa d’), II, 101.
Harvey, II, 41.
Hawkwood Giovanni, II, 250, 254, 255.
Heerman, 67.
Himmelauer, II, 229.
Hoche, II, 133.
Höchstädt, II, 95.
Hogard, II, 174.
Hohenlinden, II, 147.
Hohenstaufen (casa e imperatori di), 180, 192, 194, 196, 209, 211, 213, 219, 224, 225, 226, 231.
Iacopo, giureconsulto, 282.
Iacopone (fra) da Todi, 289.
Iamsilla (di) Niccolò, 284.
Iaoni, 21.
Iavan, 31.
Iavani, 21.
Iberi, 22.
Iberia, 22, 33, 43.
Iberica lingua, 33.
Iberici, 22, 31.
Iberici itali, 28; II, 175.
Icona, 212.
Jemmapes, II, 133.
Jena, II, 153.
Iesi, 124.
Ignazio (sant’) martire, 90.
Ignazio (sant’) di Loyola, II, 31, 118.
Ilario (sant’), 90.
Ildebrando, re longobardo, 123.
Ildebrando, vedi papa Gregorio VII.
Ildibaldo, re goto, 109.
Illiria, 21.
Illirici, 22.
Illirico, 67, 75.
Illirio, 42, 43, 45, 53, 81, 83, 216; II, 152, 156.
Illuminati (setta), II, 187.
Imola, 115, 195, 205; II, 13.
India, 23.
Indie (Nuove), 296.
Indo, 27, 42.
Ingendbund (setta dell’), II, 187.
Inghilterra, 46, 117, 127, 203, 214, 221, 297; II, 16, 114, 128, 143, 151.
Inglesi, 59, 213; II, 6, 95, 152, 160.
Innocenzo II, papa, 192, 193, 195.
Innocenzo III, papa, 212,213, 214, 215, 216, 281; II, 21.
Innocenzo IV, papa, 222, 223, 224; II, 21.
Innocenzo V, papa, 231.
Innocenzo VI, papa, 247, 248.
Innocenzo VII, papa, 257.
Innocenzo VIII, papa, 275, 276; II, 7.
Innocenzo IX, papa, II, 62.
Innocenzo X, papa, II, 67.
Innocenzo XI, papa, II, 72, 73.
Innocenzo XII, papa, II, 73.
Innocenzo XIII, papa, II, 103.
Insubri, 22.
Insubria, 26, 27, 32, 115.
Joinville, 284.
Iolanda di Lusignano, moglie di Federigo II di Hohenstaufen, 218, 219.
Ioni, 21.
Ionie isole, II, 99.
Ionio mare, 21.
Iornandes, 126.
Jourdan, II, 143.
Irene, imperatrice d’Oriente, 137.
Ireneo (sant’), 90.
Irlanda, 127, 280.
Irnerio, 282.
Isabella, regina d’Aragona e Castiglia, 297; II, 6.
Isabella d’Aragona, moglie di Gian Galeazzo Sforza, II, 7.
Isacco, imperatore greco, 217.
Isauria, 51.
Isaurico, vedi Leone isaurico.
Islanda, 296.
Istria, 45, 123; II, 50.
Isumbri, 22.
Itali, 22, 25, 26, 28, 33, 106; II, 175.
Italia (cittá) [Corfinio], 49.
Italia (viceré d’), vedi Eugenio Beauharnais.
Italica scuola, 34.
Italici, 31.
Juanez Juan, II, 78.
Iupiter, vedi Giove.
Ivrea, 115, 143, 147, 160; II, 23, 146.
Kant, II, 164.
Kauffmann Angelica, II, 174.
Kelti, 22.
Keplero, II, 79.
Kettim, 22.
Kimri, 27, 48, 105.
Klagenfurth, II, 138.
Königseck, II, 165.
Ladislao, re di Napoli, 252, 257, 260, 261, 262.
Lago Maggiore, 206.
Lambertini, vedi papa Benedetto XIV.
Lamberto, figliuolo del gia duca, poi re e imperatore Guido, 146, 147, 148.
Lampugnani, 273.
Lancastro (fazione di), II, 6.
Landau, II, 133.
Landi, II, 174.
Landino Francesco, detto il Cieco, II, 47.
Lando (conte), 250.
Lando Michele, 253.
Landolfo, ultimo duca di Benevento, 177.
Lanfranco di Pavia, 170, 281; II, 89.
Langhe (le), II, 105.
Lanini Bernardino, II, 43.
Lannes, II, 146.
Lanzone, 162, 185, 198.
Laodicea, 216.
Lars, 26.
Latina lingua, 33.
Latini, 26, 28, 33, 217.
Latini Brunetto, 280, 284, 289.
Lattanzio, 90.
Lautrec, II, 25.
Lebret, II, 171.
Lechi, 22.
Leck, II, 143.
Leczinzki Stanislao, II, 104, 105.
Leganes, II, 65.
Leo, storico, 165.
Leo Leonardo, maestro di musica, II, 174.
Leoben, II, 139.
Leonardo da Vinci, 294; II, 39, 43, 84.
Leone I (san), papa, 85, 90.
Leone III, papa, 137.
Leone IV, papa, 143.
Leone VIII, papa, 152, 154.
Leone IX, papa, 164.
Leone X, papa, 281; II, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 36, 45.
Leone XI, papa, II, 62.
Leone Isauro, iconoclasta, 121, 122.
Leonina citta, 143.
Leopoldo I d’Austria, imperatore, II, 93, 95.
Leopoldo d’Austria, I come granduca di Toscana e II come imperatore, II, 122, 123, 133.
Leopoldo II, granduca di Toscana, II, 189.
Lepanto, II, 53, 55, 57, 62, 90.
Lepido, 55.
Lerma (duca di), II, 64.
Lesdiguières, II, 59.
Lessing, II, 164.
Lestrigoni, 22.
Lesueur, II, 80.
Leutari, 111.
Licia, 67, 69, 70.
Licinio, 79.
Licurgo, 129; II, 130.
Lidia, 21.
Ligi, 22.
Ligure repubblica, II, 139, 142, 150.
Liguri, 22, 25, 26, 27, 33, 283.
Liguria, 45, 109, 115.
Liguri taurini, 27.
Lilibeo, 67.
Limmath, II, 143.
Lione, 222; II, 59, 60, 134, 148.
Lippi fra Filippo, 293.
Lippi Lorenzo, II, 83.
Liri, 26.
Lisbona, 295.
Liutberto, 119, 120.
Liutprando, re, 120, 122, 123, 129.
Liutprando, vescovo, 154, 169.
Liutulfo, 151.
Livia, moglie di Augusto, 68.
Livio Andronico, 57.
Livio Severo, imperatore, 85.
Loano, II, 135.
Lobkowitz, II, 109.
Loches, II, 12.
Locri, 25.
Lodi, 183, 190, 197, 199, 204, 208, 220, 256.
Lodigiani, 199.
Loiera, 249.
Loiola (di) sant’ Ignazio, vedi Ignazio (sant’) di Loyola.
Lombarda lega prima, 204,205,206, 207, 208; II, 20.
Lombarda lega seconda, 220, 222, 223, 225.
Lombardi, 179, 206; II, 215, 229.
Lombardia, 149, 166, 199, 205, 219, 220, 222, 225, 228, 238, 255; II, 19.
Lombardo-Veneto, II, 103, 179, 190, 196.
Lomellina, II, 95.
Lonato, II, 137.
Longobardi, 100, 103, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 159, 185; II, 177.
Lope de Vega, vedi Vega (de) Lope.
Lorena, 165, 167; II, 105.
Lorena (casa di), II, 106.
Lorenzino, vedi Medici (de) Lorenzino.
Loreto, II, 83.
Loria (di) Ruggeri, 232, 233.
Los Velez, viceré di Sicilia, II, 68.
Lotario, figlio di Ludovico il bonario, 141, 142, 143.
Lotario, figliuolo del precedente, 143.
Lotario II, figliuolo di re Ugo, 149, 150.
Lotario di Suplinburga, 192, 193, 194, 196.
Lucani, 41.
Lucano, 88.
Lucca, 115, 157, 167,190, 195, 205, 239, 257, 272, 277; II, 30, 51, 151, 163, 164, 207.
Lucca (duca di), II, 163, 207.
Lucemburgo, vedi Arrigo VII.
Luceolo, 124.
Lucera, 218, 224.
Lucio, nipote di Augusto, 68.
Lucio II, papa, 195, 212.
Lucrezio, 57.
Lucullo, 51, 52, 104.
Lucumoni etruschi, 26.
Ludovico il bonario, 136, 141, 142, 145,
Ludovico, figlio di Ludovico il bonario, 142, 143, 144.
Ludovico II, figliuolo di Lotario, 143.
Ludovico, re di Borgogna, 148.
Ludovico di Baviera, imperatore, 239, 244, 248.
Ludovico di Savoia, figliuolo d’Amedeo VIII, 261.
Ludovico XIV, vedi Luigi XIV.
Ludovisi, vedi papa Gregorio XV.
Lugdunese provincia, 67.
Luigi, fratello di Carlo il grosso, 144.
Luigi di Savoia, 272.
Luigi di Taranto, 246.
Luigi, marchese di Mantova, 272.
Luigi, re d’Ungheria, 246.
Luigi I, figlio del re di Francia, e nuovo duca d’Angiò, 252.
Luigi II d’Angiò, 252, 257, 260, 261.
Luigi III d’Angiò, 262.
Luigi d’Aragona, figliuolo di Pietro II, 257.
Luigi (san) IX, re di Francia, 223, 225, 227, 229.
Luigi XI, 254, 276; II, 6.
Luigi XII, II, 11, 12, 15, 16, 18, 179.
Luigi XIV, 279; II, 17, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 79, 93, 94, 97, 98, 99.
Luigi XVIII, II, 162.
Luigi Bonaparte, II, 153.
Luigia di Savoia, II, 25.
Luini, II, 43.
Lumello, 115.
Lunéville (pace di), II, 148.
Luni, 158.
Lunigiana, 255.
Lupi, 170.
Lusignano (di) Guido, 219.
Lusitani, 50.
Lusitania, 51, 52, 67.
Luzzara, II, 94.
Macaulay, II, 31.
Macedonia, 45, 67, 81.
Machiavello, 39, 129, 196, 210, 294; II, 13, 17, 23, 26, 27, 35, 36, 37, 42, 169.
Mack, 142.
Maclodio, 265.
Macra, 26.
Macrino, 72, 73.
Macrobio, 88.
Madonna dell’Olmo (battaglia della), II, 108.
Madrid, II, 64.
Maffei Scipione, II, 165, 168.
Magalotti, II, 84.
Magiari, 148; II, 107.
Maginfredo, conte e marchese di Torino, 159.
Magiorano, 85.
Magna Grecia, 25, 34, 35.
Magnanimo (Alfonso il), vedi Alfonso V d’Aragona.
Magnenzio, 82.
Magnesia, 45.
Magno greci, 25, 28, 42.
Magog, 27.
Magra, II, 109.
Maiano (da) Dante, vedi Dante da Maiano.
Maillebois, II, 109, 110, 111.
Maiorca (re di), 247.
Maira, II, 61.
Malaspina, marchese, 203, 204.
Malaspini Ricordano, 284.
Malatesta, 255.
Malatesta (i), 256; II, 13.
Malebranche, II, 79.
Malherbe, II, 79.
Malojaroslavetz, II, 158.
Malpighi, II, 84.
Malplaquet, II, 97.
Malta, II, 57.
Mamiani, II, 231.
Mancini, II, 90.
Manfredi, re di Napoli, 224, 225, 226.
Manfredi (i), II, 13.
Manfredi Astorre, 276.
Manfredi Eustachio, II, 167, 172.
Manfredi Galeotto, 276.
Manfredonia, 246.
Manica, II, 151.
Mantegna Andrea, 293; II, 45, 47.
Mantova, 115, 182, 204, 220, 275; II, 31, 51, 60, 61, 136, 217.
Mantova (marchese di), capo della lega contro Carlo VIII, vedi Gonzaga Francesco.
Manuzio Aldo, 294.
Manzoni, 115, 288; II, 41, 64, 198.
Maomettani, 120, 219, 297.
Maometto II, 268.
Maramaldo, II, 27.
Maratta Carlo, II, 88.
Marboeuf, II, 125.
Marcello, maestro di musica, II, 174.
Marcello II, papa, II, 32.
Marche, 205; II, 154.
Marchi (De’), II, 46.
Marcomanni, 72, 101.
Marcovaldo, 214.
Marengo, 147; II, 147.
Margaritone d’Arezzo, 285.
Margherita d’Austria, duchessa di Savoia, II, 25.
Margherita d’Austria, moglie di Alessandro de’ Medici, poi di Ottavio Farnese, II, 30.
Maria d’Aragona, figliuola di Federigo II d’Aragona, regina di Sicilia, 257.
Maria Cristina, regina di Spagna, II, 203.
Maria Giovanna di Savoia, II, 71.
Maria Luisa di Savoia, moglie di Filippo V, II, 99.
Maria Luisa d’Austria, II, 156, 163.
Mariana, II, 78.
Maria Teresa d’Asburga, moglie di Luigi XIV, II, 93.
Maria Teresa, imperatrice, II, 102, 105, 107, 108, 110, 127.
Marignano, II, 19.
Marignano (Medici, marchese di), II, 90.
Marin, II, 171.
Marini Gaetano, II, 170.
Marino Giambattista, II, 61, 83.
Mario, 47, 48, 49, 50.
Mariuccia, vedi Marozia.
Marmirolo, II, 220.
Marmont, II, 161.
Mar Nero, 190.
Marozia, 149, 150, 163.
Marsi, 26.
Marsigli, conte bolognese, II, 90.
Marsiglia, 47; II, 23, 27, 59, 133.
Marsin, II, 95.
Martino, giureconsulto, 282.
Martino IV, papa, 233.
Martino V, papa, 262.
Martino d’Aragona il giovane, re di Sicilia, 257, 258.
Martino d’Aragona il vecchio, re d’Aragona e di Sicilia, 258.
Marziale, 88.
Marzuflo, 217.
Masaccio. 293.
Masaniello, II, 69.
Mascagni, II, 172.
Mascheroni, II, 172.
Masenzio, 79.
Massa, vedi Toraldo.
Massa Carrara, 276.
Massena, II, 138, 143, 145, 146, 151.
Massillon, II, 79.
Massimiano, 75, 76, 79.
Massimiliano d’Austria, 232; II, 7, 9, 12, 15, 16, 19, 21.
Massimiliano di Baviera, II, 203.
Massimino seniore, 73, 78.
Massimino iuniore, 76, 79.
Massimo, imperatore, 84.
Massimo, senatore, poi imperatore, 85.
Massinissa, 44.
Mastai, 198.
Mastai, vedi Pio IX.
Mastino deIla Scala, vedi Scala (della) Mastino.
Matilde (contessa), 166, 167, 179, 181, 182, 187, 190, 231.
Matra, II, 125.
Mauritania, 47, 67, 69, 75.
Maurizio, imperatore bizantino, 116.
Maurizio di Savoia, II, 65.
Mauro (fra), veneziano, 295.
Mazza Angelo, II, 167.
Mazzarino cardinal Giulio, II, 66, 70, 90.
Mazzocchi, II, 88.
Mazzuchelli, II, 168.
Mecenate, 87.
Medici (i), 248, 253, 263, 264; II, 26, 29, 37, 58.
Medici (de’) Alessandro, il bastardo, II, 27, 28, 29, 38.
Medici (de’) Caterina, II, 27, 30, 41.
Medici (de’) Cosimo, il padre della patria, 251, 263, 269, 270, 271, 272, 273; II, 6.
Medici (de’) Cosimo I, granduca, 276; II, 29, 32, 33, 38, 51, 54.
Medici (de’) Cosimo II, II, 62.
Medici (de’) Cosimo III, II, 67, 73, 103.
Medici (de’) Ferdinando I, II, 62.
Medici (de’) Ferdinando II, II, 62, 67.
Medici (de’) Francesco I, II, 54, 62.
Medici (de’) Gian Gastone, II, 103, 105.
Medici (de’) Giovanni, figliuolo di Salvestro, 263.
Medici (de’) Giovanni, figlio di Lorenzo il Magnifico, vedi Leone X.
Medici (de’) Giovanni, detto delle Bande nere, 276; II, 23, 29.
Medici (de’) Giuliano, 273, 274; II, 22.
Medici (de’) Giuliano, iuniore, figlio di Lorenzo il Magnifico, II, 7, 17, 19.
Medici (de’) Giulio, vedi Clemente VII.
Medici (de’) Lorenzino o Lorenzaccio, II, 29.
Medici (de’) Lorenzo, fratello di Cosimo il vecchio, II, 29.
Medici (de’) Lorenzo il Magnifico, 251, 273, 274, 275. 276, 277, 281, 293, 294, 297; II, 6, 7, 10.
Medici (de’) Lorenzo di Piero, duca d’Urbino, II, 19, 22, 27.
Medici (de’) Piero seniore, 272, 273.
Medici (de’) Piero iuniore, figlio del Magnifico, II, 7, 8, 19.
Medici (de’) Salvestro, gonfaloniero, 253. 263.
Medici (de’), vedi papa Leone XI.
Medici (de’), vedi papa Pio IV.
Mediterraneo, 30, 45, 51, 66, 67, 215, 216, 217, 218; II, 55, 175.
Melas, II, 144, 145, 146, 147.
Melo, 157, 158.
Meli, II, 167.
Meloria (prima battaglia della), 222.
Meloria (seconda battaglia della), 233.
Memmi Simone, 290.
Mengs, II, 174.
Menzini, II, 83.
Mercy, II, 104.
Mesia, 67, 104.
Mesi, 66.
Mesopotamia, 67.
Messalina, 69.
Messina, 25, 43, 212, 232; II, 70, 116, 208, 233.
Metastasio, II, 165.
Metauro, 22.
Metello, 47.
Michelangelo, 293; II, 17, 26, 43, 44, 46, 47, 88.
Michelozzi Michelozzo, 293.
Mid-land o Mid-lawn, vedi Milano.
Mignet, II, 152.
Milano, 27, 106, 109, 115, 119, 140, 149, 155, 160, 161, 162, 163, 166, 183, 185, 186, 187, 190, 193, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 208, 210, 220, 221, 222, 224, 225, 236, 237, 238, 239, 249, 251, 252, 254, 255, 256, 264, 266, 267, 268, 272, 273, 274, 275, 277, 294, 295; II, 7, 8, 11, 12, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 64, 65, 93, 94, 98, 104, 106, 110, 111, 136, 139, 140, 143, 146, 147, 151, 162, 179, 198, 209, 214, 218, 223, 224, 225, 226, 229, 234.
Milanesi, 167, 197, 199, 201, 206, 211, 222, 266; II, 213, 223.
Millesimo, II, 135.
Milton, II, 78.
Mincio, II, 94, 104, 136, 137, 147, 214, 220, 221, 222.
Minerva, 31.
Minorca, II, 98.
Miollis, II, 155.
Mirabeau, 58.
Mirafiori, II, 65.
Mirandola, II, 15.
Mirandola, vedi Pico della Mirandola.
Miseno, 66.
Mitridate, 49, 50, 51.
Modena, 55, 204, 206, 208, 272, 275; II, 51, 66, 67, 73, 124, 137, 141, 147, 163, 191, 196, 208, 227.
Mceser, II, 165.
Mcesskirk, II, 145.
Mogolli (i), 222, 291.
Moliterno (principe di), II, 142.
Molza, II, 39.
Monaco, II, 125.
Moncalvo, II, 88.
Moncenisio, 44, 123, 125, 144, 179, 204, 206, 237; II, 134.
Monferrato (famiglia), 258.
Monferrato (marchesato di), II, 51, 60.
Monferrato (marchesi di), 197, 199, 204, 217, 249.
Monforte (di) Guido, 229.
Monginevra, 27, 44, 112.
Mongolia, 291.
Monmelliano, II, 66.
Monpensieri, II, 9.
Monreale, 232.
Mons, II, 97.
Montaigne, 280; II, 79.
Montanara, II, 217.
Montaperti, 225.
Monte (Del), vedi papa Giulio III.
Montebaldo, II, 216.
Montebello, II, 146.
Montecassino, 164, 281.
Montecatini, 238.
Montechiaro, II, 214.
Montefeltro, 124.
Montefeltro (i), II, 7.
Monte Lucaro, 124.
Montemar, II, 105.
Montenotte, II, 135.
Montesquieu, 39.
Montmirail, II, 161.
Montone (da) Braccio, 257.
Monza, 118, 160, 183.
Monzone, II, 60.
Morales, II, 78.
Morata Olimpia, II, 91.
Moravia, II, 152.
Moreau, II, 138, 143, 144, 146, 148, 159.
Morgagni, II, 172.
Mori, 296; II, 6.
Moriale (fra), 249.
Morienna, 258,
Moro (Lodovico il), vedi Sforza Lodovico.
Morosini, II, 73.
Mortara, 125.
Mosca, II, 157.
Moscowa, II, 157.
Mosé, 129, 140.
Munda, 54.
Murat Gioacchino, II, 154, 158, 160, 162, 163, 190, 235.
Muratori, 155, 195, 204; II, 168, 169, 170.
Murillo, II, 78.
Mussato Albertino, 289.
Musulmani, 140.
Nantes (l’evocazione dell’editto di), II, 72.
Napione, II, 169.
Napoleone, 44, 65, 118, 136, 193; II, 66, 125, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 166, 177, 187, 208, 211, 214, 221.
Napoletani, 233; II, 133, 142, 230.
Napoli citta, 104, 108, 109, 115, 123, 133, 142, 146, 154, 185, 192, 218, 223, 224, 252; II, 9, 14, 29, 83, 94, 96, 105, 109, 115, 116, 141, 142, 143, 144, 153, 160, 162, 190, 209, 213, 232, 233.
Napoli regno, 192, 193, 195, 203, 211, 212, 213, 214, 218, 219, 223, 224, 225, 226, 227, 232, 233, 235, 241, 246, 247, 251, 252, 253, 257, 261, 262, 270, 277; II, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 34, 50, 51, 52, 56, 64, 68, 69, 93, 96, 98, 100, 105, 106, 107, 108, 109, 115, 116, 120, 133, 137, 144, 148, 153, 154, 158, 160, 163, 188, 191, 196, 208, 209, 210, 213, 232, 235.
Narbonese provincia, 67.
Narciso, liberto, 69.
Narni, 124.
Narsete, 110, 111, 112.
Nassau-Oranges, vedi Oranges.
Nassau (di) Adolfo, 236.
Navarra citta, II, 14.
Navarra regno, II, 6.
Neerlandia, 205.
Nemours (duca di), II, 12.
Nepi, II, 30.
Neri san Filippo, II, 48.
Neri (i), 229, 234, 236.
Nerli, II, 38.
Nerone, 69, 78.
Nerva, 70.
Neustria, 115.
Nevers, vedi Gonzaga.
Nevio, 57.
Newton, II, 79.
Ney, II, 157.
Niccoletto da Torino, 284.
Niccolò II, papa, 166, 167.
Niccolò III, papa, 231.
Niccolò IV, papa, 234.
Niccolò V, papa, 251, 262, 268, 269, 272.
Niccolò di Iamsilla, vedi Iamsilla.
Niccolò pisano, 228.
Nicomede, re di Bitinia, 49.
Niemen, II, 157.
Nilo, 66.
Nina siciliana, 284.
Nino della Pelosa, II, 68.
Nipote Giulio, imperatore, 86, 104.
Nizza, 148, 260; II, 27, 28, 95, 108, 109.
Nocera dei Pagani, 218.
Noé, 96.
Nogareto, 235.
Norbano, 50.
Norici, 66.
Norico, 67, 85.
Normandia, 158, 281.
Normanni, 32, 140, 143, 158, 164, 185, 192.
Novalesa, 125.
Novalesa (Cronaca della), 162.
Novara, 158, 204, 206, 208; II, 30.
Noyon (pace di), II, 19.
Nubia, 67.
Nugent, II, 218.
Numanzia, 46.
Numa Pompilio, 29, 56.
Numeriano, 75.
Numidia, 47, 54, 67.
Nymphemburg, II, 107.
Oberto II d’Este, 158.
Oc (lingua d’), 282, 283.
Occhiali, corsaro, II, 90.
Oceano settentrionale, 76.
O’ Connell, 222; II, 203.
Oderico da Pordenone, 291.
Oderisi da Gubbio, 290.
Oderzo, 119.
Odescalchi, vedi papa Innocenzo XI.
Odoacre, 86, 103, 104, 106, 113.
Odone, conte di Parigi, 145.
Odone di Savoia, 165, 258.
Odovacar, vedi Odoacre.
Oglio, II, 104, 136, 218, 223.
Ognate (conte d’), II, 69.
Oil (lingua d’) 282, 283.
Olanda, 221; II, 97, 132, 153.
Olgiati, 273.
Olibrio, imperatore, 86.
Olivares (conte duca d’), II, 64.
Olumbri, 23.
Ombrone, 22.
Omero, 34.
Onorio, imperatore, 84.
Onorio II, papa, 191.
Onorio III, papa, 218.
Onorio IV, papa, 234.
Orazio, 57.
Orbecche (L’), opera in musica, del Giraldi, II, 48.
Ordelaffi (gli), II, 13.
Oreste, imperatore, 86, 104.
Orgagna Andrea, 290.
Origene, 90.
Orléans (duca d’), 266.
Orléans (duca d’), vedi Luigi XII.
Orléans (Filippo, duca d’) [il reggente], II, 96, 99.
Ormea (marchese d’), II, 101.
Ornani, II, 90.
Orosio, vedi Paolo Orosio.
Orsini, vedi papa Benedetto XIII.
Orta (lago d’), 115, 152.
Ortensio, 57.
Osci, 21, 28, 33.
Ostia, 143.
Ostrogoti, 105.
Otranto, 275; II, 152.
Otricoli, 142.
Ottavia, moglie di Nerone, 69.
Ottavio, vedi Augusto.
Ottobon Terzo, 256.
Ottobolli, vedi papa Alessando VIII.
Ottone, imperatore romano, 69, 70.
Ottone I di Sassonia, re di Germania e imperatore, 150, 151, 152, 153, 154; II, 177.
Ottone II, 152, 155.
Ottone III, 155, 156.
Ottone IV, duca di Sassonia e Baviera, poi imperatore, 213.
Ottone di Brunswick, 247, 252.
Oudenarde, II, 97.
Ovidio, 57, 87.
Padova, 115, 195, 202, 204, 208, 220, 222, 223, 240, 253, 256.
Padovanino, II, 88.
Paër, II, 174.
Paesiello, II, 174.
Pafiagonia, 49.
Pagano Mario, II, 168.
Paleologhi (i) di Costantinopoli, 259.
Palermo, 232; II, 68.
Palestina, 23, 283.
Palestrello, 295.
Palestrina (il), II, 48.
Palladio, II, 47.
Pallante, 25.
Pallante, liberto, 69.
Pallavicini Sforza, cardinale, II, 83.
Palma il vecchio, II, 46.
Palma il giovane, II, 88.
Palmira, 74.
Palos, 296.
Pandolfini Agnolo, 292.
Pandosia, 42.
Panfili, vedi papa Innocenzo X.
Panigo (Da), 244.
Pannartz, 294.
Pannoni, 22, 55, 66, 73.
Pannonia, 67, 73, 84, 85, 104, 107.
Paoli Giacinto, II, 103, 113, 124.
Paoli Pasquale, II, 124, 125, 134.
Paolo (san), 89.
Paolo II, papa, 269, 272, 273.
Paolo III, papa, II, 28, 29, 30, 31.
Paolo IV, papa, II, 32, 34, 51.
Paolo V, papa, II, 62.
Paolo Diacono, 115, 116, 119, 120, 127; II, 89.
Paolo Orosio, 90.
Paolo Veronese, II, 46.
Papieno, imperatore, 73.
Papio Caio, 49.
Parabiago, 244.
Pardessus, 216.
Parma città, 115, 161, 182, 195, 204, 223; II, 51, 109, 227.
Parma e Piacenza, ducato, II, 30, 73, 103, 105, 107, 108, 110, 120, 123, 136, 148, 151, 162, 163, 196, 208.
Parmigianino, II, 47.
Partenope, 25.
Parti, 51, 53, 66, 71.
Paruta, II, 83.
Pascal, II, 79.
Pasquale II, papa, 190.
Pasquale, antipapa, 203.
Passarowitz (pace di), II, 99.
Passavanti Iacopo, 289.
Passeroni, II, 166.
Pastrengo, II, 216, 225, 228, 233.
Pavesi, 159, 160, 161, 199.
Pavia, 104, 106, 109, 110, 114, 115, 120, 123, 125, 137, 143, 146, 151, 157, 160, 194, 195, 198, 202, 204, 208, 238, 249; II, 23, 109.
Pazzi (i), 273, 274.
Pegoletti, 291.
Pelagio II, papa, 116.
Pelasgi, 23, 28, 30, 31, 32, 40; II, 175.
Pelasgia, 23.
Pelasgica lingua, 33.
Pelasgiche mura, 34.
Pelasgo ellenici, 25.
Pelavicino Oberto, 224, 225, 229.
Peligni, 26.
Pellico Silvio, II, 167, 198, 199.
Peloponnesiaco (il), vedi Morosini.
Peloponneso, vedi Morea.
Penni, 45.
Pentapoli, 120, 151, 184.
Pepoli Taddeo, 240, 248.
Pera, 249.
Peretti, vedi papa Sisto V.
Peri, II, 88.
Pergamo, 46.
Pergola (la), II, 94.
Pergolese, II, 174.
Perpenna, 50.
Perrone, II, 234.
Perseo, re di Macedonia, 45.
Persia alta, 215.
Persiani, 40, 73, 75, 82, 84, 108.
Persico golfo, 76, 215.
Persio, 88.
Pertinace, 72.
Perugia, 115, 123, 224, 255, 256; II, 13, 22.
Peruzzi, 44.
Pesaro, 121, 124; II, 13.
Pescara (marchese di), II, 21, 23, 24, 40.
Pescennio, imperatore, 72.
Peschiera, II, 136, 215, 216, 217, 218, 228.
Petervaradino, II, 99.
Petrarca, 228, 234, 241, 250, 287, 288, 292; II, 90.
Petronio, 88.
Peucezi, 24.
Phalesgi, 23.
Piacentini, II, 30.
Piacenza, 43, 115, 183, 195, 200, 204, 206, 208, 220; II, 51, 227.
Piave, II, 138.
Piccinini (i), II, 7.
Piccinino Iacopo, 267, 270, 275.
Piccinino Niccolò, 262, 265, 266.
Piccolomini Enea Silvio, vedi papa Pio II.
Piccolomini, vedi papa Pio III.
Piccolomini, arcivescovo di Siena, II, 85.
Piccolomini Ottavio, II, 90.
Pico della Mirandola, 293; II, 17.
Piemonte, 27, 222, 225, 228, 258, 259, 260, 261; II, 7, 28, 29, 33, 34, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 71, 72, 101, 102, 108, 112, 125, 126, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 144, 148, 151, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 200, 201, 207, 208, 210, 214, 215, 219, 222, 225, 227, 228, 229, 230, 232, 234, 235.
Piemontesi, II, 74, 94, 95, 96, 111, 112, 133, 134, 135, 141, 143, 179, 194, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 227, 233.
Pier Damiano (san), 166, 170, 182.
Pier delle Vigne, 223, 284.
Pier di Luna, vedi Benedetto XIII, antipapa.
Pier Leone, 192.
Pier Lombardo, vescovo di Parigi, il maestro delle sentenze, 281; II, 89.
Pietrasanta, 239.
Pietro Crisologo (san), 90.
Pietro da Cortona, II, 88.
Pietro I d’Aragona, 231, 232, 233; II, 25.
Pietro II, figliuolo di Federigo d’Aragona, 257.
Pietro Leopoldo, vedi Leopoldo II d’Austria.
Pietro Perugino, 294; II, 44.
Pignatelli, vedi papa Innocenzo XII.
Pilnitz, II, 132.
Pindemonte Ippolito, II, 166.
Pinerolo, 294; II, 50, 61, 65, 71, 72.
Pio II, papa, 251, 269, 272, 293.
Pio III, papa, II, 14.
Pio V, papa, 54.
Pio VI, papa, II, 121, 123, 127, 141, 142.
Pio VII, papa, 275; II, 148, 151, 155, 162.
Pio IX, papa, II, 122, 201, 203, 205, 206, 231, 232.
Pio (Ludovico il), vedi Ludovico il bonario.
Piombino, II, 148.
Pipino il breve, 123, 124, 126, 138, 231.
Pipino, figlio di Carlomagno, 136, 137, 138, 140.
Pipino, figlio di Ludovico il bonario, 141, 142.
Pircheriano monte, 125.
Pirenei, 22, 48, 55, 135.
Pirro, 42.
Pisa, 149, 157, 166, 170, 186, 190, 195, 202, 205, 212, 214, 215,216, 222, 237, 238, 239, 249,255, 257; II, 16, 30.
Pisani, 158, 201, 216, 218, 226, 233, 249, 257.
Pisani Niccolò, 249.
Pisani Vettore, 253, 254.
Pistoia, 205, 234.
Pitagora, 34, 56, 57.
Pitigliano, II, 15.
Pitt, 58.
Pitti Luca, 271.
Pizzano (da) Cristina, II, 89.
Pizzighettone, II, 104.
Plauto, 57.
Plinio il vecchio, 60, 78, 88.
Plinio il giovane, 88.
Plutarco, 54, 88.
Po, 22, 25, 27, 43, 85; II, 143, 144.
Poeni, 43.
Poggetto (del) Bertrando, 240.
Poggio imperiale, 274.
Poitiers, 107, 122.
Pola, 253.
Polibio, 57.
Policarpo (san), 90.
Polignac, II, 151.
Politeismo, 30, 56.
Poliziano Angelo, 293, II, 17.
Polo (famiglia), 291.
Polo Marco, 291, 295, 296; II, 89.
Polonia, 214, 222; II, 73, 103, 104, 105, 143, 156, 191.
Pombal, II, 120.
Pompadour, II, 120.
Pompei, II, 116.
Pompeo, 51, 52, 53, 54.
Pompeo Sesto, 55.
Ponteba, II, 138.
Pontida, 204.
Pontifici soldati alla guerra d’indipendenza, II, 216, 230, 233.
Ponto, 49, 50, 54, 67, 81.
Pontormo, II, 44.
Pontremoli, 203, 239.
Poppea, 69.
Populonia, 115.
Porcari Stefano, 268.
Pordenone (da) Oderico, 291.
Porpora Nicola, II, 174.
Porta Carlo, II, 167.
Portici, II, 116.
Portogallo, 214; II, 98, 132, 154.
Portoghesi, 295.
Portolongolle, II, 149.
Porto Santo, 295.
Poussin, II, 80.
Presburgo (pace di), II, 152.
Presidi, II, 149.
Primaticcio, II, 91.
Primato civile e morale degl’italiani, di Vincenzo Gioberti, II, 200.
Prina, II, 162.
Principe (il), del Machiavello, II, 37.
Priocca, II, 142.
Probo, imperatore, 74.
Procida, vedi Giovanni da Procida.
Promessi sposi (I), del Manzoni, II, 198.
Properzio, 87.
Prospero (san), 90.
Protestanti, II, 54.
Provenza, 48, 107, 115, 225, 233; II, 6.
Provenzali, 149.
Provera, II, 138.
Prudenzio, 90.
Prusia, re di Bitinia, 51.
Prussia, II, 98, 107, 113, 114, 132, 153, 158, 187.
Prussiani, 40; II, 159.
Puglia, 166, 192, 223.
Puglia (regno di), vedi Napoli regno.
Pulci Luigi, 293.
Punica guerra prima, 43.
Punica guerra seconda, 43, 44.
Punica guerra terza, 45.
Quintiliano, 88.
Quintillo, imperatore, 74.
Quistello, II, 104.
Raab (battaglia di), II, 155.
Rabida (monastero della), 296.
Rachi, 123, 124, 129.
Racine, II, 79.
Radagasio, 84.
Radetzski, II, 217, 218, 219, 220, 223, 224.
Radicati, II, 91.
Raffaello, 296; II, 43, 44, 45, 46, 88.
Ragimberto, 119.
Ragusi, II, 50.
Raimondi Marcantonio, II, 47.
Rambouillet (palazzo), II, 84.
Ramillies, II, 96.
Ranke, II, 31.
Raseni, 21.
Rastadt (trattato di), II, 98, 100.
Rastadt (congresso di), II, 140.
Rauss (colle di), II, 134.
Ravenna, 66, 104,106, 109, 110, 114, 115, 122, 123, 124, 138, 160, 180, 195, 205, 282.
Redi, II, 84.
Reggio Emilia, 115, 182, 195; II, 227.
Reggio di Calabria, 25, 117; II, 208.
Régnier, II, 79.
Regolo Attilio, 43.
Renato d’Angiò, 262, 270.
Reni Guido, II, 87.
Reno, 22, 53, 66, 67, 73, 74, 82, 135.
Reti, 66.
Reynolds, II, 174.
Rezia, 67, 104.
Rezzonico, vedi papa Clemente XIII.
Riari (i), 273; II, 13.
Riario Girolamo, 295.
Ribera, II, 78.
Riccardo Normanno, 177.
Riccardo da San Germano, 284.
Riccardo di Cornovaglia, 224, 230.
Ricci, 253, 263.
Richecourt, II, 122.
Ricimero, 85, 86, 101.
Ricotti, II, 89.
Ridolfi (ministero), II, 230.
Rieti, 24.
Rimini, 115, 121, 124, 205; II, 13.
Rinaldo (Il), di Torquato Tasso, II, 81.
Ripaglia, 261.
Rivoli, II, 102, 110, 216, 219.
Rivoli (trattato di), II, 65.
Rivoli (battaglia di), II, 138.
Riswick (pace di), II, 72.
Robbia (Della) Luca, 293.
Roberto, re di Francia, secondo dei Capeti, 159.
Roberto Guiscardo, 180, 181, 182.
Roberto d’Angiò, 236, 237, 238, 241, 246.
Roberto, conte palatino, poi imperatore, 255.
Robespierre, II, 134.
Rodano, 22, 48, 105, 107.
Rodi, 67, 70, 259.
Rodoaldo, 119.
Rodolfo, re della Borgogna translurana, 148, 149, 150, 160.
Rodolfo, duca di Svevia, 165, 179, 180.
Rodolfo d’ Asburga, 230, 231, 236.
Roma, passim, specialmente 39-91.
Roma (re di), figliuolo di Napoleone, II, 156, 163.
Romagnosi, II, 169.
Romani, passim, specialmente 39-91.
Roma nuova, vedi Costantinopoli.
Romolo, 28, 29, 39.
Romolo Augustolo, 86.
Roncaglia, 190, 197, 200.
Ronciglione, II, 66.
Roncisvalle, 136.
Rosa Salvatore, II, 83, 88.
Rosate, 197.
Roselle, 34.
Rosmunda, 113.
Rospigliosi, vedi papa Clemente IX.
Rossi Pellegrino, II, 235.
Rossiglione, 107.
Rossini, II, 174.
Rosso (il), II, 44.
Rosso (il conte), vedi Amedeo VII di Savoia.
Rotari, 118, 119, 129.
Rousseau, II, 83.
Rovelli, II, 171.
Rovere (Della) famiglia, II, 13, 22.
Rovere (Della) Francesco, II, 19.
Rovere (Della) Francesco Maria II, II, 51, 55, 61, 67.
Rovere (Della) Guidobaldo, II, 55.
Rovere (Della), vedi Sisto IV e Giulio II.
Roveredo, II, 94.
Rubeis (de) Bartolomeo, 294.
Rubicone, 53.
Rubruquis, olandese (?), 291.
Rucellai, II, 39.
Rudio Eustachio, II, 141.
Rufo, 57.
Rugen, 103, 112.
Ruggeri Normanno, conte di Sicilia, 183.
Ruggero II, re di Napoli, 192, 194, 195, 197, 198, 211, 212.
Ruggeri da Loira, 222, 233.
Ruggero Settimo, II, 232.
Rugi, 103, 104, 113.
Rugiland, 112.
Rutlando, 136.
Sabini, 26, 28.
Sacca, II, 220.
Sacchetti Franco, 292.
Sacchini, II, 174.
Saint-Cyr, II, 152.
Saint-Pol, II, 26.
Saladino, 212.
Salai Andrea, II, 43.
Salamanca, 296.
Salassi, 66.
Salernitano anonimo, 169.
Salerno, 158, 181, 282; II, 90.
Salerno (golfo di), II, 25.
Salionze, II, 220.
Sallustio, 57, 58.
Salò, II, 138.
Salza, II, 147.
Saluzzesi, 259.
Saluzzo, 156, 258; II, 57, 58, 59, 61.
Saluzzo Deodata, II, 167.
Saluzzo (marchesi di), II, 57.
Salviati, vescovo, 274.
Samo, 34, 67, 70.
Sammicheli, II, 46.
Sanazzaro, 294; II, 39.
San Bernardo grande (monte), 44, 125, 199; II, 146.
San Bernardo piccolo, 44; II, 134.
San Concordio (da) Bartolomeo, vedi Bartolomeo da San Concordio.
San Domingo, isola, 296.
Sanfedisti, II, 189.
Sangallo (da) Antonio, II, 44, 46.
Sangallo (da) Giuliano, II, 46.
San Germano (da) Riccardo, vedi Riccardo da San Germano.
San Giulio, 115.
San Gottardo, II, 146.
San Leo, 152.
San Miniato, 214.
Sannio, 42.
Sanniti, 26, 42.
San Salvatore (isola di), 296.
San Sebastiano (contessa di), II, 101, 102.
Sanseverilli (i), 268; II, 12.
Sanseverillo Ferrante, II, 90.
Sansovino, II, 47.
Santa Maura, II, 73.
Sant’Elena, II, 156.
Sanuto Marin, 291.
Saorgio, II, 134.
Sapienza (golfo di), 249.
Saracini, 142, 143, 144, 148, 150, 157, 158, 185, 218, 224, 226, 232.
Saragozza, II, 97.
Sardegna, 22, 43, 45, 67, 104, 108, 135, 158, 200, 202, 213, 238; II, 100, 101, 126, 142.
Sarmati, 22, 73, 113.
Sarpi fra Paolo, II, 62, 83, 85.
Sarto (del) Andrea, II, 44.
Sarzana, 262.
Sassari, II, 126.
Sasso (Gran) d’Italia, 24.
Sassoni, 85, 112, 136, 137, 140, 165.
Sassonia (casa di), 159.
Saturnino, 48.
Saturno, 31.
Sava, II, 160.
Savelli (i), 247.
Savoia, 275; II, 59, 75, 95, 98, 101, 126, 135.
Savoia (casa di), 258, 259, 260, 261; II, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 71, 72, 73, 94, 95, 96, 142, 162.
Savoia (conti di), 206.
Savoia (duchi di), II, 60.
Savoia (duca di), figliuolo di Carlo Alberto, vedi Vittorio Emanuele di Savoia.
Savoiardi, 258.
Savona, 258; II, 146.
Savonarola fra Girolamo, II, 10, 11, 18.
Scala (Della) Can grande, 239, 240, 244.
Scala (Della) Mastino, 240.
Scala (Della) Guglielmo, 256.
Scaligeri (gli), 225, 236, 238, 254, 256, 294.
Scamozzi, II, 84.
Scandinavi, 112, 140.
Scandinavia, 105.
Scarlatti, II, 89.
Scevola, 57.
Scherer, II, 143.
Schiller, II, 164.
Schoeffer, 294.
Schoenbrunn, II, 156.
Schulemburg, II, 99.
Sciaffusa, II, 146.
Sciampagna (conte di), 161.
Sciarra Colonna, 235.
Scio, II, 55.
Scipione Africano, 44.
Scipione Emiliano, 45, 46, 47.
Scipione Nasica, 47.
Sciri, 103.
Sciti, 27.
Scizia, 54.
Scoronconcolo, II, 29.
Scott Walter, 288; II, 39.
Scrivia, II, 147.
Sebastiano (fra) dal Piombo, II, 44.
Secchi (i), 237.
Secchia, II, 104.
Segneri Paolo, II, 83.
Segni, II, 38.
Seiano, 69.
Selinunte, 25.
Seminara, II, 13.
Semiti, 21, 31.
Seneca il filosofo, 69, 88.
Seneca il tragico, 88.
Senofonte, 58.
Senoni, 27.
Sepolcro (il santo), 219.
Serchio, II, 94.
Serra, 124.
Sertorio, 50, 51.
Servilio, 51.
Servio Tullio, 29.
Sesia, II, 50.
Sesia (Val di), II, 94.
Sestie (Acque), 48.
Sesto Pompeo, vedi Pompeo Sesto.
Sesto (da) Cesare, II, 43.
Sestriera, II, 18.
Settimio Severo, 72, 78.
Severo, 79.
Sévigné, II, 79.
Sfrondrato, v. papa Gregorio XIV.
Sforza (gli), 294.
Sforza Attendolo, 257, 261, 262.
Sforza Francesco, 251, 262, 265,266, 267, 268, 270, 271, 272; II, 6, 7.
Sforza Francesco II, ultimo figlio del Moro, II, 22, 24, 26, 28.
Sforza Galeazzo, quinto duca di Milano, 272, 273.
Sforza Gian Galeazzo, sesto duca di Milano, 273.
Sforza Ludovico, detto il moro, 274, 275; II, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 43.
Sforza Massimiliano, II, 16.
Sibari, 25.
Sicani, 22.
Sicania, 22.
Sicilia, 22, 32, 42, 43, 44, 51, 104. 109, 110, 135, 142, 143, 192, 214, 218, 224, 225, 232, 233, 234, 257, 258, 270, 282; II, 6, 68, 93, 98, 99, 100, 101, 105, 142, 153, 163, 190, 208, 209, 232.
Siceli, 22.
Siciliani, 224, 234; II, 209.
Sicilie (Due), vedi Napoli e Sicilia.
Siculi, 22, 28, 32, 33, 43.
Sidone, 43.
Siena, 28, 115, 195, 205, 255, 257, 272, 277; II, 32, 33.
Sièyes, II, 145.
Siface, 44.
Sigismondo, imperatore, 261, 266.
Signorelli Luca, II, 44.
Sigonio, II, 33.
Silesia, II, 107.
Silla, 49, 50.
Silvestro II, papa, 155, 156, 169, 291.
Silvestro III, papa, 163.
Silvestro (fra), confratello del Savonarola, II, 11.
Simmaco, 88, 107.
Sinigaglia, 124; II, 13.
Sion, II, 15.
Siracusa, 25, 67.
Siria, 45, 51, 53, 67, 74, 215.
Sirmio, 73, 107.
Sismondi, 205, 235, 247, 248; II, 171.
Sismondi (i), II, 91.
Sisto IV, papa, 273, 274, 275.
Slavi, 22, 65, 137, 140.
Slavoni, 143.
Smolensko, II, 157.
Soana, 115.
Sobieski, II, 73.
Smerago Niccolò, 284.
Socino, II, 9.
Socrate, 56; II, 41.
Soemi, 73.
Soglia, cardinale, 231, 235.
Soissons, 123.
Solimene, II, 173.
Soncino, 265.
Sonderbund, II, 206.
Sordello di Mantova, 284.
Sorrento, II, 81.
Spagna, 44, 45, 46, 50, 53, 74, 75, 81, 84, 136, 296; II, 6, 11, 16, 19, 24, 48, 49, 50, 52, 53, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 78, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 107, 111, 112, 113, 116, 120, 132, 154.
Spagnuola lingua, 33; II, 77.
Spagnuoli, 46, 50, 233; II, 9, 12, 16, 18, 23, 24, 28, 32, 33, 50, 58, 61, 64, 65, 69, 70, 77, 78, 101, 105, 108, 109, 111, 156.
Spallanzani, II, 172.
Sparta, 221.
Spartaco, 51.
Spartani, 40.
Spielberg, II, 199.
Spinello Matteo, 289.
Spinola (gli), II, 90.
Spinola Ambrogio, II, 90.
Spira (da) Giovanni, 294.
Spluga, II, 147.
Spoleto, 115, 135, 146, 198, 214.
Spolverini, II, 167.
Staffarda, II, 72.
Stahremberg, II, 97, 98.
Stanhope, II, 97.
Statella, II, 233.
Stazio, 88.
Stefano II, papa, 123, 124.
Stefano III, papa, 125.
Stefano IX, papa, 166.
Sterz Alberto, 250.
Steyer, II, 147.
Stilicone, 84.
Stiria, 48.
Stockach, II, 146.
Stolhoffen, II, 96.
Strabone, 60.
Stradella, II, 146.
Strasburgo, II, 146.
Strozzi Leone, II, 89.
Strozzi Pietro, II, 89.
Stuardi (gli), II, 98.
Stura (Val di), II, 108.
Subiaco, 294.
Sulpicio Severo, 90.
Superga, II, 96.
Suplinburga, vedi Lotario di Suplinburga.
Susa, 123, 125, 148, 204, 206; II, 95, 96.
Sutri, 122.
Sventebaldo, 146.
Svetonio, 88.
Svevi, 84, 113.
Svevi imperatori, vedi Hohenstaufen.
Svevia, 135, 144, 166.
Svevia (casa di), vedi Hohenstaufen.
Svezia, II, 132.
Svizzera, 221; II, 150.
Svizzeri, 236, 274; II, 12, 16, 18, 206.
Sweinheim, 294.
Tacito Cornelio, 58, 88, 99, 101, 112, 135; II, 38.
Tacito, imperatore, 74.
Tagliacozzo, 226.
Tallard, II, 95.
Talleyrand, II, 152.
Tana (Taganrog), 249.
Tancredi di Lecce, 212.
Tanucci, II, 116.
Taranto, 25, 42.
Taro, II, 162.
Tarquinia, 34.
Tarquinio Prisco, 29.
Tarquinio il superbo, 29.
Tarragonese provincia, 67.
Tartaglia, II, 46.
Tartari, 240.
Tartaria, 291.
Tartini, II, 174.
Tassilone, 137.
Tasso Torquato, 221; II, 61, 81, 82, 83, 86.
Tauride, 51.
Taurini, 27, 44.
Taurisci, 21, 27.
Tauro, 21.
Tebani, 40.
Tebe, 221.
Tedeschi, 99, 103, 106, 152, 157, 159, 160, 161, 179, 183, 196, 201, 203, 204, 211, 213, 224, 226, 227, 233, 236, 243, 294; II, 77, 111.
Teia, 110.
Temanza, II, 173.
Temerario (il), vedi Carlo il Temerario.
Temeswar, II, 100.
Templari, 236; II, 120.
Templieri, vedi Templari.
Tenda (Col di), II, 134.
Teodato, 108.
Teodelinda, 118, 119, 120, 127.
Teoderico, 104, 105, 106, 107, 108, 127, 129; II, 176.
Teodora, 149, 163.
Teodoro, vedi Adelchi.
Teodoro, barone di Neuhof, re di Corsica, II, 113.
Teodosio I, 83, 84, 88.
Teodosio II, 128.
Teodote, 119.
Teofania, 154, 155.
Terenzio, 57.
Terrasanta, 158, 296.
Tertulliano, 90.
Tessaglia, 23.
Tessalonica, 217.
Testi Fulvio, II, 83.
Teuda, 107.
Teutch, 22.
Teutoni, 22, 48, 53, 99, 105.
Tevere, 25, 26, 28, 143.
Theiss, 107, 140.
Thian, 31.
Thou (De), II, 79.
Tiberio Gracco, 47.
Tiberio, imperatore, 68, 69.
Tibullo, 87.
Ticino, 27, 44, 120, 197, 199.
Tigri, 76, 82.
Tilsit, II, 153.
Tintoretto, II, 46.
Tiraseni, 21, 22.
Tirolo, 136, 198.
Tirrena lingua, 33.
Tirreni, 21, 28, 31, 33; II, 175.
Tirrenia, 24.
Tirreno mare, 21.
Tirseni, 21.
Tito, imperatore, 70, 87.
Tito Livio, 57, 58.
Tivoli, 156, 195, 198.
Tiziano, 294; II, 43, 46, 47, 91.
Toccia, 48.
Tolentino (trattato di), II, 138.
Tolentino (battaglia di), II, 190.
Tolomeo, 54.
Tommaso (san) d’Aquino, 170, 215, 281, 287, 290; II, 90.
Tommaso da Pisa, 285.
Tommaso di Savoia, II, 65, 70.
Toraldo, principe di Massa, II, 69.
Torinesi, II, 74
Torino, 115, 117, 143, 194, 197, 220, 223; II, 55, 57, 58, 65, 66, 95, 126, 144, 213.
Torino (cittadella di), II, 57, 102, 126.
Torsi, II, 12.
Torriani (i), 221, 225, 236, 237.
Torricelli, II, 84.
Torrismondo, 113.
Tortona, 197, 198, 199, 202, 204, 208; II, 109.
Toscana, 84, 109, 115, 149, 160, 166, 203, 205, 214, 222, 223, 228, 236, 253, 254, 283, 293; II, 51, 54, 110, 154, 196, 207, 230, 235.
Toscanelli, 295.
Toscani, 216, 217, 230.
Toth, 22.
Totila, 109, 110
Tours, 138.
Tracia, 21, 67, 69, 70, 75, 81.
Traiano, 67, 70, 71, 78, 83, 87.
Trasimeno, 44.
Trebbia, 44, 115, 146; II, 143.
Trecate, 197.
Trento, 115, 119, 239.
Trento (concilio di), II, 32, 53.
Treviso, 115, 195, 202, 204, 208, 220, 240, 254; II, 148.
Tribolo, II, 47.
Triboniano, 108.
Triburia, 178.
Trieste, II, 154.
Trinci (i), II, 13.
Tripoli, 216.
Trissino, II, 39.
Triulzi, II, 18.
Triulzi Belgioioso, principessa, II, 232.
Troia pelasgica, 23.
Troia (l’assedio di), 24.
Troya Carlo, II, 231.
Tucidide, 58.
Tule, 296.
Tullo Ostilio, 29.
Tunisi (bey di), II, 113.
Turchi, 103, 268, 275; II, 28, 53, 55, 67, 73, 99.
Turcilingi, 603.
Turio, 25.
Turingia, 135.
Tusci, 21.
Tuscia, 115.
Tuscolo, 119, 163.
Tzechi, 22.
Ubaldino, 255.
Uberti (degli) Farinata, 225.
Uberti (degli) Fazio, 289.
Udine (da) Giovanni, II, 45, 91.
Ugo, giureconsulto, 282.
Ugo, conte di Provenza, 149, 150, 151.
Ugonotti, II, 72.
Uguccione della Faggiola, 237, 238, 244.
Ulfila, 105.
Ulma, II, 146.
Umana, 121.
Umberto II di Savoia, 258.
Umbra lingua, 33.
Umbri, 26, 27, 41; II, 175.
Umbria, 27, 74.
Unaldo, 125.
Ungheri, 148, 149, 150.
Ungheria, 113, 212, 214, 222, 236, 246, 252.
Unn-Avaria, vedi Ungheria.
Unni, 82, 84, 137.
Unni-avari, 113, 137, 140, 148.
Unzmark, II, 139.
Urbano II, papa, 182.
Urbano III, papa, 212.
Urbano IV, papa, 225.
Urbano V, papa, 248, 250.
Urbano VI, papa, 252.
Urbano VII, papa, II, 62.
Urbano VIII, papa, II, 62, 65, 67.
Urbino (città), 124, 275; II, 13.
Urbino (ducato), II, 19, 22, 51, 55, 61.
Ursini (degli) Emiliano, 294.
Uscocchi, II, 64.
Uzeda (duca d’), II, 64.
Vaga (del) Pierin, II, 45.
Val Camonica, 203.
Valdesi, II, 57, 66.
Valenciennes, II, 135.
Valente, imperatore, 82.
Valentiniano I, 82.
Valelltiniano II, 84.
Valentiniano III, 85.
Valentino, vedi Borgia Cesare.
Valenza, II, 12, 65, 142, 143.
Valeriano, 73, 78, 83.
Valerio, 75.
Valla Lorenzo, 292.
Valeggio, II, 214, 216, 219, 220.
Vallese, 148.
Vallisnieri, II, 84.
Valmichi, 34.
Valmy, II, 133.
Valois (di) Carlo, 234, 257.
Valois (di) Filippo, 238.
Valori, II, 27.
Valromey, II, 59.
Vandali, 84, 85, 104, 108.
Vandamme, II, 159.
Vandea, II, 133.
Vanini, II, 86.
Vanvitelli, II, 173.
Varani (i), II, 13.
Varano (da) Alfonso, II, 165.
Varchi, II, 38.
Varo, 67.
Varrone, 57, 280.
Varsavia (granducato di), II, 154.
Vasari, II, 22, 39, 43, 44, 84, 88.
Vasco de Gama, 295.
Vauchamp, II, 161.
Vega (de la) Garcilazo, II, 77.
Veio, 28, 29, 41.
Velasquez, II, 78.
Velleio Patercolo, 112, 115.
Velletri, II, 109.
Venceslao, 255.
Vendeli, 112.
Venere, 31.
Veneti, 21, 27.
Venezia, 21, 115, 120, 135, 155, 184, 195, 203, 204, 205, 208, 209, 216, 217, 220, 221, 240, 245, 248, 249, 253, 256, 267, 268, 269, 270, 272, 277, 296; II, 7, 9, 14, 15, 18, 19, 50, 51, 55, 56, 63, 64, 67, 73, 95, 9, 102, 124, 139, 140, 163, 226, 227.
Veneziani, 122, 170, 215, 216, 217, 249, 265, 266; II, 11, 16, 24, 55, 99, 136.
Ventimiglia, II, 112.
Verazzani Giovanni, II, 42.
Vercelli, 115, 156, 158, 204, 208, 220, 249; II, 33.
Verde (il conte), vedi Amedeo IV
di Savoia.
Verdun, 143.
Verme (Dal), 255.
Vero (Lucio Antonio), 71.
Verona, 27, 84, 109, 115, 125, 143, 148, 149, 195, 203, 204, 206, 208, 222, 226, 236, 237, 256; II, 136, 139, 217, 219, 220.
Veronesi, 198.
Verre, 52.
Verri Pietro, II, 268.
Verrua, II, 95.
Vervins, II, 59.
Vespasiano, 70, 87.
Vesuvio, 110.
Vibellini, vedi Ghibellini.
Vicenza, 115, 143, 195, 202, 204, 208, 221, 256; II, 31, 94, 218.
Vico Giambattista, 39; II, 168, 169, 170.
Vien, II, 174.
Vienna, II, 73, 90, 105, 152, 155.
Vignate (da) Giovanni, 256.
Vignola, II, 46.
Villa, moglie di Berengario II, 151, 152.
Villafranca, 219, 220, 222.
Villa (marchese di), II, 66.
Villani Filippo, 292.
Villani Matteo, 289.
Villani Giovanni, 289; II, 27.
Villanova d’Asti, II, 50.
Villars, II, 95, 96, 97, 98, 105.
Villaviciosa, II, 97.
Ville Hardouin, 284.
Villeroi, II, 94, 96.
Vilna, II, 157.
Vilumbri, 22.
Vinci, II, 43.
Vinci (da) Leonardo, vedi Leonardo da Vinci.
Vindelicii, 66.
Vindelizia, 67.
Vinnuli, 112.
Virgilio, 57.
Viriate, 46.
Visconti (i), 236, 237, 249, 254, 256,
261, 264, 273.
Visconti Azzo, 239, 241.
Visconti Bernabò, nipote di Giovanni, 249, 254.
Visconti Caterina, 256.
Visconti Filippo Maria, 256, 264, 265, 266.
Visconti Galeazzo, figliuolo di Matteo, 239, 244.
Visconti Galeazzo II, nipote di Giovanni, 249, 254.
Visconti Gian Galeazzo, primo duca di Milano, 254, 255, 256.
Visconti Giovanni, arcivescovo, 248, 249.
Visconti Giovanni Maria, secondo duca, 256.
Visconti Giulio, viceré di Napoli, II, 105.
Visconti Lodrisio, 244.
Visconti Luchino, 241, 244, 248.
Visconti Marco, 244.
Visconti Matteo, 238, 239, 244.
Visconti Matteo, nipote di Giovanni, 249.
Visigoti, 82, 83, 105.
Viteli, 22.
Vitelli (i), II, 13.
Vitellio, 70.
Vitepsk, II, 157.
Vitige, 109, 111.
Vitikindo, 136.
Vittore II, papa, 164, 166.
Vittore III, papa, 182.
Vittore IV, antipapa, 201, 203.
Vittoria, citta, 223.
Vittorio Amedeo I, duca di Savoia, II, 65.
Vittorio Amedeo II, re di Sicilia, poi di Sardegna, II, 71, 72, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 102.
Vittorio Amedeo IlI, re di Sardegna, II, 126, 133, 137.
Vittorio Emanuele I, re di Sardegna, II, 162, 191.
Vittorio Emanuele, duca di Savoia, figlio di Carlo Alberto, II, 216, 217, 222.
Vituli, 22.
Viviani, II, 84.
Voghera, II, 147.
Volsci, 60.
Volta Alessandro, II, 172, 197.
Volterra, 34; II, 26.
Volterra (da) Antonio, 274.
Volterra (da) Daniele, II, 45.
Vormazia, 178.
Vulcano, 31.
Vulci, 34.
Vurtzburga, 197.
Wagram, II, 156.
Weibelingen, 159.
Weissembourg, II, 133.
Welden, II, 218.
Wieland, II, 164.
Winkelmann, II, 164.
Wittemberga, II, 20.
York, II, 6.
Zaccaria, papa, 123.
Zama, 44.
Zanotti Francesco Maria, II, 172.
Zappi, II, 83.
Zara, 127.
Zen Carlo, 254.
Zeno Apostolo, II, 165.
Zenobia, 74.
Zeus, 31.
Zingarelli, II, 174.
Zuccarelli, II, 173.
Zuccari Taddeo, II, 45.
INDICE
——————
LIBRO SETTIMO
ETÁ SETTIMA: DELLE PREPONDERANZE STRANIERE
| 1. | Di quest’etá in generale, ed in particolare di questo periodo primo delle preponderanze spagnuola e francese combattute | pag. | 3 |
| 2. | Stato d’Europa e d’Italia | » | 6 |
| 3. | Alessandro VI papa | » | 8 |
| 4. | Pio III, Giulio II | » | 14 |
| 5. | Leone X | » | 17 |
| 6. | Adriano VI, Clemente VII | » | 22 |
| 7. | Paolo III | » | 28 |
| 8. | Giulio III, Marcello II, Paolo IV | » | 31 |
| 9. | Colture di questo periodo | » | 34 |
| 10. | Continua | » | 39 |
| 11. | Continua | » | 42 |
| 12. | Il secondo periodo della presente eta in generale; rassegna degli Stati | » | 48 |
| 13. | Emmanuele Filiberto | » | 52 |
| 14. | Carlo Emmanuele I | » | 58 |
| 15. | Vittorio Amedeo I, Francesco Giacinto, Carlo Emmanuele II | » | 64 |
| 16. | Vittorio Amedeo II | » | 71 |
| 17. | Una digressione | » | 73 |
| 18. | Le colture straniere derivate dall’italiana in questo periodo | » | 77 |
| 19. | Colture di questo secondo periodo | » | 81 |
| 20. | Continua | » | 84 |
| 21. | Continua | » | 86 |
| 22. | Gl’italiani fuor d’Italia | » | 89 |
| 23. | Il terzo periodo della presente etá in generale | » | 91 |
| 24. | Prima guerra della successione di Spagna | » | 93 |
| [290]25. | Guerra di Morea e di Sardegna e Sicilia | » | 99 |
| 26. | Pace di dodici anni; guerra della successione di Polonia | » | 101 |
| 27. | Breve pace. Guerra della successione austriaca | » | 106 |
| 28. | Pace e progressi di quarantaquattr’anni | » | 113 |
| 29. | Continua | » | 117 |
| 30. | Continua | » | 122 |
| 31. | Le guerre della rivoluzione francese fino alla pace di Campoformio | » | 128 |
| 32. | Continua | » | 133 |
| 33. | Segue fino alla pace d’Amiens | » | 141 |
| 34. | Napoleone primo consolo e presidente della repubblica italiana, poi imperatore e re d’Italia | » | 148 |
| 35. | Continua | » | 157 |
| 36. | Le colture di quest’ultimo periodo | » | 163 |
| 37. | Continua | » | 168 |
| 38. | Continua | » | 173 |
| 39. | Le sette etá di nostra storia | » | 175 |
APPENDICE
| 40. | Il periodo quarto dell’etá settima, o della preponderanza austriaca | » | 185 |
| 41. | Continua | » | 192 |
| 42. | Continua. La rivoluzione delle riforme | » | 199 |
| 43. | Continua l’appendice. Principio d’un’etá ottava della storia d’Italia? La guerra d’indipendenza | » | 210 |
| 44. | L’armistizio | » | 233 |
| Nota | » | 237 | |
| Indice dei nomi | » | 251 | |
NOTE:
[1] Nella edizione di novembre 1846 era qui quest’aggiunta, quest’eccezione: «(fino al giugno 1846)». Così ora nel 1850 la potess’io lasciare! Così poi ripentirmi, e riporla a luogo suo!
[2] Non so trattenermi di notare che non ho mutata e non trovo da mutar una sillaba a questa pagina, scritta or son quattr’anni, nel 1846, e quando eravam lontani tutti di prevedere la rinnovazione di simili faccende.
[3] Farini, II, 110.
[4] Della storia d’Italia il Balbo incominciò a occuparsi verso il 1815, con due abbozzi: Storia dei passaggi delle Alpi e Storia delle discese degli stranieri in Italia. E in un primo periodo, che potrebbe chiamarsi di assaggi, e che giunge fino al 1824, ideò e svolse in parte gli altri seguenti lavori: 1) un discorso Sopra il modo di trattare la storia d’Italia; 2) una Istoria della guerra di libertá tra Federico I e le repubbliche italiane; 3) un’opera storico-politica intitolata L’Italia; tutti tre abbozzati non oltre il 1816; e poi: 4) un’altra opera storico-politica, sul tipo della precedente, divisa in sette discorsi, dei quali soltanto il primo venne scritto (ott.-nov. 1819).—Nel 1824 il B. concepiva precisamente il disegno di scrivere una storia generale d’Italia dal 476 ai tempi moderni. Vi preludiava con due discorsi d’indole teorica: I. Della difficoltá e utilitá d’una storia d’Italia; II. Del modo di scriverla; e la concepiva divisa in tredici periodi, ciascuno dei quali avrebbe formato un libro. Furono per altro scritti soltanto tre libri: i primi due (epoca erulo-goto-greca ed epoca longobarda) vennero pubblicati nel 1830 in due volumi presso il Pomba di Torino; il terzo (epoca carolingia), postumo, nel 1862, negli Scritti storici minori.—In duplice modo il B. svolse la sua attivitá intorno alla storia d’Italia durante un terzo periodo, che va dal 1832 al 1839, e che fu anch’esso iniziato da una dissertazione teorica, ossia da una lettera al Vieusseux, destinata all’Antologia, dal titolo: Dell’utilitá presente d’una storia generale d’Italia: vale a dire col contributo validissimo da lui recato ai lavori della classe di scienze morali e politiche della R. Accademia di Torino, e coi tanti abbozzi da lui tentati di una storia d’Italia. All’Accademia egli infatti leggeva nel 1832 una memoria: Studi da farsi sulla storia d’Italia, e otteneva che si mettessero a concorso tre temi: 1) Della condizione della proprietá in Italia dalla caduta dell’impero alla metá del secolo XI, 2) Storia delle compagnie di ventura, 3) Sull’origine dei comuni. Al primo concorsero Carlo Baudi di Vesme e Spirito Fossati, al secondo Ercole Ricotti: il terzo tema, quantunque il B., per renderne piú agevole lo svolgimento, pubblicasse una sua traduzione delle Vicende della costituzione delle cittá lombarde di E. Leo (Torino, 1836), facesse tradurre l’operetta di C. F. Eichorn, Dell’origine della costituzione delle cittá in Germania (Torino, 1838) e desse alla luce alcuni suoi Appunti per la storia delle cittá italiane fino all’istituzione dei comuni (Torino, 1838), non trovò alcun ardimentoso, che volesse affrontarlo. Ciò forse disanimò il B. dal proporre altri temi, ché altri ne aveva pronti, come mostrano 15 pp. di Cenni di argomenti di storia italiana, dedicate per l’appunto a 5 temi da proporre all’Accademia. Circa lavori personali del B., egli, oltre qualche trattazione d’indole monografica, ora compiuta (p. e. la lezione Dei titoli e della potenza dei conti, duchi e marchesi dell’Italia settentrionale, e in particolare dei conti di Torino, inserita nelle Memorie della R. Accademia di Torino del 1833; una memoria sugli Sforza, che è del 1834; una Notice sur l’histoire et les historiens de la monarchie de la maison de Savoie, scritta nel 1835), ora frammentaria (frammenti di studi sui longobardi e le loro leggi, 1834; lettera al Cantú, Della virtú italiana nel secolo XII, 1836, ecc. ecc.), abbozzava, a dir poco, una dozzina di volte il futuro Sommario:—1) Prime lezioni di storia d’Italia a’ miei figliuoli (1832?). Furono scritte sole 3 pagine.—2) Discorsi e studi sulla storia d’Italia (1833). Si riattaccano forse ai due discorsi del 1824. Ma il B. non scrisse se non delle genti barbare che stanziarono in Italia.—3) Storia d’Italia compendiata (1834). Sono scritti soltanto 3 fogli.—4) Della storia d’Italia (1834). Avrebbe dovuto trattare in 36 capi, con una prefazione, un’introduzione e una conclusione, gli anni 476-1830. Furono scritti soltanto la prefazione, l’introduzione e il primo capitolo: I teutoni.—5) Études sur l’histoire d’Italie (1834). Furono scritte sole 9 pp.—6) Études sur l’hist. d’It. (1835). Concepito in 4 libri e 28 capi, il lavoro avrebbe dovuto trattare gli anni 476-1789. Furono scritti i primi 4 capp. (1. Les historiens d’Italie, 2. Les romains en 476, 3. Les germains, 4. Odoacre), e cominciato il quinto (Les goths).—7) Storia d’Italia compendiata (1836). Cominciata due volte. Scritte pp. 56.—8) Storia d’Italia durante il regnare dei Franconi (1836 o 1837). Scritta la sola prefazione.—9) Sulla storia d’Italia, lettere agli studiosi di tale storia (1836 o 1337). Abbozzata soltanto la ripartizione della materia (anni 476-1489) in 25 lettere.—10) Discorsi su vari punti di storia italiana (1836 o 1837). Soltanto l’indice di alcuni.—11) Un secolo della storia d’Italia, a. 1073-1183 (1836 o 1837). Soltanto l’indice e l’introduzione, relativa agli anni 774-1073.—12) Vita di Gregorio VII (1836 o 1837). È condotta fino al 1081.—13) Della storia d’Italia, oppure Introduzione allo studio della storia moderna d’Italia, discorsi (1838). Concepita in dodici discorsi, oltre due discorsi preliminari (di prefazione e introduzione) e una conclusione, avrebbe dovuto trattare gli anni 474-1814. Furono scritti i discorsi preliminari e il discorso I (Odoacre), il II (greci e longobardi) e parte del III (Carolingi). All’opera sarebbe dovuto seguire una Geografia della storia moderna d’Italia, della quale fu stesa una parte del testo e una parte dell’indice.—14) Storia d’It. per le persone non colte. Appena abbozzata.—Un quarto periodo (1840-1841) fu dedicato dal B. agli Studi o Pensieri sulla storia d’Italia, divisi in tre libri, l’uno dedicato alla storia politica, l’altro a quella letteraria, la terza a quella morale. Senza di essi, egli forse non avrebbe potuto mai scrivere il Sommario. «S’io avessi—egli dice nella prefazione—anni e forze da compiere gli 11 o 12 voll. della storia giá intrapresa, avrei pure bisogno di sgomberarmene la via colle spiegazioni e collo sfogo presente. Vecchio e stanco, voglio pure sgombrarla altrui». E la sgombrò effettivamente a se stesso, perché poté, per tal modo, liberarsi «di tutte quelle discussioni di principi, di tutti quei pensieri, i quali erano venuti destandosi, moltiplicandosi ed opprimendolo in 16 anni di studi».—Tuttavia, prima di giungere al Sommario, non mancano parecchi altri tentativi, che occupano un ultimo periodo (1841-5).—Pensò in prima (1841) di scrivere una serie di biografie (Gregorio VII, Innocenzo III, san Francesco, Guglielmo di Monferrato, Enrico Dandolo, Dante, Alfieri); poi ricominciò (1841) per la terza o quarta volta la storia della guerra tra Federico Barbarossa e i comuni italiani, e ideò pure (sembra anche nel 1841) altri quattro lavori; 1) Iconografia della storia d’It.; 2) Storia del Seicento; 3) Storia delle sollevazioni e delle leghe delle cittá italiane contro gl’imperatori orientali; 4) Cenni sulle rivoluzioni delle instituzioni municipali.—Tra il 1841 e 1842 il B. conobbe l’avvocato Eduardo Brignone, e disegnò, in collaborazione con lui, un Atlante cronologico della storia d’Italia, comprendente per ogni etá di essa: 1) la storia politica e della cultura, 2) la geografia storica, 3) le genealogie delle famiglie sovrane, 4) i principali monumenti delle arti. Poi il disegno del lavoro fu ristretto, e il titolo mutato in questo: Tavole cronologiche della storia d’Italia dall’a. 476 al 1840, poste in ordine da C. B. e compilate da E. Brignone. Ma, tranne il discorso preliminare, abbozzato dal B., e due pagine di saggio, stampate dal Pomba, non se ne fece nulla. E nulla parimente si fece di una Storia compendiata d’Italia, che si sarebbe dovuta cominciare a pubblicare nel 1842, nella Biblioteca delle opere utili del Pomba, in sei volumetti, dei quali uno di biografie e uno di bibliografia (distribuito, quest’ultimo, in una prefazione intitolata a Gino Capponi e in 17 capi); nulla d’una Geografia cronologica d’Italia; nulla di alcune Tavole geografiche della storia d’Italia, ideate anche nel 1842. Vero è che allora il B. aveva per le mani le Meditazioni storiche e le Speranze d’Italia. Ciò, per altro, non gl’impediva di tentare, forse tra il 1843 e il 1844, una Storia brevissima d’Italia, destinata alle Letture di famiglia, e ripartita in 161 biografie, delle quali nessuna fu scritta (quantunque il B. riprendesse codesto disegno verso la fine del 1845); di abbozzare nell’agosto 1844 alcuni Pensieri di storia e politica, consacrati principalmente all’Italia; e di stendere nel medesimo anno vari abbozzi Sulla letteratura italiana esterna, ovvero degli italiani fuori d’Italia, che dovevano poi essere rifusi in un paragrafo del Sommario. L’anno seguente (1845) il Balbo affrontava per la prima volta la storia dell’Italia preromana, scrivendo sull’argomento una prefazione, una dedica e alcuni abbozzi, poi rifusi nel primo libro del Sommario; e tentava per ben tre volte (1. Il Mediterraneo antico e moderno, lettere a Gino Capponi; 2. L’histoire du Méditèrranée, concepita in una prefazione e cinque capi; 3. Del Mediterraneo, libri tre) di svolgere un’altra sua tesi favorita, quella del Mediterraneo «lago italiano», ponendo in carta (specialmente del terzo lavoro, del quale fu pubblicato un frammento nella Rivista contemporanea del 1854) parecchi abbozzi, qualcuno dei quali fu senza dubbio rifuso qua e lá nel Sommario. Al quale, come si vedrá, il B. si poneva toto corde nel marzo del 1846.—Per maggior copia di notizie, si veda l’utilissimo e ormai raro libro: Della vita e degli scritti del conte C. B., rimembranze di Ercole Ricotti (Firenze, Le Monnier, 1856), dal quale ho riassunto, nonché i cit. Scritti storici minori.
[5] Ventidue volte, p. e., il Balbo mutò il titolo dei Pensieri sulla storia d’Italia: 1. Pensieri rimasti da uno studio sulla st. d’It., libri III di C. B.;—2. Sulla st. d’It., pensieri di C. B.;—3. Sulla st. d’It., discorsi di C. B.;—4. Pensieri d’uno studioso sulla st. d’It.;—5. Studi di st. ital.;—6. Studi della st. d’It.;—7. Pensieri della st. d’It.;—8. Opinioni sulla st. d’It.;—9. Pensieri dedotti dalla st. d’It., libri III di C. B.;—10. Dei pregiudizi ital., discorsi di C. B.;—11. Di alcune opinioni ital., discorsi di C. B.;—12. Discorsi sulla storia (o sullo stato presente?) d’It., libri III di C. B.;—13. Pensieri ed esempi tratti dallo studio della st. d’It., libri III di C. B.;—14. Pensieri ed esempi dalla st. d’It., libri III di C. B.;—15. Di alcuni pregiudizi antichi e moderni in It., discorsi di C. B.;—16. Di alcune opinioni antiche e moderne in It., discorsi di C. B.;—17. Della politica, delle lettere e dei costumi d’It., discorsi di C. B.;—18. Dell’Italia, discorsi di C. B.;—19. Pensieri sulla st. d’It.; 20. Pensieri ed esempi dalla st. d’It.;—21. Studi sulla st. d’It.;—21 bis. Opinioni sulla st. d’It. [=al titolo 8];—22. Studi ed opinioni sulla st. d’It. «Ma nondimen, rimossa ogni menzogna, | tutta tua vision fa’ manifesta, | e lascia poi.....», Dante, Inf.—Cfr. Ricotti, op. cit., pp. 424-5.
[6] A dir vero, in un primo momento, il B. aveva dato ai «periodi storici» assai minore importanza che non dette poi, ed egli stesso aveva notato che gli storici greci e latini non s’erano mai preoccupati di razionali ripartizioni cronologiche, contenti di quelle che veniva a offrire, quasi di per se stessa, l’esposizione storica (cfr. Scritti stor. min., p. 257). Ma poi egli cangiò opinione. Il frutto dei suoi nuovi studi circa sí fatta materia fu da lui esposto in una memoria presentata nel 1841 alla R. Accademia di Torino, nelle cui Memorie (serie II, tomo III) fu pubblicata col titolo Sulla divisione e suddivisione della storia d’Italia, cenni del conte C. B. (inserita poi negli Scritti stor. min.).—Ivi, separata del tutto la storia antica dalla moderna (separazione, che piú tardi, nel Sommario, abbandonava), il B. divide la seconda in quattro periodi; 1. (suddiviso in due) Dei barbari, 476-774;—2. (suddiviso in 2) Del regno d’Italia (774-1073);—3. (suddiviso in 4) Dei comuni, 1073-1494;—4 (suddiviso in 3) Della preponderanza straniera, 1494-1814.—Che è la divisione, la quale, giá adottata presso a poco nei Pensieri sulla storia d’Italia, il B. tenne poi presente nel Sommario. Cfr. Ricotti, pp. 171-2.
[7] «Cesare Balbo, secondo narra lo stesso signor Predari [Bullett. di scienze, lett., ecc., 20 marzo 1854], ’esitò cinque o sei mesi ad accettare l’assunto: finalmente vi si decise, violentato, per cosí dire, dall’idea, con cui perseguitammo l’animo suo, di far cosa necessaria all’Italia’. Quello stupendo lavoro fu da lui cominciato e condotto a fine in poco piú di quaranta giorni. Il 18 marzo 1846, dopo un nostro colloquio, in cui accondiscese alle pertinaci istanze nostre, ci scriveva: ’La prego di non dimenticare di mandarmi in prestito un esemplare tagliato dell’Enciclopedia. vorrei farmi un’idea degli altri articoli storici. E giá, pensandovi, veggo che la gran difficoltá sará il restringermi. Mi accenni il maximum delle colonne che mi sarebbe conceduto... Ella mi ha messo il diable en corps, con quel nome d’Italia, che Ella chiama mia bella, ed io direi quella scelleratissima mia bella, per non dir altro e piú con Dante’.—Otto giorni di poi il conte Balbo aveva giá compiuti i primi tre libri. Il 2 maggio scriveva al Predari: ’Le mando il manoscritto per tôrmelo dagli occhi: se no, non finirei. È cosa, se non da rifare, certo da correggere e da pulir molto. Pazienza! non v’abbiam tempo né l’Enciclopedia né io. Vada a sua fortuna. E mi noti tutti gli errori che vi vedrá. Se siamo in tempo, li correggerò’.—’Le date di queste lettere—prosegue nel suo racconto il Predari—mostrano quindi come in quarantatré giorni avesse compiuto tutto il suo lavoro. Ogni mattina dettava a memoria per tre ore consecutive ad un nostro amanuense mandatogli a casa; un’ora dopo, ne faceva lettura con noi, accademicamente disputando; piú tardi rivedeva e correggeva; e, poiché egli tutto faceva a memoria, noi lo sollevammo in parte dalla fatica di rinvenire e verificare e collocare ai debiti luoghi e in ordine cronologico le date degli avvenimenti, sulla copia che noi facevamo poi fare del suo primo dettato’» (Ricotti, pp. 222-3).
[8] Naturalmente bisognerebbe aggiungere al computo le ristampe dell’Enciclopedia. Senonché nella quinta edizione, che ho sott’occhio (Torino, Unione tipog. editrice, 1860), del Sommario sono riprodotti, riuniti in un tutto, i soli paragrafi consacrati dal B. alla storia letteraria. La storia politica d’Italia è compilazione di altro autore.
[9] Di questa ediz. il B. «inviava al Predari un esemplare legato a lutto in pelle nera, coll’indirizzo: ‘Al Mefistofele di questa diavoleria la povera vittima Cesare Balbo’» (Ricotti, p. 225).
[10] Fin dal 1846 il B. voleva premettere al Sommario una dedica, «e varie ne ideò; cioè una al re Carlo Alberto, una a Gino Capponi, un’altra al Capponi e a Massimo d’Azeglio, una quarta agli studiosi italiani. Questa era nei termini seguenti: ’Agli studiosi italiani, desiderando che se ne giovino a scrivere la storia della patria; all’intiero popolo italiano, desiderando intanto che se ne giovi ad operarne la storia futura; questo ultimo e povero risultato dei lunghi, interrotti, compressi e respinti studi suoi, dedica, accomanda, lascia Cesare Balbo’») (Ricotti, pp. 223-4).
[11] Si veda poco piú oltre la lettera di Prospero Balbo al Le Monnier.
[12] Secondo il Ricotti, pp. 294 e 309, il Balbo avrebbe lavorato intorno a codesta appendice negli anni 1850 e 1851.
[13] Si veda p. 220 dell’ediz. Le Monnier (I, 246 della nostra), ove il Balbo per ben tre volte nomina Andrea invece di Luigi.